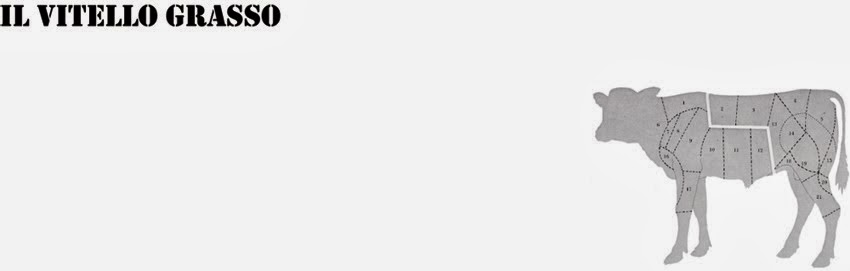Sono nato nel palazzo di fronte, un’anonima costruzione in cemento armato che svetta per cinque piani all’angolo tra le vie Alberoni e via Abbadia. Quante volte l’avevo notata, ai tempi della scuola, mentre ripetevo la lezione nella mia camera affacciata sui giardini. E quante volte mi sono affidato a lei, mentre con lo zaino in spalla andavo a scuola senza aver nemmeno finito i compiti.
Eppure solo adesso me ne sono ricordato.
La cosa curiosa è che, chiedendo a parenti e amici che vivono da sempre nel mio quartiere d’origine, ho appreso con stupore che quasi nessuno si è mai accorto di lei. Quale Madonna?, mi hanno risposto.
Dice bene Enrico Garlaschelli, nel presentare questa iniziativa (Libertà, 19.01.2012): “L’uomo moderno ha uno sguardo e un’andatura diversi: quelli frettolosi dell’automobile, quelli curiosi o indifferenti dei passanti”.
Pensare che lei è in quella nicchia, sormontata da un timpano triangolare retto da esili lesene, da oltre un secolo. Non conosco l’anno di costruzione del fabbricato del civico 57 di via Alberoni, oggetto di un sopralzo nel secondo dopoguerra. Sobrio e severo, questo palazzo residenziale riprende le modanature della più bassa e antica costruzione alla sua destra, di origine settecentesca. Esso è stato sovrapposto nel XX secolo al lato sinistro di San Savino, nel corso del tempo accerchiata da un coacervo disomogeneo di costruzioni. All’esterno, gli unici tratti oggi visibili della basilica romanica sono la facciata del XVIII secolo e le due absidi ricostruite durante i lavori di restauro di fine Ottocento, quando Ettore Martini – che abitò proprio qui - fu incaricato di spogliare il tempio dal pesante apparato decorativo di epoca barocca e di riportarlo al suo splendore originario. Pragmatico e fedele alla scuola di Viollet Le Duc («Restaurare una costruzione è ristabilirla in uno stato completo che può anche non essere mai esistito fino a quel momento»), l’ingegnere usò la mano pesante, decidendo di ricostruire alcuni dei capitelli antropomorfi e zoomorfi dei pilastri cruciformi che reggono le volte costolonate, oltre a inventarsi la scenografica scalinata di accesso alla cripta, posta sul fondo della navata centrale.
Da quando ne ho memoria, la facciata del palazzo è senza colore.
Solo intonaco grigio, ormai annerito dal traffico e dalle polveri sottili, sul quale spicca la statua in pietra - opera di discreta fattura ma convenzionale - che raffigura la Madonna con le mani congiunte nell’atto di pregare, con una mezzaluna rovesciata ai suoi piedi che allude all’Apocalisse: “Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”. Un’iconografia popolare e diffusa a partire dal XV secolo (così la rappresenta nel 1498 Jean Bourdichon nel trittico della Cattedrale di Moulins: in piedi, giovane e bella, con i capelli sciolti, che poggia sulla falce lunare; e per togliere ogni dubbio il cartiglio ai suoi piedi reca la scritta: “Sole amicta, lunam habens sub pedibus, coronata stellis”).
L’androne sottostante la statua reca un’iscrizione nel cancello in ferro battuto:
“MATER ILIIS”.
Devo ammettere di non aver studiato il latino, tuttavia posso avanzare il dubbio che alla scritta manchi una “F”:
“MATER FILIIS”.
La madre per i figli.
Oltrepassando l’androne si accede al cortile dell’oratorio, il cortile dove io e i miei amici abbiamo tirato i primi calci a un pallone, nella mitica “Bolide”. Era allora, e lo è ancora, un piazzale di cemento pieno di buche e di pozzanghere, dalla forma irregolare, vagamente trapezoidale. Sul lato sinistro, era delimitato da gabbie metalliche, contro le quali era possibile far rimbalzare la palla, mentre sul lato opposto esisteva una linea di fondo: questo almeno in teoria, perché era costantemente lavata via dalle piogge invernali. Sui lati corti, dietro alle porte pericolosamente inclinate verso l'area di rigore, c'erano le autorimesse dei condomini del caseggiato; bisognava fermarsi e sospendere la partita, quando qualcuno di loro veniva a ritirare la macchina. Quando veniva buio, il parroco mandava la perpetua a requisirci la palla: era questo l'unico modo per far terminare le partite, che andavano avanti per ore e ore, sotto il sole e sotto la pioggia, fino a che tutto non sfumava nell'oscurità.
L’oratorio era anche, allora, un punto di riferimento per tutti noi ragazzi, adolescenti e non, un vero e proprio centro di aggregazione sociale.
Erano quelli i tempi difficili - del terrorismo e della strategia della tensione - che seguirono la ricostruzione del dopoguerra, il mito del progresso e della crescita continua.
Piacenza appariva trasformata, reduce dal saccheggio della speculazione edilizia e di un’attività edilizia frenetica che produsse una periferia caotica e disordinata. In un paio di decenni la città consolidata – oltre duemila anni di storia urbana – duplicò, anzi triplicò, le sue dimensioni; il centro perse la sua tradizionale importanza produttiva e iniziò a spopolarsi. A pochi metri dalla Mater, ecco tuttavia in quegli anni erigersi il Grattacielo dei Mille, simbolo e paradigma di un boom economico ormai sgonfiatosi e dei suoi inutili eccessi, svettare tra le case umili dei maestri e dei ferrovieri, costruite senza ferro e con poco cemento. Sembra di udire l’anatema di Ginsberg nel suo celebre “Urlo” (1956): “si sono rotti la schiena a innalzare moloch al cielo!”
Allora in via Alberoni c’erano ben due fruttivendoli, a distanza di trenta metri uno dall’altro. Poi c’era un rivenditore di elettrodomestici, un fotografo, la parrucchiera, il negozio di fiori, una latteria, una merceria, le tre sorelle che vendevano il pane, così devote alla Madonna, l’alimentari e il Bar Sport.
Il Bar Sport c’è anche adesso. Intorno, resiste solo la parrucchiera, il fotografo ha chiuso da un pezzo. Adesso ci sono due o tre kebab, un take away pakistano, un centro massaggi con arredamento minimal-giapponese, un callcenter con transfer money, una lavanderia a gettone, una copisteria e qualche vetrina sfitta.
E’ la città tradizionale che implode e si smaterializza sotto i nostri occhi, inglobata dall’attuale indiscriminata urbanizzazione del territorio agricolo - la "geography of nowhere" descritta da Kunstler, scrittore e osservatore di un paesaggio occidentale in costante evoluzione. Inizialmente mosso dal legittimo desiderio di accedere a una casa di proprietà, di garantire alla propria famiglia la privacy, di stabilire un più diretto rapporto con la natura, l’abitante postmoderno soffre oggi della congestione del traffico e dell’inquinamento, ma anche di un crescente senso di isolamento, che è certa¬mente reso più acuto dalla mancanza di spazi pubblici degni di questo nome. E la scomparsa dello spazio pubblico avviene a vantaggio di una progressiva privatizzazione del territorio, e in ultima analisi della trasformazione del cittadino in consumatore. I luoghi di socializzazione tipici della contemporaneità e del sistema globale delle reti sono infatti i grandi contenitori, i Centri Commerciali e le Multisala cinematografiche, ovvero quelli che paradossalmente Augè – l’etnologo della solitudine – aveva definito i “non-luoghi”: parallelepipedi privi di significato e senza riferimenti al loro contenuto, accostati uno all’altro lungo strade a scorrimento rapido, ma ormai affermatisi come punti di ritrovo d’elezione dagli adolescenti.
L’oratorio per fortuna c’è ancora.
Possiamo considerarlo uno degli ultimi avamposti della città, la città così come storicamente l’abbiamo sempre intesa, ovvero uno dei rituali antichi che la modernità non riesce a cancellare ma che pone sullo sfondo, indicatori del tempo che passa e sopravvive.
E anche oggi è uno straordinario luogo di incontro e di contaminazione. Un crocevia di culture e di religioni.
Luogo di inclusione, non di esclusione.
Oltre a esprimere la devozione e la gratitudine dei fedeli, tradizione vuole che la Madonna del mistadello indicasse ai pellegrini stanchi – i moderni migranti - che in quel luogo avrebbero trovato cibo e accoglienza.
Al pomeriggio, qui vengono a giocare ragazzi dell’Ecuador e del Burkina Faso, della Macedonia e dell’Algeria, dell’Albania e del Marocco: cattolici, ortodossi e musulmani.
Tutti figli della stessa madre.