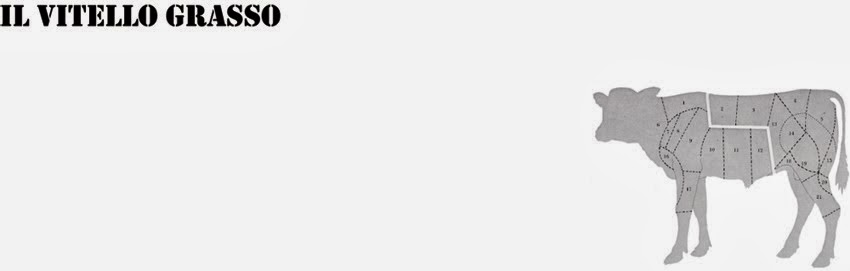mercoledì 26 febbraio 2014
#FIDUCIA
Una cosa la diciamo agli amici grillini: lo decideremo noi, se abbiamo speso bene o no i famosi due euro.
LA MAPPA DEGLI ARTISTI PREFERITI NEGLI STATES
Nessuna sorpresa per Kurt Vile in Oregon, Portland si conferma la città più cool, e per Sufjan Stevens nel nativo Illinois (al quale ha dedicato anche un disco), ci sta pure James Blake per i sofosticati newyorchesi.
Ma i Grateful Dead in New Hampshire?
Ma i Grateful Dead in New Hampshire?
IL PAGELLONE DI SANREMO 2014
Vi siete ripresi dalla sbornia sanremese? Ecco l'immancabile pagellone
di PiacenzaSera firmato da Giovanni Battista Menzani, che ha seguito per
noi (twittando con moderazione) la kermesse canora.
Il pagellone di Sanremo 2014
di Giovanni Battista Menzani (@GiovanniMenzani)
Arisa: 6,5
Con il passare dei giorni il look migliora e la platea di twitter si riprende dallo shock delle tette sfoggiate al debutto. “Controvento” è il pezzo perfetto per il Festival, is the new “Mentre il mondo cade a pezzi”. “Lentamente il primo che passa” ha un testo di Cristina Donà, ma l’incedere ricorda troppo Ravel. Perfetto per la soundtrack di un cartone della Disney
Cristiano De André: 7,5
La dimostrazione che la formula del ballottaggio tra le due canzoni è deleteria e abbassa la qualità del lotto che in finale si disputa la vittoria.
“Invisibili”, premio Mia Martini, è infatti la canzone più bella di tutto il Festival, struggente omaggio a Genova (anche se spuntano accuse di plagio a James Taylor).
“Il cielo e' vuoto” (“E Dio che si dimentica di fare il suo lavoro”) è più debole, ma sul voto incide anche la commovente interpretazione di “Verranno a chiederti del nostro amore” (anche se qui vince facile).
Sembra rinato, ed è una bella notizia.
Giusy Ferreri: 5
Sentita solo a sprazzi: sulla fiducia.
Frankie Hi-Nrg: 5
La sensazione e' che l'altro brano (Molto a là Jovanotti), “Un uomo è vivo”, fosse il migliore, malgrado quel verso “C’è istante in cui ogni uomo diventa sua madre” che urla ancora vendetta ed è l’erede naturale di “Fare l’amore in tutti i laghi”.
“Pedala” - che i media italiani hanno dedicato immediatamente a Renzi, “hai voluto la biciletta?”- è poco originale ma è perfetta per il Primo Maggio, già le vediamo sventolare tutte quelle bandiere coi quattro mori.
Rafael Gualazzi: 5,5
In finale il microfono si rifiuta di funzionare, malignano sul web, che si scaglia sul look demenziale di Bloody Beetroots (qualcuno maligna che dovendo sul palco con Gualazzi ha preferito rimanere anonimo).
Sarà perché in casa e' piaciuto a tutti, ma non ce la sentiamo di stroncare “Liberi o no”, malgrado un testo messo insieme un po’ alla cazzo: almeno ha il merito di svegliare la platea dal suo torpore.
Noemi: 5,5
Pesa sul giudizio l'imbarazzante look della serata di giovedì, quando si e' presentata sul palco dell'Ariston con un'acconciatura da calciatore e un attaccapanni infilzato nel collo.
Ha il pezzo più radiofonico, “Bagnati dal sole”, e la sua interpretazione ci piace, anche se sembra sempre un po’ insicura (e sì che ne ha fatta di strada).
Giuliano Palma: 4,5
Sarà perché il vintage rischia di diventare stucchevole, alla lunga.
Il pezzo co-firmato da Nina Zilli, “Cosi lontano”, e' proprio un compitino e lui non appare in gran forma.
Perturbazione: 6
I rappresentanti della cosiddetta pattuglia indie non sprecano l’occasione del grande pubblico con un pezzo leggero, leggerissimo, “L’unica”, persino troppo incensato sul web. “L’Italia vista al bar è invece un inutile elenco di luoghi comuni (“e se la gente si incazza/scenderemo in piazza”).
Ci aspettavamo di più, comunque. Se pensiamo a Rice e Wainwright…
Francesco Renga: 5,5
Partiva super favorito, ha perso e proprio per questo l'Apparato lo elegge icona del progressismo. Maybe, il duetto con Kekko ha avviato il suo tracollo.
Ron: 5
“Sing in the rain” è un impalpabile folk stile Mumford&Sons, e in finale è pure stonato.
L’altro pezzo neanche ce lo ricordiamo.
Forse aveva il compito di rappresentare il cantautorato, come accadde a Finardi, Vecchioni e altri.
Fallisce.
Renzo Rubino: 6
E’ talmente agitato che a noi viene il dubbio che l'audio non sia sincronizzato e che la regia stia mandando in onda un altro pezzo, ovvero che lui in realtà stia eseguendo una cover dei Black Sabbath.
“Ora” è una canzone ben costruita, ma la sua interpretazione è sopra le righe.
Antonella Ruggiero: 6
La scongelano per Sanremo.
Su twitter si sprecano ironie e sarcasmo per l’inquietante somiglianza con Robert Smith dei Cure, il Sean Penn di “This must be the place” ed Edward mani di forbice”.
Look dark a parte, va detto che i suoi due brani sono raffinati e lei è un’interprete di classe.
“Da lontano”, con il suo ritornello che pare in lingua araba, andrebbe sottotitolata, altro che i versi da bullo da banlieu di Stromae.
Francesco Sarcina: 3
Se il suo talento fosse paragonabile all'autostima e all’egocentrismo - titolo del nuovo album: “Io” - questo sarebbe un fuoriclasse.
Invece strilla in modo quasi fastidioso, facendo addirittura rimpiangere i Moda'.
Riccardo Sinigallia: 6,5
L’ex Tiromancino è escluso per i motivi che sappiamo. Peccato, non demeritava.
Da ricordare la sua versione del classico di Lolli, con Paola Turci e Marina Rey.
Il pagellone di Sanremo 2014
di Giovanni Battista Menzani (@GiovanniMenzani)
Arisa: 6,5
Con il passare dei giorni il look migliora e la platea di twitter si riprende dallo shock delle tette sfoggiate al debutto. “Controvento” è il pezzo perfetto per il Festival, is the new “Mentre il mondo cade a pezzi”. “Lentamente il primo che passa” ha un testo di Cristina Donà, ma l’incedere ricorda troppo Ravel. Perfetto per la soundtrack di un cartone della Disney
Cristiano De André: 7,5
La dimostrazione che la formula del ballottaggio tra le due canzoni è deleteria e abbassa la qualità del lotto che in finale si disputa la vittoria.
“Invisibili”, premio Mia Martini, è infatti la canzone più bella di tutto il Festival, struggente omaggio a Genova (anche se spuntano accuse di plagio a James Taylor).
“Il cielo e' vuoto” (“E Dio che si dimentica di fare il suo lavoro”) è più debole, ma sul voto incide anche la commovente interpretazione di “Verranno a chiederti del nostro amore” (anche se qui vince facile).
Sembra rinato, ed è una bella notizia.
Giusy Ferreri: 5
Sentita solo a sprazzi: sulla fiducia.
Frankie Hi-Nrg: 5
La sensazione e' che l'altro brano (Molto a là Jovanotti), “Un uomo è vivo”, fosse il migliore, malgrado quel verso “C’è istante in cui ogni uomo diventa sua madre” che urla ancora vendetta ed è l’erede naturale di “Fare l’amore in tutti i laghi”.
“Pedala” - che i media italiani hanno dedicato immediatamente a Renzi, “hai voluto la biciletta?”- è poco originale ma è perfetta per il Primo Maggio, già le vediamo sventolare tutte quelle bandiere coi quattro mori.
Rafael Gualazzi: 5,5
In finale il microfono si rifiuta di funzionare, malignano sul web, che si scaglia sul look demenziale di Bloody Beetroots (qualcuno maligna che dovendo sul palco con Gualazzi ha preferito rimanere anonimo).
Sarà perché in casa e' piaciuto a tutti, ma non ce la sentiamo di stroncare “Liberi o no”, malgrado un testo messo insieme un po’ alla cazzo: almeno ha il merito di svegliare la platea dal suo torpore.
Noemi: 5,5
Pesa sul giudizio l'imbarazzante look della serata di giovedì, quando si e' presentata sul palco dell'Ariston con un'acconciatura da calciatore e un attaccapanni infilzato nel collo.
Ha il pezzo più radiofonico, “Bagnati dal sole”, e la sua interpretazione ci piace, anche se sembra sempre un po’ insicura (e sì che ne ha fatta di strada).
Giuliano Palma: 4,5
Sarà perché il vintage rischia di diventare stucchevole, alla lunga.
Il pezzo co-firmato da Nina Zilli, “Cosi lontano”, e' proprio un compitino e lui non appare in gran forma.
Perturbazione: 6
I rappresentanti della cosiddetta pattuglia indie non sprecano l’occasione del grande pubblico con un pezzo leggero, leggerissimo, “L’unica”, persino troppo incensato sul web. “L’Italia vista al bar è invece un inutile elenco di luoghi comuni (“e se la gente si incazza/scenderemo in piazza”).
Ci aspettavamo di più, comunque. Se pensiamo a Rice e Wainwright…
Francesco Renga: 5,5
Partiva super favorito, ha perso e proprio per questo l'Apparato lo elegge icona del progressismo. Maybe, il duetto con Kekko ha avviato il suo tracollo.
Ron: 5
“Sing in the rain” è un impalpabile folk stile Mumford&Sons, e in finale è pure stonato.
L’altro pezzo neanche ce lo ricordiamo.
Forse aveva il compito di rappresentare il cantautorato, come accadde a Finardi, Vecchioni e altri.
Fallisce.
Renzo Rubino: 6
E’ talmente agitato che a noi viene il dubbio che l'audio non sia sincronizzato e che la regia stia mandando in onda un altro pezzo, ovvero che lui in realtà stia eseguendo una cover dei Black Sabbath.
“Ora” è una canzone ben costruita, ma la sua interpretazione è sopra le righe.
Antonella Ruggiero: 6
La scongelano per Sanremo.
Su twitter si sprecano ironie e sarcasmo per l’inquietante somiglianza con Robert Smith dei Cure, il Sean Penn di “This must be the place” ed Edward mani di forbice”.
Look dark a parte, va detto che i suoi due brani sono raffinati e lei è un’interprete di classe.
“Da lontano”, con il suo ritornello che pare in lingua araba, andrebbe sottotitolata, altro che i versi da bullo da banlieu di Stromae.
Francesco Sarcina: 3
Se il suo talento fosse paragonabile all'autostima e all’egocentrismo - titolo del nuovo album: “Io” - questo sarebbe un fuoriclasse.
Invece strilla in modo quasi fastidioso, facendo addirittura rimpiangere i Moda'.
Riccardo Sinigallia: 6,5
L’ex Tiromancino è escluso per i motivi che sappiamo. Peccato, non demeritava.
Da ricordare la sua versione del classico di Lolli, con Paola Turci e Marina Rey.
BENTORNATO, CROZ
“Croz” è il suo soprannome storico. La scelta del titolo si deve a un
gioco iniziato tanto tempo fa, nel 1971. Il suo primo album da solista
si intitolava infatti “If I could only remember my name” (Se solo
potessi ricordare il mio nome), grande disco, e il suo secondo invece,
nel 1989, “Yes, I can” (Sì che posso). Quindi, il terzo: “Croz”.
Lui, David Crosby, è un grande della musica americana, uno dei maestri
della West Coast – prima nei Byrds poi nel celebre trio con Stills &
Nash, che arruolarono successivamente Neil Young – degli anni Sessanta e
Settanta.
Croz torna inaspettatamente, dopo oltre un ventennio di silenzio.
All’età di settantatre, con il coraggio di ieri. Forse per via del nuovo
fegato, recentemente trapiantato (una vita di bagordi, il nostro Croz).
E non delude le aspettative.
L’iniziale “What’s broken” è una raffinata ballata jazzy costruita attorno la suadente chitarra di Mark Knopfler. Come “Slice of time”, ricorda le atmosfere - recenti - di Iron&Wine e Deastroyer. Le successive “Time I have” e “Holding not to nothing” (con la tromba di Wynton Marsalis) hanno un tono più intimista e crepuscolare, così pure “Morning falling”. Stesso mood per “If she called”, anzi più drammatica: scritta osservando, dalla finestra di un albergo tedesco, alcune prostitute allineate ai bordi di una strada. L’elettrica “The clearing”, con una bella coda di chitarre, la radiofonica (!) “Radio” – con un delizioso ritornello pop - e “Dangerous night” hanno un eco decisamente Seventies, ma del lotto nostalgico il brano che più piace è “Set the baggage down”, psichedelica e amara. Un pezzo che molte delle bands della cosiddetta scena neopsichedelica gli invidieranno non poco. Bentornato, Croz.
L’iniziale “What’s broken” è una raffinata ballata jazzy costruita attorno la suadente chitarra di Mark Knopfler. Come “Slice of time”, ricorda le atmosfere - recenti - di Iron&Wine e Deastroyer. Le successive “Time I have” e “Holding not to nothing” (con la tromba di Wynton Marsalis) hanno un tono più intimista e crepuscolare, così pure “Morning falling”. Stesso mood per “If she called”, anzi più drammatica: scritta osservando, dalla finestra di un albergo tedesco, alcune prostitute allineate ai bordi di una strada. L’elettrica “The clearing”, con una bella coda di chitarre, la radiofonica (!) “Radio” – con un delizioso ritornello pop - e “Dangerous night” hanno un eco decisamente Seventies, ma del lotto nostalgico il brano che più piace è “Set the baggage down”, psichedelica e amara. Un pezzo che molte delle bands della cosiddetta scena neopsichedelica gli invidieranno non poco. Bentornato, Croz.
MONDAY MORNING
L’idea di questo album - un inno a nuove grandi speranze come suggerisce
il titolo, “High hopes” – nasce dall’ingresso (temporaneo) di Tom
Morello nella E Street Band, in sostituzione di Van Zandt, durante la
recente tournee australiana. La collaborazione con l’ex chitarrista dei
Rage Against the Machine si è presto trasformata in idillio, tanto che
si è pensato di realizzare un album infarcito di cover, outtakes e
vecchi brani del Boss rivisitati con la nuova formazione.
“High Hopes” pare quasi un disco live.
La titletrack è una rivisitazione – in un tripudio di fiati - di un
vecchio brano degli Havalinas di Tim Scott McConnell: “Monday morning” è
un incipit notevole, e il verso “Gimme love/gimme peace” è un amarcord
della stagione del florer power. La successiva “Harry’s Place” ha una
base elettronica e un’anonimo andamento funk: forse serviva un
arrangiamento più sobrio, meno ridondante. Segue una nuova versione di
“American skin”, inutile qui ripetere dell’episodio di violenza razzista
da cui nasce la canzone, tra le più belle della sua produzione recente.
Ecco le cover: “Just like fire would” è un brano degli australiani
Saints al quale se togli la ruvidezza e l’immediatezza del punk resta
poco. Ricorda Mellencamp.
Onesto e sano rock, si dirà, ma da uno come il Boss si può pretendere di più: la scrittura dei pezzi è spesso elementare e non brilla certamente per originalità e per urgenza. “Down in the hole”, ad esempio, è affascinante, ma troppo simile a “I’m on fire”. Tuttavia il nostro non si risparmia, as usually. “Heaven’s wall” è un gospel celtico nel mezzo del quale Morello entra con la delicatezza di un elefante in una cristalleria, e apre la sequenza folk che sta nel cuore dell’opera, completato da “Frankie fell in love”, “This is your sword” e “Hunter of invisible game”.
Il finale non ci aiuta a emettere un verdetto definitivo: la versione elettrica di “The ghost of Tom Joad” tradisce la disperazione dell’originale, con un Morello ancora sopra le righe e un finale pomposo e urticante, così poco Steinbeck. Nella speciale classifica delle cover peggio riuscite di sempre, è appena un gradino sopra “Knockin’ on heaven’s door” dei Gun’s Roses. “The wall” è una ballata acustica dedicata a un marine (“Cigarettes and a bottle of beer/This poem I wrote for you/This black stone and these hard tears/Are all I've got left now of you/I remember you in your Marine uniform laughing/Laughing that you're shipping out probably/I read Robert McNamara says he's sorry”) e per ultimi i Suicide, vecchia passione. Notevoli i testi, ancora una volta dalla parte di chi sta al margine: “Questa è la musica che ho sempre sentito il bisogno di pubblicare. Dai gangster di “Harry’s Place”, i compagni di stanza di “Frankie Fell In Love”, (ombre di me e Steve che facciamo casino nell’appartamento di Asbury Park), i viaggiatori nella terra desolata di “Hunter Of Invisible Game”, fino ai soldati e i visitatori di “The Wall”, sentivo che si meritassero tutti una casa e un ascolto.”
Onesto e sano rock, si dirà, ma da uno come il Boss si può pretendere di più: la scrittura dei pezzi è spesso elementare e non brilla certamente per originalità e per urgenza. “Down in the hole”, ad esempio, è affascinante, ma troppo simile a “I’m on fire”. Tuttavia il nostro non si risparmia, as usually. “Heaven’s wall” è un gospel celtico nel mezzo del quale Morello entra con la delicatezza di un elefante in una cristalleria, e apre la sequenza folk che sta nel cuore dell’opera, completato da “Frankie fell in love”, “This is your sword” e “Hunter of invisible game”.
Il finale non ci aiuta a emettere un verdetto definitivo: la versione elettrica di “The ghost of Tom Joad” tradisce la disperazione dell’originale, con un Morello ancora sopra le righe e un finale pomposo e urticante, così poco Steinbeck. Nella speciale classifica delle cover peggio riuscite di sempre, è appena un gradino sopra “Knockin’ on heaven’s door” dei Gun’s Roses. “The wall” è una ballata acustica dedicata a un marine (“Cigarettes and a bottle of beer/This poem I wrote for you/This black stone and these hard tears/Are all I've got left now of you/I remember you in your Marine uniform laughing/Laughing that you're shipping out probably/I read Robert McNamara says he's sorry”) e per ultimi i Suicide, vecchia passione. Notevoli i testi, ancora una volta dalla parte di chi sta al margine: “Questa è la musica che ho sempre sentito il bisogno di pubblicare. Dai gangster di “Harry’s Place”, i compagni di stanza di “Frankie Fell In Love”, (ombre di me e Steve che facciamo casino nell’appartamento di Asbury Park), i viaggiatori nella terra desolata di “Hunter Of Invisible Game”, fino ai soldati e i visitatori di “The Wall”, sentivo che si meritassero tutti una casa e un ascolto.”
mercoledì 5 febbraio 2014
TOH, ECCO IL SAUNDERS ITALIANO (TROPPO, SAUNDERS...)
Toh, ecco il George Saunders italiano. Per
scherzo? No, seriamente. Quasi. Perché è vero che Menzani sconta il
doppio handicap di essere 1) un “quasi esordiente” (all’attivo solo un
paio di saggi sull’architettura contemporanea e un Dizionario biografico fantastico dei piacentini illustri)
e soprattutto 2) un “quasi scrittore”, nel senso che di mestiere
fa(ceva?) l’architetto. E però ce ne fossero di quasi-scrittori come
lui. Che quasi-scrivendo qua e là tirano fuori dal cassetto
questi tredici racconti che sono delle piccole chicche. Per lo meno per
chi ama le ambientazioni “quasi-saundersiane”. O giù di lì.
Sciolto ogni dubbio, quel che è certo è che in queste pagine si viene accompagnati con passo lieve in uno scenario che di lieve ha ben poco.
Baraccopoli post moderne e posticce, periferie sub-urbane anonime e
desolante, dove si muovono personaggi strani in situazioni ambigue.
Aspiranti partecipanti ad improbabili show televisivi ammassati in
villaggi prefabbricati in attesa della chiamata in onda; cinici
poliziotti addetti al controllo delle spese personali sulla base delle
indicazioni fornite dal Ministero dei consumi; uomini costretti a
travestirsi da animali per allietare osceni visitatori di un outlet;
pubblico in estasi in un Multiplex per assistere ad esecuzioni capitali.
C’è insomma tutta la schizofrenia
distopica che si ritrova appunto dei racconti di Saunders, dove
un’umanità andata da tempo alla deriva è costretta a barcamenarsi tra i
bassifondi di un impero dove il consumismo e l’avidità hanno vinto da un
pezzo. E il resto sono macerie. In questo caso siamo
naturalmente in Italia. Ma è una Bassa Padana appena abbozzata, che
potrebbe in realtà essere ovunque. Perché il paesaggio non è che una
misera quinta dietro la quale si muovono gli inconsapevoli attori.
Uomini e donne perduti, ignavi, rassegnati, sconfitti. E se qua e là
trapela un tocco di ironia a rendere surreale alcuni passaggi, il tutto
resta abbondantemente connotato da un forte senso di smarrimento e
perdizione.
Che si fa sottile angoscia nei racconti più realistici. Quelli nei quali l’autore abbandona il surreale e si concentra su scene di vita quotidiana. Di nuovo, come Saunders nel suo ultimo lavoro (Dieci dicembre, leggi recensione); anche se qui il riferimento più esplicito è più che altro a Raymond Carver. Menzani mette in scena quadretti di apparente banalità nei quali, come nella migliore tradizione del minimalista americano, a conferire tensione alla narrazione è più il non detto che quello che viene esplicitato. Quella sensazione che qualcosa di brutto sia appena successo o, peggio, stia per succedere. Ma siccome non è che basti darsi un tono minimal per raggiungere questi effetti, il fatto che il giovane Menzani riesca ad avvicinarsi senza apparente sforzo ai suoi modelli è già una vittoria da salutare brindando.
Semmai, se proprio dovessimo rimproverargli qualcosa (ma perché poi?), sarebbe proprio questo suo rimando così esplicito ad altri autori. L’effetto è un po’ come quello di sentire una cover band, che esegue in modo impeccabile brani di altri in attesa del coraggio necessario per scriverne di propri. Ma un quasi-autore così prima o poi lo sforna di sicuro un album tutto suo.
Che si fa sottile angoscia nei racconti più realistici. Quelli nei quali l’autore abbandona il surreale e si concentra su scene di vita quotidiana. Di nuovo, come Saunders nel suo ultimo lavoro (Dieci dicembre, leggi recensione); anche se qui il riferimento più esplicito è più che altro a Raymond Carver. Menzani mette in scena quadretti di apparente banalità nei quali, come nella migliore tradizione del minimalista americano, a conferire tensione alla narrazione è più il non detto che quello che viene esplicitato. Quella sensazione che qualcosa di brutto sia appena successo o, peggio, stia per succedere. Ma siccome non è che basti darsi un tono minimal per raggiungere questi effetti, il fatto che il giovane Menzani riesca ad avvicinarsi senza apparente sforzo ai suoi modelli è già una vittoria da salutare brindando.
Semmai, se proprio dovessimo rimproverargli qualcosa (ma perché poi?), sarebbe proprio questo suo rimando così esplicito ad altri autori. L’effetto è un po’ come quello di sentire una cover band, che esegue in modo impeccabile brani di altri in attesa del coraggio necessario per scriverne di propri. Ma un quasi-autore così prima o poi lo sforna di sicuro un album tutto suo.
GRANDI SPERANZE (RIPOSTE MALE)
L’idea di questo album - un inno a nuove grandi speranze come suggerisce
il titolo, “High hopes” – nasce dall’ingresso (temporaneo) di Tom
Morello nella E Street Band, in sostituzione di Van Zandt, durante la
recente tournee australiana. La collaborazione con l’ex chitarrista dei
Rage Against the Machine si è presto trasformata in idillio, tanto che
si è pensato di realizzare un album infarcito di cover, outtakes e
vecchi brani del Boss rivisitati con la nuova formazione.
“High Hopes” pare quasi un disco live. La titletrack è una rivisitazione – in un tripudio di fiati - di un vecchio brano degli Havalinas di Tim Scott McConnell: “Monday morning” è un incipit notevole, e il verso “Gimme love/gimme peace” è un amarcord della stagione del florer power. La successiva “Harry’s Place” ha una base elettronica e un’anonimo andamento funk: forse serviva un arrangiamento più sobrio, meno ridondante. Segue una nuova versione di “American skin”, inutile qui ripetere dell’episodio di violenza razzista da cui nasce la canzone, tra le più belle della sua produzione recente. Ecco le cover: “Just like fire would” è un brano degli australiani Saints al quale se togli la ruvidezza e l’immediatezza del punk resta poco. Ricorda Mellencamp.
Onesto e sano rock, si dirà, ma da uno come il Boss si può pretendere di più: la scrittura dei pezzi è spesso elementare e non brilla certamente per originalità e per urgenza. “Down in the hole”, ad esempio, è affascinante, ma troppo simile a “I’m on fire”. Tuttavia il nostro non si risparmia, as usually. “Heaven’s wall” è un gospel celtico nel mezzo del quale Morello entra con la delicatezza di un elefante in una cristalleria, e apre la sequenza folk che sta nel cuore dell’opera, completato da “Frankie fell in love”, “This is your sword” e “Hunter of invisible game”.
Il finale non ci aiuta a emettere un verdetto definitivo: la versione elettrica di “The ghost of Tom Joad” tradisce la disperazione dell’originale, con un Morello ancora sopra le righe e un finale pomposo e urticante, così poco Steinbeck. Nella speciale classifica delle cover peggio riuscite di sempre, è appena un gradino sopra “Knockin’ on heaven’s door” dei Gun’s Roses. “The wall” è una ballata acustica dedicata a un marine (“Cigarettes and a bottle of beer/This poem I wrote for you/This black stone and these hard tears/Are all I've got left now of you/I remember you in your Marine uniform laughing/Laughing that you're shipping out probably/I read Robert McNamara says he's sorry”) e per ultimi i Suicide, vecchia passione. Notevoli i testi, ancora una volta dalla parte di chi sta al margine: “Questa è la musica che ho sempre sentito il bisogno di pubblicare. Dai gangster di “Harry’s Place”, i compagni di stanza di “Frankie Fell In Love”, (ombre di me e Steve che facciamo casino nell’appartamento di Asbury Park), i viaggiatori nella terra desolata di “Hunter Of Invisible Game”, fino ai soldati e i visitatori di “The Wall”, sentivo che si meritassero tutti una casa e un ascolto.”
“High Hopes” pare quasi un disco live. La titletrack è una rivisitazione – in un tripudio di fiati - di un vecchio brano degli Havalinas di Tim Scott McConnell: “Monday morning” è un incipit notevole, e il verso “Gimme love/gimme peace” è un amarcord della stagione del florer power. La successiva “Harry’s Place” ha una base elettronica e un’anonimo andamento funk: forse serviva un arrangiamento più sobrio, meno ridondante. Segue una nuova versione di “American skin”, inutile qui ripetere dell’episodio di violenza razzista da cui nasce la canzone, tra le più belle della sua produzione recente. Ecco le cover: “Just like fire would” è un brano degli australiani Saints al quale se togli la ruvidezza e l’immediatezza del punk resta poco. Ricorda Mellencamp.
Onesto e sano rock, si dirà, ma da uno come il Boss si può pretendere di più: la scrittura dei pezzi è spesso elementare e non brilla certamente per originalità e per urgenza. “Down in the hole”, ad esempio, è affascinante, ma troppo simile a “I’m on fire”. Tuttavia il nostro non si risparmia, as usually. “Heaven’s wall” è un gospel celtico nel mezzo del quale Morello entra con la delicatezza di un elefante in una cristalleria, e apre la sequenza folk che sta nel cuore dell’opera, completato da “Frankie fell in love”, “This is your sword” e “Hunter of invisible game”.
Il finale non ci aiuta a emettere un verdetto definitivo: la versione elettrica di “The ghost of Tom Joad” tradisce la disperazione dell’originale, con un Morello ancora sopra le righe e un finale pomposo e urticante, così poco Steinbeck. Nella speciale classifica delle cover peggio riuscite di sempre, è appena un gradino sopra “Knockin’ on heaven’s door” dei Gun’s Roses. “The wall” è una ballata acustica dedicata a un marine (“Cigarettes and a bottle of beer/This poem I wrote for you/This black stone and these hard tears/Are all I've got left now of you/I remember you in your Marine uniform laughing/Laughing that you're shipping out probably/I read Robert McNamara says he's sorry”) e per ultimi i Suicide, vecchia passione. Notevoli i testi, ancora una volta dalla parte di chi sta al margine: “Questa è la musica che ho sempre sentito il bisogno di pubblicare. Dai gangster di “Harry’s Place”, i compagni di stanza di “Frankie Fell In Love”, (ombre di me e Steve che facciamo casino nell’appartamento di Asbury Park), i viaggiatori nella terra desolata di “Hunter Of Invisible Game”, fino ai soldati e i visitatori di “The Wall”, sentivo che si meritassero tutti una casa e un ascolto.”
LA RECENSIONE SU IJE.ZINE
L’odore della Plastica Bruciata è una raccolta di racconti scritta da Giovanni Battista Menzani ed edita da
LiberAria. Racconti crudi, spietati, tristemente ironici, che mettono in
evidenza tutto l’egoismo e il cinismo della nostra società, in una deriva di
valori che ci spinge sempre più verso il basso e ci costringe a rotolarci nel
fango.
Non è un caso che il libro si apra con Con
passo sicuro e costante andatura, storia di un povero malcapitato che
per sbarcare il lunario si trova costretto a lavorare come asino in un outlet,
caricandosi sul groppone i pacchi della “gentile” clientela che dal momento che
paga ha il diritto di sottoporlo a umiliazioni e vessazioni di ogni sorta,
fingendo di dimenticare che sotto quel costume si nasconde un essere umano.
Il racconto in chiusura L’odore della plastica bruciata (che dà il titolo alla raccolta) affronta un tema molto delicato: la pena di morte. Qui ci vengono presentati alcuni assassini condannati alla sedia elettrica, la cui esecuzione capitale viene eseguita in diretta in un cinema multisala affollato di persone. Persone talmente assuefatte alla spettacolarizzazione del lutto, da gustarselo assieme ai loro figli con un pacco di popcorn tra le mani, in un parossismo di disumanità. In mezzo ci sono storie di lavori precari, di mariti rovinati dalle ex mogli, di brutture, di freddezza, di vite in bilico. Una cosa su tutto: l’indifferenza, che il più delle volte rende l’uomo peggio della bestia. Giovanni Battista Menzani affronta questi argomenti in modo egregio, senza mai scadere nella retorica, denotando una sensibilità e una profondità d’animo fuori dal comune. Ma la cosa a mio avviso più importante e che rende questi racconti credibili, è che Menzani non indugia in inutili personalismi, non offre soluzioni stereotipate, il suo è solo un preciso punto d’osservazione frutto di un immaginario compatto. E per riuscire a mettere insieme tutto questo utilizza un’ironia sottile e una scrittura semplice, senza sbavature. Semplice nel senso che anziché ricorrere a effetti speciali o colpi di scena, ha il pregio di mostrare le cose per quello che sono. L’atmosfera rarefatta che si respira durante la lettura trasmette un senso di claustrofobico.
E alla fine resta dentro un sapore acre.
Acre come la plastica bruciata.
Il racconto in chiusura L’odore della plastica bruciata (che dà il titolo alla raccolta) affronta un tema molto delicato: la pena di morte. Qui ci vengono presentati alcuni assassini condannati alla sedia elettrica, la cui esecuzione capitale viene eseguita in diretta in un cinema multisala affollato di persone. Persone talmente assuefatte alla spettacolarizzazione del lutto, da gustarselo assieme ai loro figli con un pacco di popcorn tra le mani, in un parossismo di disumanità. In mezzo ci sono storie di lavori precari, di mariti rovinati dalle ex mogli, di brutture, di freddezza, di vite in bilico. Una cosa su tutto: l’indifferenza, che il più delle volte rende l’uomo peggio della bestia. Giovanni Battista Menzani affronta questi argomenti in modo egregio, senza mai scadere nella retorica, denotando una sensibilità e una profondità d’animo fuori dal comune. Ma la cosa a mio avviso più importante e che rende questi racconti credibili, è che Menzani non indugia in inutili personalismi, non offre soluzioni stereotipate, il suo è solo un preciso punto d’osservazione frutto di un immaginario compatto. E per riuscire a mettere insieme tutto questo utilizza un’ironia sottile e una scrittura semplice, senza sbavature. Semplice nel senso che anziché ricorrere a effetti speciali o colpi di scena, ha il pregio di mostrare le cose per quello che sono. L’atmosfera rarefatta che si respira durante la lettura trasmette un senso di claustrofobico.
E alla fine resta dentro un sapore acre.
Acre come la plastica bruciata.
(Grazie a Francesco Rago)
Iscriviti a:
Post (Atom)