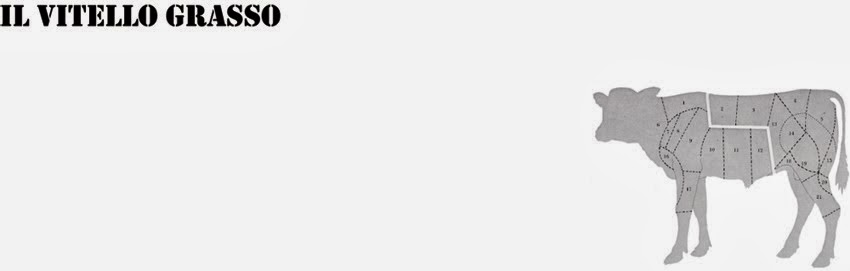domenica 27 maggio 2012
DECEMBERISTS, "We all raise our voices to the air" (2012)
Il lettore più attento potrà lamentarsi: ancora i Decemberists.
Vero, seguiamo con attenzione le mosse della band di Portland, e l’ennesima occasione per parlare di loro è l’uscita del loro primo live, un cd doppio – addirittura triplo nell’edizione in vinile.
La recente riscoperta della tradizione e delle radici folk si riflette in questa torrenziale (126 minuti!) raccolta di brani incisi in ben 12 diverse performance tenute da Colin Meloy e soci dal mese di aprile ad agosto del 2011, durante il Popes of Pendarvia World Tour, comprese le ultime due date nella loro città natale (alcuni episodi si avvalgono di una sezione fiati aggiuntiva).
Tale generosità permette loro di farsi perdonare qualche piccola sbavatura.
La raccolta si caratterizza per una sapiente alternanza tra struggenti e languide ballate e pezzi più ritmati e festaioli, con grande profusione di mandolini, fise e armoniche a bocca, e si distingue per la sua immediatezza e il suo potente impatto emotivo.
La track-list ripercorre una breve ma intensa carriera, se album e una mancita di EP (32 solo nel corso del 2011): da Oceanside (dall’EP di debutto, Five Songs, 2001) alle storie epiche di soldati e marinai tratte dal celebrato Picaresque (2005: The Infanta, The Bagman’s Gambit, We Both Go Down Together, The Mariner's Revenge Song, per lungo tempo l’epilogo consueto dei loro concerti, questa volta egregiamente sostituita dalla più datata I Was Meant For The Stage), dalla suite The Crane Wife alle recenti Rise To Me, All Arise, June Hymn, This Is Why We Fight, Down By The Water, Rox In The Box, che ripropone nel mezzo un’aria in stile Irish Heartbeat, e Calamity Song, ispirata a una novella di David Foster Wallace.
Bravi a saper coniugare la scuola del folk elettrico britannico di fine ’60 (Fairport Convention, Pentangle) e degli anni ’80 (Pogues, Waterboys) con il roots americano, la lezione dei R.E.M. e dei grandi maestri (The Band, Byrds, Grateful Dead).
giovedì 17 maggio 2012
Padania, 2012
PERFUME GENIUS, SHINS, MOSS
La rubrica delle segnalazioni musicali di PiacenzaSera riparte dopo un breve periodo di silenzio dovuto, niente scuse, alla pigrizia proverbiale del recensore.
E, per farsi perdonare, lo fa proponendovi addirittura tre nuove uscite.
Perfume Genius è lo pseudonimo di Mike Hadreas, da Seattle.
Cantautore dalla vena intimista e tormentata, in questa sua seconda opera mostra segni di maggiore maturità rispetto all’esordio, tra Antony e Wainwright.
Si è parlato di lui a causa del video di “Hood”, nel quale ha recitato un noto attore gay porno, ma merita maggiore considerazione per la sua musica e le sue canzoni, tra le qualki “Normal Song” e “Dark Pants”, che narra delle violenze subite dalla nonna a opera di suo marito (“I will take the dark parts of your heart into my heart”).
Certamente più accessibili e scanzonati gli Shins, band di Albuquerque (New Mexico, resa celebre da Neil Young) ma di stanza a Portland, Oregon, una delle nuove mecche della geografia rock USA, e capitanata da un nerd incallito come James Mercer (amante di Weezer e Big Star).
Il loro terzo album contiene la solita serie di pezzi lounge-pop dalla sonorità sixties, ma alla fine l’ascolto lascia poche tracce.
Citazione d’obbligo per la superba, e mielosa, “It’s Only Life”.
Per ultimi gli olandesi Moss, da Amsterdam (quanta buona musica dall’Olanda…), giunti anch’essi al terzo album e autori di un pop-rock sofisticato, assai gradevole e senza sbavature.
Poco più di quaranta minuti per undici brani scritti bene, davvero bene, tra i quali spiccano l’opener “I’m Human”, eterea e sfuggente, la notevole “Tiny Love”, che è stata accostata ai Beach House e ai Fleet Foxes, poi “The Hunter”, tra i primi Placebo e il krautrock anni ‘70, e infine “Almost a Year” e “What You Want”, che sfodera un riff di chitarra semplice e tuttavia irresistibile, un singolo che potrebbe anche sfondare.
domenica 18 marzo 2012
W la Bolide


Sono nato nel palazzo di fronte, un’anonima costruzione in cemento armato che svetta per cinque piani all’angolo tra le vie Alberoni e via Abbadia. Quante volte l’avevo notata, ai tempi della scuola, mentre ripetevo la lezione nella mia camera affacciata sui giardini. E quante volte mi sono affidato a lei, mentre con lo zaino in spalla andavo a scuola senza aver nemmeno finito i compiti.
Eppure solo adesso me ne sono ricordato.
La cosa curiosa è che, chiedendo a parenti e amici che vivono da sempre nel mio quartiere d’origine, ho appreso con stupore che quasi nessuno si è mai accorto di lei. Quale Madonna?, mi hanno risposto.
Dice bene Enrico Garlaschelli, nel presentare questa iniziativa (Libertà, 19.01.2012): “L’uomo moderno ha uno sguardo e un’andatura diversi: quelli frettolosi dell’automobile, quelli curiosi o indifferenti dei passanti”.
Pensare che lei è in quella nicchia, sormontata da un timpano triangolare retto da esili lesene, da oltre un secolo. Non conosco l’anno di costruzione del fabbricato del civico 57 di via Alberoni, oggetto di un sopralzo nel secondo dopoguerra. Sobrio e severo, questo palazzo residenziale riprende le modanature della più bassa e antica costruzione alla sua destra, di origine settecentesca. Esso è stato sovrapposto nel XX secolo al lato sinistro di San Savino, nel corso del tempo accerchiata da un coacervo disomogeneo di costruzioni. All’esterno, gli unici tratti oggi visibili della basilica romanica sono la facciata del XVIII secolo e le due absidi ricostruite durante i lavori di restauro di fine Ottocento, quando Ettore Martini – che abitò proprio qui - fu incaricato di spogliare il tempio dal pesante apparato decorativo di epoca barocca e di riportarlo al suo splendore originario. Pragmatico e fedele alla scuola di Viollet Le Duc («Restaurare una costruzione è ristabilirla in uno stato completo che può anche non essere mai esistito fino a quel momento»), l’ingegnere usò la mano pesante, decidendo di ricostruire alcuni dei capitelli antropomorfi e zoomorfi dei pilastri cruciformi che reggono le volte costolonate, oltre a inventarsi la scenografica scalinata di accesso alla cripta, posta sul fondo della navata centrale.
Da quando ne ho memoria, la facciata del palazzo è senza colore.
Solo intonaco grigio, ormai annerito dal traffico e dalle polveri sottili, sul quale spicca la statua in pietra - opera di discreta fattura ma convenzionale - che raffigura la Madonna con le mani congiunte nell’atto di pregare, con una mezzaluna rovesciata ai suoi piedi che allude all’Apocalisse: “Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”. Un’iconografia popolare e diffusa a partire dal XV secolo (così la rappresenta nel 1498 Jean Bourdichon nel trittico della Cattedrale di Moulins: in piedi, giovane e bella, con i capelli sciolti, che poggia sulla falce lunare; e per togliere ogni dubbio il cartiglio ai suoi piedi reca la scritta: “Sole amicta, lunam habens sub pedibus, coronata stellis”).
L’androne sottostante la statua reca un’iscrizione nel cancello in ferro battuto:
“MATER ILIIS”.
Devo ammettere di non aver studiato il latino, tuttavia posso avanzare il dubbio che alla scritta manchi una “F”:
“MATER FILIIS”.
La madre per i figli.
Oltrepassando l’androne si accede al cortile dell’oratorio, il cortile dove io e i miei amici abbiamo tirato i primi calci a un pallone, nella mitica “Bolide”. Era allora, e lo è ancora, un piazzale di cemento pieno di buche e di pozzanghere, dalla forma irregolare, vagamente trapezoidale. Sul lato sinistro, era delimitato da gabbie metalliche, contro le quali era possibile far rimbalzare la palla, mentre sul lato opposto esisteva una linea di fondo: questo almeno in teoria, perché era costantemente lavata via dalle piogge invernali. Sui lati corti, dietro alle porte pericolosamente inclinate verso l'area di rigore, c'erano le autorimesse dei condomini del caseggiato; bisognava fermarsi e sospendere la partita, quando qualcuno di loro veniva a ritirare la macchina. Quando veniva buio, il parroco mandava la perpetua a requisirci la palla: era questo l'unico modo per far terminare le partite, che andavano avanti per ore e ore, sotto il sole e sotto la pioggia, fino a che tutto non sfumava nell'oscurità.
L’oratorio era anche, allora, un punto di riferimento per tutti noi ragazzi, adolescenti e non, un vero e proprio centro di aggregazione sociale.
Erano quelli i tempi difficili - del terrorismo e della strategia della tensione - che seguirono la ricostruzione del dopoguerra, il mito del progresso e della crescita continua.
Piacenza appariva trasformata, reduce dal saccheggio della speculazione edilizia e di un’attività edilizia frenetica che produsse una periferia caotica e disordinata. In un paio di decenni la città consolidata – oltre duemila anni di storia urbana – duplicò, anzi triplicò, le sue dimensioni; il centro perse la sua tradizionale importanza produttiva e iniziò a spopolarsi. A pochi metri dalla Mater, ecco tuttavia in quegli anni erigersi il Grattacielo dei Mille, simbolo e paradigma di un boom economico ormai sgonfiatosi e dei suoi inutili eccessi, svettare tra le case umili dei maestri e dei ferrovieri, costruite senza ferro e con poco cemento. Sembra di udire l’anatema di Ginsberg nel suo celebre “Urlo” (1956): “si sono rotti la schiena a innalzare moloch al cielo!”
Allora in via Alberoni c’erano ben due fruttivendoli, a distanza di trenta metri uno dall’altro. Poi c’era un rivenditore di elettrodomestici, un fotografo, la parrucchiera, il negozio di fiori, una latteria, una merceria, le tre sorelle che vendevano il pane, così devote alla Madonna, l’alimentari e il Bar Sport.
Il Bar Sport c’è anche adesso. Intorno, resiste solo la parrucchiera, il fotografo ha chiuso da un pezzo. Adesso ci sono due o tre kebab, un take away pakistano, un centro massaggi con arredamento minimal-giapponese, un callcenter con transfer money, una lavanderia a gettone, una copisteria e qualche vetrina sfitta.
E’ la città tradizionale che implode e si smaterializza sotto i nostri occhi, inglobata dall’attuale indiscriminata urbanizzazione del territorio agricolo - la "geography of nowhere" descritta da Kunstler, scrittore e osservatore di un paesaggio occidentale in costante evoluzione. Inizialmente mosso dal legittimo desiderio di accedere a una casa di proprietà, di garantire alla propria famiglia la privacy, di stabilire un più diretto rapporto con la natura, l’abitante postmoderno soffre oggi della congestione del traffico e dell’inquinamento, ma anche di un crescente senso di isolamento, che è certa¬mente reso più acuto dalla mancanza di spazi pubblici degni di questo nome. E la scomparsa dello spazio pubblico avviene a vantaggio di una progressiva privatizzazione del territorio, e in ultima analisi della trasformazione del cittadino in consumatore. I luoghi di socializzazione tipici della contemporaneità e del sistema globale delle reti sono infatti i grandi contenitori, i Centri Commerciali e le Multisala cinematografiche, ovvero quelli che paradossalmente Augè – l’etnologo della solitudine – aveva definito i “non-luoghi”: parallelepipedi privi di significato e senza riferimenti al loro contenuto, accostati uno all’altro lungo strade a scorrimento rapido, ma ormai affermatisi come punti di ritrovo d’elezione dagli adolescenti.
L’oratorio per fortuna c’è ancora.
Possiamo considerarlo uno degli ultimi avamposti della città, la città così come storicamente l’abbiamo sempre intesa, ovvero uno dei rituali antichi che la modernità non riesce a cancellare ma che pone sullo sfondo, indicatori del tempo che passa e sopravvive.
E anche oggi è uno straordinario luogo di incontro e di contaminazione. Un crocevia di culture e di religioni.
Luogo di inclusione, non di esclusione.
Oltre a esprimere la devozione e la gratitudine dei fedeli, tradizione vuole che la Madonna del mistadello indicasse ai pellegrini stanchi – i moderni migranti - che in quel luogo avrebbero trovato cibo e accoglienza.
Al pomeriggio, qui vengono a giocare ragazzi dell’Ecuador e del Burkina Faso, della Macedonia e dell’Algeria, dell’Albania e del Marocco: cattolici, ortodossi e musulmani.
Tutti figli della stessa madre.
The revolution will bw not televised

Appuntamento di grande interesse, quello svoltasi lo scorso mercoledì al Caffè Letterario Baciccia. Nel corso della serata – che ha visto la speciale partecipazione di Luca Frazzi, redattore del mensile musicale “Rumore” e di Alioscia, vocalist storico dei Casino Royale - sono stati infatti presentati i due volumi “ORIGINAL RUDE BOY, DALLA GIAMAICA AGLI SPECIALS”, sottotitolo: l'autobiografia dello Ska Inglese, e “GIL SCOTT-HERON, The Bluesologist”, Storia e discografia del padre del Rap.
Il primo testo è l’autobiografia di Neville Staple – scritta in collaborazione con il giornalista inglese Tony McMahon e tradotta in italiano da Antonio "TONY FACE" Bacciocchi, con la prefazione di Alioscia - ovvero il frontman di colore della band di culto degli Specials - leader incontrastati dello ska inglese e tra gli animatori dell’opposizione al governo Thatcher - , poi del trio pop Fun Boy Three e adesso del gruppo ska The Neville Staple Band.
Il secondo invece è opera dello stesso Bacciocchi, ed è un intenso ritratto della figura di Gil Scott-Heron, poeta, musicista, cantante, autore, scrittore, cantore dell'America del Vietnam e dell’emancipazione del popolo nero (fu ribattezzato dalla critica statunitense “il Bob Dylan nero”).
Nella prefazione al testo, Tony Face elenca i motivi per cui ha iniziato ad amare questo grande artista: “Qualcuno ha scritto che le sue canzoni sono piene di rabbia triste. Gil sa essere Malcolm X e James Brown, Curtis Mayfiled e Walt Withman, tragico e ironico, divertente e implacabile. Sa accostare stupende ballate a pungenti e devastanti inni politici.”
Il libro ripercorre la travagliata vita dell’artista nero, segnata da abusi di ogni tipo: dall’infanzia vissuta in casa della nonna paterna nel Tennessee, che gli garantì una solida educazione e studi prestigiosi, alle prime prese di coscienza a livello politico e sociale, che coincisero con le morti di Kennedy, di Malcolm X e soprattutto di Martin Luther King (un periodo che lui ribattezzò “Winter in America”, che è anche il titolo del suo terzo album di studio del 1973); dal debutto come romanziere (“The Vulture”, 1970 e “The Nigger’s Factory”, 1971) ai primi esperimenti musicali con un album di spoken words, in cui legge le sue poesie sull’orgoglio Blackness e che contiene una primissima versione dell’immortale “The Revolution Will Be Not Televised”, certamente il suo brano più noto ma anche controverso (lui stesso rinnegherà alcune interpretazioni troppo politicizzate del brano, come quella del Wu Tang Clan); dalla collaborazione con Brian Jackson e con la Midnight Band alla partecipazione al concerto “No Nukes” contro il nucleare (1979), e ai tour di Stevie Wonder; dai problemi con la droga al recente, grandissimo ritorno dopo un lungo periodo buio con l’eccellente “I’m New Here”, sino alla sua improvvisa scomparsa avvenuta lo scorso 27 maggio al St.Luke Hospital di New York, reduce da un lungo tour europeo.
Ironico e aggressivo, brutale e diretto, Gil voleva “gettare qualche informazione in faccia alla gente che altrimenti non avrebbe mai potuto avere”.
Considerato da molti artisti rap e hip-hop alla stregua di un padre spirituale (lui stesso apprezzava artisti come Common, Mos Def e Kanye West, anche se i suoi preferiti rimasero i grandi classici della musica afroamericana: Miles Davis, Nina Simone, John Coltrane, Billie Holiday), non ebbe forse il successo che avrebbe meritato. Colpa, anche, di un carattere non facile: “Se non fossi stato l’eccentrico, l’odioso, l’arrogante, l’aggressivo, l’introspettivo, l’egoista quale sono stato, non sarei stato io. Non mi pento di aver fatto quello che ho fatto o del modo in cui l’ho fatto. So che se fossi stato zitto su un paio di cose probabilmente avrei fatto un po’ di soldi, ma non avrebbe dato più senso a quello che ho fatto. E non sarei stato capace di dire ai miei figli: ho alzato la testa per questo”.
La sua vita, suggerisce Bacciocchi nell’epilogo del breve saggio introduttivo sulla sua parabola umana ed artistica, può essere suggellata dal fatto che “Io credo nelle mie convinzioni, sono stato condannato per ciò in cui credo”.
Un febbraio fertile: ecco il grande ritorno dei Lambchop (“Mr. M”), sul quale forse torneremo più tardi, poi il pop sofisticato delle svedesi First And Kit e il prog dei Field Music, il nuovo EP della potessa dark austriaca Soap&Skin (“Narrow” - il brano “Wonder”, davvero meraviglioso – nome omen) e il torrenziale doppio album dei Crippled Black Phoenix, “(Mankind) The Crafty Ape”, le cui cavalcate acide ambiscono al titolo di “Dark Star” del nuovo millennio (siamo certi che piacerebbero anche al vecchio Zio Jerry).
Ma due uscite in particolare fanno discutere la stampa specializzata.
I giovanissimi Maccabees sono dei predestinati Dopo un paio di lavori caratterizzati da un pop fresco e di facile presa, la band di Brighton prova il salto di qualità con questo “Given To The World”, acclamatissimo in patria.
Gli arrangiamenti orchestrali e il massiccio utilizzo di organo e pianoforte ricordano gli Arcade Fire, ma qui la pietra di paragone è l’art-rock di Wild Beasts, Foals ed Elbow. Ma anche, andando in dietro: XTC, Echo & The Bunnymen.
Per dirla con le parole di Storiadellamusica.it, “abbiamo di fronte un'imponente prova di metabolizzazione degli ultimi dieci-venti anni di pop music inglese. Il risultato è quasi perfetto e si spinge oltre alla raccolta enciclopedica, facendo fluire forme e stili in un'ibridazione personale e spesso straniante”.
Il primo ascolto ci ha lasciati perplessi, forse a causa degli arrangiamenti troppo puliti.
Ci torneremo.
La band di Dylan Baldi arriva invece dell’America più profonda: Ohio.
Se i Maccabees hanno metabolizzato il pop made in GB, i Cloud Nothings è capace di sintetizzare – nessuno inventa più nulla - quanto di più buono prodotto recentemente oltreoceano.
Prodotti dal celebre Steve Albini (Rapeman, Big Black, Shellac), propongono in avvio con l’inquietante nichilismo di “No Future No Past” un revival della stagione del post-rock americano (Slint, Codeine) e con lo strumentale “Wasted Day” dell’epopea dell’etichetta Dischord di Chicago (Fugazi), per poi orientarsi verso un power-pop raffinato debitore, in particolare con tre-quattro pezzi molto belli, tra i primi Foo Fighters e l’hardcore Usa anni ’80-‘90 (Replacements e Husker Du): “Our Plans”, “Fall In” e “Cut You”.
Una delle sorprese più piacevoli dell’anno.
Ma due uscite in particolare fanno discutere la stampa specializzata.
I giovanissimi Maccabees sono dei predestinati Dopo un paio di lavori caratterizzati da un pop fresco e di facile presa, la band di Brighton prova il salto di qualità con questo “Given To The World”, acclamatissimo in patria.
Gli arrangiamenti orchestrali e il massiccio utilizzo di organo e pianoforte ricordano gli Arcade Fire, ma qui la pietra di paragone è l’art-rock di Wild Beasts, Foals ed Elbow. Ma anche, andando in dietro: XTC, Echo & The Bunnymen.
Per dirla con le parole di Storiadellamusica.it, “abbiamo di fronte un'imponente prova di metabolizzazione degli ultimi dieci-venti anni di pop music inglese. Il risultato è quasi perfetto e si spinge oltre alla raccolta enciclopedica, facendo fluire forme e stili in un'ibridazione personale e spesso straniante”.
Il primo ascolto ci ha lasciati perplessi, forse a causa degli arrangiamenti troppo puliti.
Ci torneremo.
La band di Dylan Baldi arriva invece dell’America più profonda: Ohio.
Se i Maccabees hanno metabolizzato il pop made in GB, i Cloud Nothings è capace di sintetizzare – nessuno inventa più nulla - quanto di più buono prodotto recentemente oltreoceano.
Prodotti dal celebre Steve Albini (Rapeman, Big Black, Shellac), propongono in avvio con l’inquietante nichilismo di “No Future No Past” un revival della stagione del post-rock americano (Slint, Codeine) e con lo strumentale “Wasted Day” dell’epopea dell’etichetta Dischord di Chicago (Fugazi), per poi orientarsi verso un power-pop raffinato debitore, in particolare con tre-quattro pezzi molto belli, tra i primi Foo Fighters e l’hardcore Usa anni ’80-‘90 (Replacements e Husker Du): “Our Plans”, “Fall In” e “Cut You”.
Una delle sorprese più piacevoli dell’anno.
domenica 19 febbraio 2012
Il pagellone di Sanremo, 2012

ARISA – La notte
La sorpresa.
Il suo duetto con Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus) è una delle poche cose da ricordare di questo festival, e in più c’è il violino commovente di Mauro Pagani.
La canzone, dolce e intimista, è forse la più bella.
E in mezzo a tatuaggi inguinali e mutande nascoste, la sua sobrietà un po’ trista ci sta pure simpatica.
In finale abbiamo tifato per lei, inutilmente: troppo forte lo strapotere del televoto in favore dei prodotti del marketing targato Mediaset.
VOTO: 7,5
CHIARA CIVELLO – Al posto del mondo
Ci dicono che è famosa in tutto il mondo come cantante jazz: lo ripetono più volte nella speranza che noi ci crediamo davvero.
By the way, il colpo alla Gualazzi quest’anno non riesce, perché Chiara è sembrata - a pubblico e critica – poco più di una schiappa.
Ovvio, sul voto influisce anche il duetto non indimenticabile con la Michielin, fresca vincitrice di XFactor 5.
VOTO: 5
DOLCENERA – Ci vediamo a casa
Grintosa con vestitino nero, borchie, spilloni e schiena scoperta: peccato per quei booties che le regalano un bell'effetto cotechino.
L’arrangiamento del pezzo è troppo radiofonico, quasi dance, e i continui riferimenti a De Andrè c’azzeccano poco.
Con Gazzè il pezzo ne guadagna.
VOTO: 5
EUGENIO FINARDI – E tu lo chiami Dio
Il vecchio cantautore milanese, look total black, codino e un’aura da spiritualità zen, sfodera sorrisi immotivati e – ormai raggiunta la pace interiore - se ne fotte di tutto il caos che gli sta intorno.
L’interpretazione è di classe, così come il duetto con un'elegante Noa.
Il testo non è tra i suoi più ispirati, ma pare Proust al confronto con l’avvincente dibattito tra Pupo, Celentano e Morandi sulla sinistra e sulla vita di Gesù.
VOTO: 6,5
EMMA – Non è l’inferno
Non sarà l’inferno, ma ci assomiglia.
Emma canta in modo sguaiato ed eccessivo un pezzo straordinariamente brutto anche per la media non eccezionale di Kekko dei Modà (ma non poteva saltare un giro, quest’anno?). Il testo, poi, è talmente paraculo che si sarebbe vergognato persino Povia.
L’accoppiata salentina con la Amoroso – su Twitter qualcuno le ha definite “due rane” – rappresenta l’apoteosi del DeFilippi-pensiero.
Vince a mani basse: è lo specchio dell’inesorabile declino del paese.
VOTO: 4
FRANCESO RENGA – La tua bellezza
Mah.
L’ex-ledaer dei Timoria ci sembra decisamente involuto, ed è fastidioso questo suo eccesso di autostima. Alla fine fa parlare di sé solo per le polemica (sacrosanta) sul troppo spazio concesso a quello sciroccato del molleggiato: facciamo solo da contorno, si è lamentato. Come dargli torto?
L’accompagnamento del coro di Scala & Kolacny Brothers una pessima idea.
VOTO: 5,5
IRENE FORNACIARI – Il grande mistero
Il grande mistero è lei.
Tra le più assidue frequentatrici del festival, ancora una volta si rivela una meteora: inconsistente e impalpabile, non lascia traccia di sè.
Si presenta vestita come il tubo di una stufa in un sapiente nero che "sfila", e nemmeno al secondo cambio acquista dignità di donna, resta stufa.
Alla lunga stufa anche noi.
VOTO: 4,5
LOREDANA BERTE’ e GIGI D’ALESSIO
Lei esibisce evidenti segni di errori chirurgici sul viso, corredati dalle immancabili labbra a canotto. Non contenta, indossa un vestito che svela ciò che dovrebbe nascondere.
Lui ha l’aria del pappone, con un giubbino da motociclista e un sorriso assai sforzato.
Accanto a loro la povera Macy Gray – in pailettes e paltò – non si regge in piedi: probabilmente si è ubriacata di brutto quando ha saputo che doveva duettare con D'Alessio (pare che abbia provato la strada del certificato medico, senza esito).
Imbarazzanti.
VOTO: 3
MARLENE KUNTZ – Canzone per un figlio
Sul web impazzano le accuse di tradimento da parte dei fan della prima ora. Inevitabili, per loro questo palco è la morte della musica.
Godano – così conciato è il sosia di Mirko Vucinic, con tristi multistrati e improbabili multi grigi - parte troppo piano, bisbigliando frasi apparentemente sconnesse (noi abbiamo capito solo: “attonita”). Il ritornello invece è soffocato dall’enfasi ingiustificata della sezione archi e, insomma, il pezzo ne esce piuttosto male.
Tuttavia, il duetto con l’icona Patti Smith – “Impressioni di settembre” della P.F.M. e poi la celebre “Because the night” – è uno dei pochi momenti emozionanti di uno dei festival più brutti degli ultimi anni.
Lei, poi, sembra una prof di italiano vicina alla pensione: lezione di stile a Dalla e alla Bertè.
VOTO: 6,5
MATIA BAZAR – Sei Tu
Che tenerezza, sembrano dei Muppets, dei vecchi zii dalla faccia di gomma che accompagnano la vocalist vestita come Biancaneve.
Il pezzo, no, non l’abbiamo ascoltato: abbiamo abbassato l’audio.
Non potete chiedere troppo.
VOTO: 4 (sulla fiducia)
NINA ZILLI – Per sempre
La nostra punta di diamante puntava allo scudetto, ma si deve accontentare della Coppa Uefa.
La mandano a rappresentare l’Italia all’Eurofestival a Baku, Azerbaijan.
Povera.
Seppur annoiata dai paragoni con Mina e con Winehouse, Nina si diverte con Giuliano Palma e con Skye dei Morcheeba, bellissima tutta in bianco.
Ha classe e talento, forse il pezzo non era all’altezza.
VOTO: 6
NOEMI – Sono solo parole
Nonostante l’evidente pasticcio cromatico - capelli rosso fuoco, giacca verde cangiante e trucco bianco pallido – Noemi sfodera grinta e una bella voce, e nel complesso non fa una bruttissima figura (anche se, cazzarola, presentarla con “You Really Got Me” dei Kinks è davvero troppo).
Il pezzo è di Fabrizio Moro: scontato ma efficace.
Brava con Sarah Jane Morris, in versione Fiona di Shrek, nella cover da Tracy Chapaman.
VOTO: 5,5
PIERDAVIDE CARONE - Nani
Ha la gravissima colpa di aver scritto “Per tutte le volte che”, brano trash con cui Valerio Scanu ha vinto tempo fa la sezione giovani. Per questo motivo in un paese normale sconterebbe una pena tra i dieci e i dodici anni, mentre lui è a piede libero.
A poco servono l’accompagnamento di un Dalla in versione Biscardi e il duetto di un Grignani sopra le righe.
La sensazione è che l’amico Pierangelo Carbone – un passato illustre negli Hurlo – non lo avrebbe fatto rimpiangere.
VOTO: 4,5
SAMUELE BERSANI – Un pallone
A noi lui piace parecchio, anche se questo pezzo non è tra i suoi migliori.
Il duetto con Paolo Rossi, paragonato sul web al fratello brutto e senzatetto del Pinguino di Batman, non è memorabile; più divertente quello con Bregovic – presentato da Morandi come Goran Zuzminac (!, chi minchia se lo ricordava!), uno dei passaggi migliori del festival insieme all’inutile Ivanka che cita Ennio “Morriccione”.
Scontato il premio della critica (tra i giovani andato alla Erica Mou, non male infatti).
VOTO: 7
(grazie a Nilla, Walter, Ivan e Michele)
mercoledì 15 febbraio 2012
Uscito da qualche mese, questo prezioso DVD documenta il live della band di Kurt Cobain tenutosi al Paramount Theatre di Seattle, WA, l’ormai lontano 31 ottobre 1991, quando salì sul palco della propria città dopo i compaesani Mudhoney, tra i principali esponenti del nascente grunge, e i Bikini Kill.
Originariamente girato con pellicola 16 mm, il concerto è stato rimasterizzato in occasione del ventesimo anniversario di “Nevermind” - disco epocale, disco che ha cambiato la storia.
Il videoclip, poco più di un’ora di straordinaria musica, restituisce una band in ascesa e in assoluto stato di grazia: un sound grezzo e acerbo, ma potentissimo e viscerale.
Pochi fronzoli, molte emozioni.
Kurt Cobain si presenta con una maglia infeltrita e piena di buchi, grigia con collo a V, jeans e capelli spettinati davanti agli occhi, forse come forma di autodifesa per la sua timidezza. Sulla sua chitarra un grosso adesivo: “Vandalism: beautiful like a rock in a cop’s face”. Krist Novoselic con pizzetto, maglietta POWER e piedi rigorosamente scalzi; Dave Growl a torso nudo e i consueti tatuaggi sugli avambracci.
Pochissime parole, e una scenografia praticamente inesistente: Smells Like Teen Spirit con uno sfondo rosso acceso, la successiva About A Girl con un azzurro, e poi Polly che ancora vira sul rosso. Alcuni ragazzi salgono indisturbati sul palco e ballano fianco a fianco dei musicisti. Ogni tanto qualcuno fa surf lanciandosi sul pubblico.
La musica dei Nirvana non ha bisogno di effetti speciali.
Strepitosa la scaletta, tra “Nevermind” e “Bleach”, con qualche anticipazione da “Incesticide”: "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam" (The Vaselines, ripresa anche in MTV Unplugged)/"Aneurysm"/"Drain You"/"School"/"Floyd the Barber"/"Smells Like Teen Spirit"/"About a Girl"/"Polly"/"Breed"/"Sliver"/"Love Buzz" (Shocking Blue)/"Lithium"/"Been a Son"/"Negative Creep"/"On a Plain"/"Blew"
L' edizione singolo DVD contiene 3 tracce bonus registrate l'8 marzo 1991 al Commodore Ballroom a Vancouver: “Breed”/”Territorial Pissings”/”Scoff”
Per i dizionari del presente e del futuro.
Alla voce: rock.
lunedì 6 febbraio 2012
Era destino inevitabile che, tale era stato l’hype dei mesi passati e tale l’attenzione su di lei da parte dei media, alla fine nessuno parlasse della sua musica.
Lana del Rey, al secolo Elizabeth Grant (classe 1986), newyorchese, ha finalmente pubblicato il suo primo album, preceduto da un’abilissima operazione di marketing; in molti le pronosticano da tempo un futuro da star. Che poi, di vero debutto non si tratta: la biondina dalla bellezza algida e dallo sguardo glaciale aveva già inciso un disco nel 2009 sotto lo pseudonimo di Lizzy Grant, poi misteriosamente ritirato dal mercato (assai più affascinante il nuovo nome d’arte, mutuato dalla diva di Hollywood Lana Turner, nota per le sue burrascose relazioni sentimentali, e la Ford Del Rey, una macchina di produzione sudamericana diventata obsoleta prima del tempo).
“Born To Die” è uscito a fine gennaio e già divampano le polemiche.
I duri e puri dell'alt rock sono rimasti delusi a causa di una produzione patinata e dagli arrangiamenti troppo pop.
Il popolo del web che l’aveva anzitempo adottata come nuova eroina – il videocilp di “Videogames”, primo singolo estratto, è da mesi tra i più cliccati sul tubo – l’ha pubblicamente rinnegata: si moltiplicano le parodie sui social network e le critiche sulla sua scarsa resa live (la sua esibizione al Saturday Night Live è stata definita "disastrosa", e c’è chi ha scritto che un ubriaco su un treno canterebbe meglio…; meglio è andata da Letterman qualche sera dopo, con il popolare showman che al termine dell’esibizione le dice: torna anche domani!)
Giudicate voi stessi:
http://www.youtube.com/watch?v=9zrvD-o8cII
http://www.youtube.com/watch?v=Hr52zTBp3oo
Alcuni dubitano della sua autenticità, ipotizzando che si tratti di una bufala colossale, di un prodotto studiato a tavolino da sedicenti strateghi del mercato discografico (ricordate The Great Rock’n’Roll Swindle, la grande truffa del Rock’n’Roll?). Altri ironizzano sul suo look ruffiano, artificiale e rétro; altri ancora sospettano pesanti iniezioni di chirurgia plastica, e le labbra a canotto alla Jessica Rabbit parrebbero avvalorare questa tesi.
La sua musica, dicevamo.
A noi ha lasciato un po’ di amaro in bocca.
I due brani già noti, “Videogames” e la title-track (con un video dark-gothic girato nel castello di Fountainebleu), sono due brani notevoli e dunque le aspettative, anche per noi, erano assai elevate. E invece il resto della collezione non si mantiene a quei livelli, invero eccellenti; meritano un cenno “Blue Jeans” – tra Portishead e Goldfrapp – l’orecchiabile “Dark Paradise” e infine la bella “Million Dollar Man”- tra Dido e Cat Power -, mentre "National Anthem" cita nell’incipit i Verve di "Bittersweet Symphony", che a loro volta avevano citato gli Stones di “You Can’t get Always What You Want” (“Money is the anthem/Of success/So before we go out/What's your address?”).
La aspettiamo alla prova del nove, anche se rischiamo di rimanere ancor più delusi: “Non credo che scriverò un altro disco”, ha dichiarato in questi giorni, ancora visibilmente scossa dalle critiche feroci, “Cosa potrei dire? Sento che ho già detto tutto quello che volevo dire”.
mercoledì 1 febbraio 2012
Idee vecchie

La voce è che il cantautore canadese – da tempo ritiratosi su un’isola sperduta dell’arcipelago greco e abbandonata l’attività – sia stato costretto a un frettoloso rientro a causa di un clamoroso crac finanziario; in altre parole, pare che il vecchio Leonard (77 anni) sia rimasto nello spazio di poche ore senza un becco di un quattrino.
Il Live in London del 2009, con il quale ripercorreva la sua gloriosa carriera, era infatti sembrato ad alcuni nient’altro che una furba operazione commerciale.
Sarà una storia vera, o saranno solo stupide malignità, questo non è dato a noi saperlo.
Resta il fatto che questa volta è tornato in studio per licenziare un nuovo album di materiale inedito, che ai suoi occhi suonano solo come un pugno di “vecchie idee”.
“Vecchie idee” che alle nostre orecchie suonano invece come l’ennesima dimostrazione della sua innata classe, della sua scrittura raffinata, del suo senso della misura e infine del suo humour nero e malinconico.
Lasciati da parti gli arrangiamenti orchestrali – a volte un po’ pomposi – delle ultime decadi, Cohen ritorna alla scarna e tenebrosa semplicità degli esordi. Anche i cori femminili che lo accompagnano in molti ritornelli stavolta restano in secondo piano, e non disturbano la struttura generale dei brani.
L’ottima opener Going Home – ascoltabile sul sito del New Yorker – è un autoritratto ("un pigro bastardo in giacca e cravatta") scritto con sarcasmo e ironia: “I love to speak with Leonard/He’s a sportsman and a shepherd/He’s a lazy bastard/Living in a suit/But he does say what I tell him/Even though it isn’t welcome/He will never have the freedom/To refuse/He will speak these words of wisdom/Like a sage, a man of vision/Though he knows he’s really nothing/But the brief elaboration of a tube”.
Sul sito http://www.leonardcohen.com/it/oldideas potete invece ascoltare Darkness, primo singolo, un blues apocalittico sul crepuscolo della vita e delle illusioni, un’oscurità senza fine (“Non ho futuro/So che mi restano pochi giorni/Il presente non è così piacevole/solo un mucchio di cose da fare/Pensavo che il passato mi sarebbe bastato/Ma l'oscurità ha inghiottito anche quello”).
Il disco registra anche qualche calo di tensione, ma nel complesso si mantiene su uno standard di alto livello, con picchi – oltre ai brani già citati – come Show Me The Place e Come Healing.
Nudo alla meta, nell’olimpo dei grandi:
Dylan, Cash, Waits.
sabato 28 gennaio 2012
domenica 15 gennaio 2012
La terra del ghiaccio
L’alba del nuovo anno – quello definitivo, secondo la profezia Maya – è ancora avara di novità, e dunque occorre guadarsi ancora indietro per ripescare tra le uscite di quello passato.
E quindi: notizie (non proprio fresche…) dalla lontana terra d’Islanda.
Lasciatasi alle spalle l’estremismo avanguardista e snob di “Medulla” e “Volta”, opere – va detto - quasi inascoltabili, Bjork ha dato alle stampe “Biophilia”, ovvero un lavoro che segna un timido ritorno all’elegante techno-pop degli esordi, soprattutto per ciò che riguarda gli episodi più radiofonici (Crystalline, Virus).
Tuttavia, l’artista ormai newyorchese d’adozione fa parlare di sè soprattutto per lo sfruttamento delle tecnologie digitali più trendy: ella concepisce i propri lavori in primo luogo come applicazioni da scaricare su tablet o smartphone, algoritmi "intelligenti" che non si limitano a proporre le canzoni dell’album ma che creano microcosmi multimediali – e variabili - intorno alle stesse (l’applicazione “Biophilia” è gratuita sull’AppStore, mentre le singole tracce sono sotto-applicazioni a pagamento).
Mah.
Dopo oltre tre anni di attesa – interrotti solamente dal secondo album solista di Jonsi – ecco invece un torrenziale live dei conterranei Sigur Ros – assai più legati alla terra natìa - tratto a dire il vero da un’esibizione non troppo recente: due concerti tenuti all’Alexandra Palace di Londra nel 2008.
Il titolo “Inni” significa dentro.
Ed è una bella esperienza quella di entrare dentro la musica sognante e misteriosa, eterea eppur emozionale, della band di Reykyavik, che resta comunque una delle migliori cose del panorama della musica popolare d’autore (post-rock?) degli ultimi tempi.
La confezione in vendita è composta da quattro vinili, due CD e un DVD contenete un film documentario della serata. Il live è un meraviglioso, e faticoso, compendio della carriera – 17 anni, si formarono infatti nel dicembre del 1994 prendendo il nome dalla sorellina neonata di Jonsi: Sigurros, ovvero Rosa della Vittoria - dei ragazzi islandesi. Quattordici brani che toccano e ripercorrono tutti i lavori, dall’ormai lontano “Von” all'ultimo “Með Suð I Eyrum Við Spilum Endalaust”. Le perle del disco: Hoppipolla, Saeglopur, Svefn-g-englar, Festival (cazzo, almeno un nome facile…)
La raccolta si conclude con l'inedito in studio Lúppulagið, un brano dall’atmosfera ambient che sembrerebbe anticiparci il loro futuro.
Non resta che attenderli alla prova.
lunedì 9 gennaio 2012
Archiviato l’anno appena trascorso con il trionfo annunciato – almeno per il pagellone di PiacenzaSera – di Justin Vernon aka Bon Iver, meritatamente un gradino o due sopra Wilco, P.J. Harvey, St. Vincent e James Blake, non resta che recuperare alcuni lavori assolutamente misconosciuti ma interessanti che, per ragioni di spazio, abbiamo in passato colpevolmente ignorato.
Ma anche qui non c’è spazio per tutti – verrebbero in mente i transalpini M83, i danesi Iceage, poi i Tuneyards, i Gang Gang Dance e anche il secondo album di Antlers, progetto solista di Peter Silberman, da Brooklyn – e dunque siamo costretti a scegliere solamente due titoli: Girls e Dirty Beachers.
I primi arrivano da San Francisco e sono capitanati da Christopher Owens, hipster magro e biondo con una biografia che sembra scritta da un Frank Capra in acido: orfano di padre in tenerissima età, cresciuto dalla setta religiosa Children of God dopo aver girovagato per anni con la madre prostituta, infine adottato da un milionario di Beverly Hills, che non si sa se è un lieto fine.
Il loro rock chitarroso e abrasivo si richiama alla migliore scuola americana anni ’80, epoca pre-grunge: Husker Du e Replacements.
Si ascoltino Vomit – il primo singolo estratto dall’album, un lungo lamento che fa pensare a Nick Cave – poi My Ma (palesemente ispirata dal Neil Young di Rust Never Sleeps), la cavalcata psych Die e la melodica Just a Song.
Quello di Alex Zhang Hungtai aka Dirty Beaches è invece un dischetto sporco e imperfetto (dura poco più di venti minuti, ma attenzione: è un vero gioiellino) scovato grazie a Sentire Ascoltare, che lo ha inserito tra le rivelazioni del 2011. L’atmosfera – lo dice il titolo – dovrebbe essere ispirata allo Springsteen crepuscolare di Nebraska. Si sente l’influenza anche dello psichobilly distorto e scomposto di Cramps e Suicide e della canzone d’autore di scuola francese; con echi di romanticismo tenebroso da Giant Sand, Portishead e Tindersticks.
Un grande dischetto.
Iscriviti a:
Post (Atom)