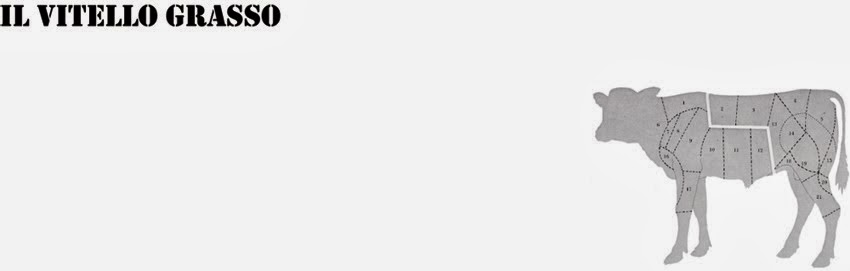Non era facile dare un seguito a “For Emma, Forever Ago”, il debutto strabiliante dei/di Bon Iver del 2008, opera incensata e mitica (mitizzata?). Si trattava di una raccolta di esili ed eteree canzoni, letteralmente strazianti e un po’ naif, composte dal leader e vocalist Justin Vernon ritiratosi in un capanno isolato del Wisconsin dopo una lacerante delusione amorosa e al termine di una lunga malattia.
Questo secondo album eponimo – anzi doppiamente eponimo, Vernon preferisce chiamarlo “Bon Iver, Bon Iver” – non cade nel tentativo di ripetere quel mood unico e irripetibile, generato da una situazione contingente, ma invece arricchisce il loro repertorio di nuove trame, di un sound piu’ strutturato, di arrangiamenti piu’ sofisticati e orchestrali (fondamentali in questo senso le collaborazioni con Greg Leisz e Colin Stetson), senza tuttavia tradire gli elementi più tipici del suo stile ormai codificato: la voce in falsetto, trattata grazie all’uso del vocoder e a sovraincisioni multiple, le suggestive e malinconiche melodie a cavallo tra la tradizione folk ed emotività soul, una comunicatività unica malgrado i testi quasi incomprensibili (i lamenti stranianti di Vernon ci rammentano la lingua inventata dei Sigur Ros, o i virtuosismi vocali di Robert Wyatt e Tim Buckley).
Nel frattempo è infatti arrivato il successo, quello con la S maiuscola, e da lì collaborazioni illustri ed eterogenee (National, Kayne West, St. Vincent) e attestati di stima (Peter Gabriel ha inserito la cover di Flume nel suo ultimo album); e anche lo straordinario EP dello scorso anno, intitolato “Blood Bank”. Insomma, deve aver pensato Justin: cosa cazzo ci torno a fare in quel fottuto capanno del Wisconsin?
“Bon Iver, Bon Iver” è quasi un concept-album, nel senso che ogni brano è ispirato a un luogo del mondo, che sia reale o inventato, una sorta di diario di viaggio dell’immaginario nel clima gelido dell’America settentrionale (Bon Iver è una storpiatura di buon inverno in francese).
In apertura troviamo uno dei capolavori della collezione: “Perth”. “Una canzone heavy metal con un suono da Guerra Civile”, la definisce Vernon per via del suo incedere marziale. Gli altri capolavori sono le commoventi “Holocene” e “Michigant”, ballate post-rock che solo lui sa scrivere, e “Calgary”, primo singolo estratto, con la sua aspra e spiazzante coda noisy.
Un gradino sotto le bucoliche “Towers” e “Wash”, e anche l’innocuo intermezzo di “Lisbon, OH”.
I restanti tre pezzi presentano le maggiori discontinuità con il passato: in “Minnesota, WI” e “Hinnon TX” Vernon abbandona il falsetto mentre nella conclusiva “Beth/Rest” si permette addirittura di citare – alla maniera dell’ultimo Sufjan Stevens – il pop elettronico degli eighties, senza paura di apparire ridicolo (“Fuck it, I love the way this sounds").
Insomma, siamo in presenza di un vero artista: Bon Iver è – in campo musicale - la cosa piu’ bella che ci è capitata da qualche anno a questa parte.
giovedì 30 giugno 2011
domenica 19 giugno 2011

Warp records non delude le aspettative.
In attesa dell’ennesimo Brian Eno – il guru dell’ambient farà uscire il suo “Drums Betwwen The Bells” il prossimo 20 giugno – e dei nuovi lavori di Gonjasufi e di Flying Lotus, tra le rivelazioni dell’anno passato, l’etichetta di Sheffield ospita il sorprendente ritorno dei Seefeel.
Quindici anni di pausa, interrotti unicamente da un Ep dello scorso autunno, peraltro nulla di eccezionale, per questo eponymous che invece eccelle per qualità e intensità.
Lunghe composizioni metalliche e dissonanti, come l’eccezionale singolo “Dead Guitars”, la cui trama gelida e industriale è a tratti squarciata dalla voce dreamy di Sarah Peacock, che eleva anche “Airless”, oppure le tessiture elettroniche di “Rip Run” (Aphex Twin, Boards Of Canada) e “Faults” (Autechre).
Notevole.
Restando nel campo dell’elettronica, segnaliamo inoltre il clamore suscitato dal terzo album degli australiani Cut Copy, da Melbourne, che – nome omen – fanno del “taglia e incolla” il loro manifesto artisitico: nel singolo “Take Me Over” assemblano, con esiti francamente raccapriccianti, addirittura un brano di Madonna e con uno dei Fleetwood Mac, mentre in “Where I’m Going” l’incipit è quello di “I’m Waiting For The Man” dei Velvet Underground. Sacrilegio.
Il loro sound è elementare e si ispira agli anni Ottanta, in particolare alla dance sintetica di New Order e Pet Shop Boys.
Si salvano un paio di episodi e l’iniziale “Need You Now”, che per la verità non suona nuova alle nostre orecchie.
Dove l’abbiamo già sentita?
lunedì 13 giugno 2011

Quando il nostro recensore di fiducia, CJ, ha lasciato spazio a Big per l'ultima strepitosa opera di Vinicio Capossela, ho pazientemente aspettato il mio turno. Che è arrivato, per mia iniziativa, con il quarto album degli Arctic Monkeys, tra le band più amate e allo stesso tempo detestate della scena inglese: un disco attesissimo dopo il deludente Humbug, disco della presunta maturità artistica e svolta hard non del tutto riuscita.
Come sempre è il web, che li portò a vendere un milione di copie dell'album di debutto senza alcuna campagna di lancio e in puro stile indie, il canale di diffusione preferito dal quartetto inglese, sul cui sito ufficiale è possibile ascoltare gratuitamente l'album.
Diciamolo subito, nonostante la forte tentazione di replicare alle consuete stroncature esagerate di parte della critica musicale, non riesco proprio a parlare di disco epocale.
Suck It And See è un disco che promette bene con un incipit formidabile, l'apertura dell'indovinata ballata psichedelica She's Thunerstorm, ma - pur rimanendo su uno standard accettabile - non mantiene del tutto le promesse, alternando pezzoni stoner (Brick by Brick, sgangheratamente retrò, e la cupa, potente ma non geniale Don't Sit Down Cause I've Moved Your Chair) a melodie più indovinate (Reckless Serenade, un pò brit pop e un pò R.E.M., Piledirver Waltz, That's Where You're Wrong e la title-track Suck It All And See, alla Morrissey).
Alex Turner racconta di essersi ispirato ad artisti come Nick Cave, John Cale, Lou Reed, David Bowie e Leonard Cohen.
Esagerato.
Però si coglie un tentativo di svolta verso la canzone d'autore, un paradosso se si analizzano invece i testi all’insegna del nonsense e l’assoluto disimpegno, forse suggerito dal soggiorno in California per la registrazione del disco, con la supervisione di James Ford.
La solarità e le sonorità della Orange County - psichedelia, atmosfere surf e il sound melanconico e struggente di gruppi come Red House Painters e American Music Club - si scorgono infatti dietro le chitarre e i coretti di Suck It And See.
Il titolo dell'album sta suscitando qualche polemica negli States – almeno nelle zone piu’ puritane e bacchettone degli States - dopo che alcuni negozi hanno deciso di censurarlo o addirittura di non metterlo in vendita. “Certi supermarket ci hanno detto che il titolo del disco è irrispettoso e maleducato. Pensano che sia incivile, così in America in alcuni negozi ci metteranno sopra un adesivo, un adesivo di quelli grossi”, ha spiegato Turner.
Operazione tutt’altro che facile, dal momento che la cover, ispirata al White Album dei Beatles, è completamente bianca con il titolo nel mezzo.
Controcorrente David Letterman, che chiede alle scimmie artiche: "E' il classico disco per il Natale?", prima di lasciare la scena ai muri di chitarre delle scimmie artiche.
I wanna rock'n'roll brick by brick.
DJ Paulette
mercoledì 8 giugno 2011
“Non c’è gusto in Italia ad essere intelligenti”: era il titolo di un album degli emiliani Skiantos, album tutt’altro che indimenticabile ma che conteneva un pezzo cult come “Sono un ribelle mamma”, sulla stessa falsariga di “Sui giovani d’oggi ci scatarro su” degli Afterhours.
Ci viene in mente quel titolo ascoltando il nuovo lavoro di Daniele Silvestri, intitolato S.C.O.T.C.H. e con in copertina lo stesso Silvestri appiccicato a un muro intonacato di rosso grazie a un bel pò di nastro adesivo.
Ci piacciono infatti l’intelligenza e l’ironia che traspaiono da questa opera matura del cantautore romano, il suo impegno non urlato – così lontano dagli inni caciaroni di alcuni - e il suo senso della misura – così lontano dalla verbosità eccessiva di altri. Persino le tante collaborazioni in questo caso non appesantiscono un’opera fresca, leggera, gradevole.
Il disco si apre con l’intimità di “Le navi” e con un duetto quasi britpop con l’amico Niccolò Fabi in “Sornione”, che si risolve in un delizioso amalgama di voci e di umori: “Non è prevista l'onestà/e se ti guardi intorno/mi darai ragione/e va di moda la sincerità/ma solo quando/è urlata alla televisione”.
“Cos’è questa cosa qua” ha un tono scanzonato e naif alla Samuele Bersani – un altro dei piu’ bravi della loro generazione – e la successiva “Fifty Fifty” è invece una delle sue classiche filastrocche.
L’album entra nel vivo con la ballata “Acqua stagnante” – tra i brani migliori insieme a “Acqua che scorre”, che si avvale della voce tagliente di Diego Mancino – e con quella “Precario è il mondo” già sentita in tv da Fazio e Saviano (qui con Raiz, ex-voce degli Almamegretta).
Dopo un paio di cover da Paoli (divertente “La gatta” trasformata in “La chatta”, con tanto di telefonata allo stesso Paoli che poi fa un cameo) e da Gaber (“Io non mi sento italiano”, per tornare all’incipit di questa recensione…), parte il rock di “Monito(r)”, che ha un bel tiro e auspica la ribellione della penna del presidente Napolitano, al momento della firma in calce a leggi e decreti ad personam.
E ancora: il singolo “Ma che discorsi”, la title-track con la voce recitante di Servillo e Camilleri, un paio di episodi minori e infine l’amaro epilogo di “Questo paese”, impreziosito dal piano di Stefano Bolllani: “Non c'è nei discorsi di chi vado a votare/
se grandezza ce n'è non si riesce a vedere/così hai voglia a cercarla tra i mille canali/sia su quelli analogici che sui digitali/ma non serve aumentare la definizione/per vedere più grande un coglione”.
Ci viene in mente quel titolo ascoltando il nuovo lavoro di Daniele Silvestri, intitolato S.C.O.T.C.H. e con in copertina lo stesso Silvestri appiccicato a un muro intonacato di rosso grazie a un bel pò di nastro adesivo.
Ci piacciono infatti l’intelligenza e l’ironia che traspaiono da questa opera matura del cantautore romano, il suo impegno non urlato – così lontano dagli inni caciaroni di alcuni - e il suo senso della misura – così lontano dalla verbosità eccessiva di altri. Persino le tante collaborazioni in questo caso non appesantiscono un’opera fresca, leggera, gradevole.
Il disco si apre con l’intimità di “Le navi” e con un duetto quasi britpop con l’amico Niccolò Fabi in “Sornione”, che si risolve in un delizioso amalgama di voci e di umori: “Non è prevista l'onestà/e se ti guardi intorno/mi darai ragione/e va di moda la sincerità/ma solo quando/è urlata alla televisione”.
“Cos’è questa cosa qua” ha un tono scanzonato e naif alla Samuele Bersani – un altro dei piu’ bravi della loro generazione – e la successiva “Fifty Fifty” è invece una delle sue classiche filastrocche.
L’album entra nel vivo con la ballata “Acqua stagnante” – tra i brani migliori insieme a “Acqua che scorre”, che si avvale della voce tagliente di Diego Mancino – e con quella “Precario è il mondo” già sentita in tv da Fazio e Saviano (qui con Raiz, ex-voce degli Almamegretta).
Dopo un paio di cover da Paoli (divertente “La gatta” trasformata in “La chatta”, con tanto di telefonata allo stesso Paoli che poi fa un cameo) e da Gaber (“Io non mi sento italiano”, per tornare all’incipit di questa recensione…), parte il rock di “Monito(r)”, che ha un bel tiro e auspica la ribellione della penna del presidente Napolitano, al momento della firma in calce a leggi e decreti ad personam.
E ancora: il singolo “Ma che discorsi”, la title-track con la voce recitante di Servillo e Camilleri, un paio di episodi minori e infine l’amaro epilogo di “Questo paese”, impreziosito dal piano di Stefano Bolllani: “Non c'è nei discorsi di chi vado a votare/
se grandezza ce n'è non si riesce a vedere/così hai voglia a cercarla tra i mille canali/sia su quelli analogici che sui digitali/ma non serve aumentare la definizione/per vedere più grande un coglione”.
Iscriviti a:
Post (Atom)