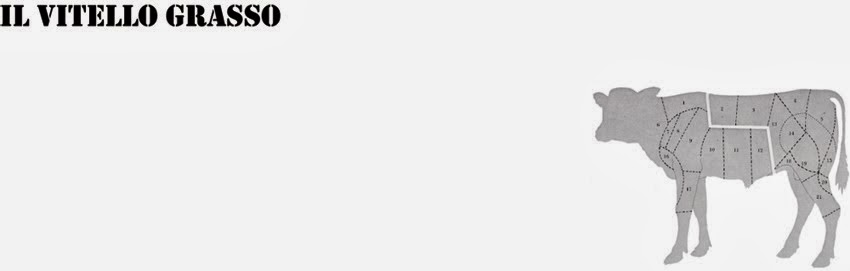20
JONSI – Go
Jonsi – vero nome: Jón Þor Birgisson - è il leader degli islandesi Sigur Ros, band tra le piu’ importanti dello scorso decennio. Al suo debutto solista, lo straordinario vocalist cerca di smarcarsi puntando su filastrocche bislacche e su un’immediatezza e una freschezza pop che lasciano il segno.
19
GONJASUFI - A Sufi And A Killer
Gonjasufi – vero nome: Sumach Valentine – è un personaggio alquanto strambo: rasta, insegnante di yoga, intellettuale mistico e inquieto, Dj ed ex-rapper, oggi artista di punta della scuderia WARP. La sua opera prima mescola con classe e irriverenza i piu’ disparati generi musicali: trip hop e blues-rock, elettronica vintage e disco-music, citazioni terzomondiste e acid-rock psichedelico, e lo fa con un’inclinazione rigorosamente lo-fi che fa pensare – oltre che a Frank Zappa - al primo, grandissimo, Beck.
18
FOUR TET – There Is Love In You
La categoria: elettronica anche nel 2010 vede una serie di ottimi lavori.
Notevoli l’ambient di Balmorhea e The Album Leaf, il drone di Yellow Swans e Pan Sonic, le alchimie groove e i campionamenti di Flying Lotus.
Su tutti, i Four Tet del capolavoro Angel Echoes: stupore allo stato liquido, anzi sonoro.
17
RADIO DEPT - Clinging To A Scheme
La Svezia si fa notare per una scena pop viva e vegeta (XX, Sonnets).
I Radio Dept sono un terzetto di Lund che ha dato alle stampe il terzo album verso l’inizio dell’anno, sull’etichetta apripista Labrador. Suonano un pop sofisticato e malinconico, senza grosse pretese o ambizioni, ma straordinariamente gradevole.
16
HINDI ZAHRA – Handmade
Originaria del Marocco, Hindi Zahra esordisce riproducendo in musica il melting pot culturale tipico del sud della Francia, nel quale le tradizioni arabe e berbere si fondono col sofisticato patrimonio del cantautorato di scuola transalpina.
15
AMPARO SANCHEZ - Tucson Habana
Dopo dodici anni alla guida degli Amparanoia, la cantante andalusa Amparo Sánchez intraprende la carriera solista chiedendo aiuto ai Calexico. Il risultato non poteva che essere eccellente: Tucson Habana è un disco elegante e raffinato, caratterizzato da una malinconica atmosfera latina appena venata da accenti jazz e blues.
14
VILLAGERS – Becoming A Jackal
Chi come noi si porta l’Irlanda nel cuore non può che rallegrarsi per questa opera prima del giovane dublinese Conor J. O’Brien, alias Villagers, che mette in mostra un delicato fraseggio folk e una grande freschezza e immediatezza comunicativa. Si ascolti la meravigliosa Pieces, il brano migliore di tutta la raccolta, sospesa tra un’atmosfera vagamente jazzy e una magistrale interpretazione vocale.
13
JOHN GRANT - Queen Of Denmark
I texani Midlake sono tra le bands piu’ attive del momento. Eccoli in veste di co-produttori dell’opera prima di John Grant, accolta oltreoceano dall’ovazione quasi unanime da parte della critica (5 stelle su 5 per Mojo): l’ex leader degli Czars è in effetti capace di scrivere ottime canzoni, chiaramente ispirate ai grandi classici del passato, prima di tutto il grande rock americano degli anni anni Settanta.
12
ERLAND AND THE CARNIVAL - Erland And The Carnival
Frettolosamente catalogato nel Psych-Folk d'oltremanica, questo debutto omonimo degli Erland & The Carnival è un’autentica rivelazione.
Abilissimi nel mischiare i generi e le influenze piu’ disparate, ripropongono un repertorio di traditionals rivisitati con intensità e originalità; a questo aggiungono alcune perle d’autore: su tutte Trouble In Mind, ovvero uno straordinario pezzo indie-pop che – in un mondo normale – resterebbe a lungo nelle classifiche e nelle heavy rotation di radio e tv.
11
NEIL YOUNG - Le Noise
Alienato e disturbato, a tratti persino paranoico, l’ennesimo disco del cantautore canadese è un ascolto tutt’ altro che scontato. Cavallo pazzo è senza percussioni, solo con la sua chitarra – mai così distorta – e con una sequenza di rumori, feedback, riverberi elettronici ed echi (aiutato da Lanois).
Noi di PiacenzaSera salutiamo dunque uno dei nostri eroi di sempre, apprezzandone il coraggio e la voglia di sperimentare, di mettersi continuamente in discussione.
10
PAUL WELLER – Wake Up The Nation
GORILLAZ – Plastic Beach
Il maestro che supera l’allievo, questa volta è proprio il caso di dirlo.
Convince di piu’ il vecchio e redivivo Weller, autentico monumento nazionale britannico, qui alle prese con una rabbia mai sopita e un sound graffiante (seppur nel segno della tradizione), che l’allievo Albarn con la sua celebre cartoon-band: Plastic Beach contiene una manciata di ottimi brani, ma nel complesso si distingue per una stucchevole parata di stelle e per il trionfo dell’eclettismo postmoderno piu’ modaiolo e cool.
09
CARIBOU – Swim
Canada sugli scudi: con Arcade Fire e Neil Young ben tre posizioni in classifica.
Caribou è artista eclettico e con la sua terza opera ci regala un vortice impressionante di suoni psichedelici, uno spazio fluido in continuo divenire, un caleidoscopio di emozioni allo stato puro.
08
HEY MARSEILLES - To Travel And Trunks
Bizzarra band composta da sette musicisti capelloni, gli Hey Marseilles propongono un folk orchestrale e rivolgono la loro attenzione alla grande tradizione celtica. Il loro disco d’esordio si rivela un ascolto piacevolissimo, oltre un’ora di ballate malinconiche rivisitate con piglio quasi progressive e/o con stile bucolico e naif, piuttosto dimesso ma non cupo: molto lontano dal clima spesso caciarone - e ad alto tasso alcolico - della scena indie-folk britannica.
07
JANELLE MONAE – The Archandroid
Mentre Pitchfork e Stereogum stanno per incoronare il rapper stronzissimo Kanye West e il suo My Beautiful Dark Twisted Fantasy come disco dell’anno – eccezionale il suo campionamento di 21 Century Schizoid Man dei King Crimson dell’opener Power - noi preferiamo puntare (per la verità niente male anche i Black Keys, che tuttavia neri non sono…) su questa ragazza di venticinque anni e la sua irresistibile miscela di r'n'b, pop, funk, soul.
Signori e signore, ecco la nuova regina della black music.
06
MICE PARADE – What It Means To Be Left-Handed
L’ottava fatica di Mice Parade, creatura solitaria del percussionista newyorchese Adam Pierce, è un lavoro impossibile da catalogare, frutto com’è di una miriade di influenze diverse e di spunti creativi apparentemente inconciliabili, ovvero il tentativo dichiarato di fondere in modo armonico la seriosità di etnica e jazz con l’immediatezza dell’indie piu’ alternativo (e sofisticato).
Da ascoltare assolutamente.
05
NATIONAL - High Violet
Il colore viola del titolo rappresenta alla perfezione il romanticismo tenebroso e crepuscolare della band ormai newyorkese, in breve assurta da icona indie a “classico” del nuovo rock made in USA. Pur avendo optato per una linea di sostanziale continuità con la consueta, raffinata miscela di post-punk, canzone d’autore e rock intellettuale, rispetto al recente passato il loro sound appare meno claustrofobico e teso, e vira verso suoni e arrangiamenti piu’ ariosi e sofisticati, addirittura epici.
04
MENOMENA – Mines
TU FAWNING - Hearts On Hold
La cosiddetta scena di Portland, Oregon è una delle piu’ belle notizie dell’anno.
In attesa del nuovo albo dei Decemberists - King is Dead, in uscita il prossimo gennaio – ecco due lavori eccezionali (la critica promuove anche i Typhoon, di cui ancora non sappiamo nulla). I piu’ navigati Menomena propongono un art-rock con inclinazioni progressive e pulsazioni etniche. I Tu Fawning, loro supporter durante l’ultimo tour USA, fanno ancora meglio, con un’opera dalle venature dark, con chitarre abrasive e fisarmoniche gitane, litanie trip-hop e cori terribilmente tetri.
Imperdibile/i.

03
ARCADE FIRE - The Suburbs
Ormai superstar dell’indie-rock, acclamati da pubblico e da critica specializzata, il collettivo di Montreal giunge al difficile traguardo del terzo album: stretti nell’insanabile dubbio tra una ripetizione di schemi già proposti e il rischio della ricerca di nuove sonorità, scelgono di non scegliere, e così facendo allungano oltre misura la durata dell’album, togliendo qualcosa alla spregiudicatezza e alla tensione emotiva degli esordi.
Tuttavia The Suburbs si fa piacevolmente ascoltare per il suo pop raffinato e per un riuscito amalgama folk/wave, oltre che per la descrizione – come in una sorta di concept album – di un paesaggio contemporaneo alienato e alienante, fatto di centri commerciali e di outlet, di autolavaggi e di svincoli autostradali, di vuoti e assolati piazzali d’asfalto, di immense aree di parcheggio e di schiere interminabili di villette a schiera.

02
SUFJAN STEVENS - All Delighted People (EP)
SUFJAN STEVENS - The Age Of Adz
Altra doppietta.
Sufjan Stevens non smentisce la sua fama di compositore folle e bizzarro, oltre che prolifico e prolisso, e se ne esce con un Ep da quasi un’ora di musica e, a distanza di pochi mesi, un maestoso album di oltre 75 minuti. Mentre il primo riprende gli schemi acustici del passato (straordinaria la title-track), il secondo rappresenta una svolta epocale: The Age Of Adz è un disco di musica elettronica. E’, per i fan del nostro, un autentico shock.
L’eccessiva lunghezza dell’album si riflette in qualche passaggio a vuoto, tuttavia la raccolta contiene passaggi fottutamente geniali, con i quali Sufjan raggiunge l’apice della magniloquenza e dell’autoreferenzialità. Un discorso a parte merita Impossible Soul, l’ennesima, lunghissima, suite - oltre 27 minuti! - una Supper’s Ready postmoderna caratterizzata da continui mutamenti d’atmosfera e da capovolgimenti di fronte, come in un grande collage barocco di citazioni.

01
BEACH HOUSE – Teen Dream
Sorpresa?
La verità è che per dodici mesi abbiamo aspettato l’album capolavoro che potesse scalzare dal gradino piu’ alto del podio questa strepitosa, ultima fatica dei Beach House, da Baltimora, uscita a febbraio per la mitica label indipendente Sub Pop.
Ma niente. Un ultimo ascolto, e – nemmeno il tempo di finirlo – ecco presa la decisione di proclamarlo album dell’anno.
La prima parte - quella che una volta avremmo chiamato la Side A - sfiora addirittura la perfezione. Che sequenza! Zebra, e il suo straordinario intro acustico, la fantastica ballata Silver Soul (i Cocteau Twins al rallentatore), il singolo dreampop Norway, poi Walk In The Park, con la voce di Victoria Legrand che ricorda davvero quella di Nico, e infine la delicata, pianistica, Used To Be.
E nella parte residua del disco si resta ad alti livelli, senza cadute di tensione o di stile sino alla conclusiva Take Care, velvettiana sino al midollo.