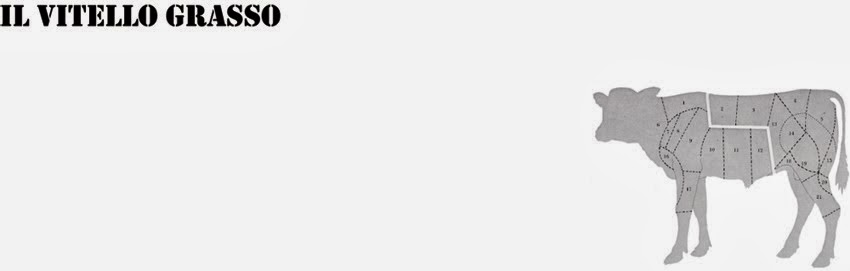mercoledì 28 settembre 2011
Prima che lui dica bah
Il ghiro è tornato.
Alle prime luci dell’alba, puntuale, inizia a rovistare nel sottotetto facendo un casino pazzesco e svegliandoci inesorabilmente.
E’ la sua stagione.
Saggezza popolare dice – che poi qui in paese i vecchi saggi iniziano a farsi dei bianchi alle sei del mattino e quando sono solo le undici più che saggi sono pieni marci – che sta facendo provviste per il lungo e gelido inverno che lo/ci attende. Pare che stia mettendo insieme una scorta di noci per tre-quattro mesi di letargo.
Astuto.
Astuto e coraggioso.
La pianta del noce dista almeno dieci metri dal tetto di casa mia, e l’unico collegamento tra di essi è un vecchio cavo del telefono posto a circa sei metri d’altezza. Me lo vedo, quel figlio di puttana, camminare sul filo come un equilibrista trascinando con sé - sospesa sopra la testa? - una noce ancora avvolta dal mallo.
Un lavoraccio, cazzo.
Resta il fatto che casino fa casino, che siano le noci che mette via o - se la saggezza popolare è solo leggenda - che si accontenti di rosicchiare le lastre di poliuretano espanso o le cantinelle di abete grezzo della copertura.
La reazione c'è stata, ed è stata dura. Dura e decisa.
L’altro ieri ho scagliato sul tetto una dozzina almeno di esche velenose, potentissime: una di quelle è in grado di squarciargli lo stomaco in pochi minuti e - prima che lui dica bah - polverizzargli poi tutti gli organi vitali. Brutta fine. Roba da pazzi sadici, lo ammetto. Ma è una guerra senza esclusione di colpi.
Tanto non ottengo alcun effetto.
Ci credo, Cristo, sono bustine dall’inquietante color azzurrognolo, davvero non si vede perché lo stronzo dovrebbe essere attratto da quella roba così sgargiante e un tantino psichedelica. A meno che non sia un ghiro tossico, un ghiro dal sorriso sdentato e appassionato di trip lisergici e pasticche colorate varie.
La verità, dicono sempre i vecchi saggi, è che non bisogna toccare le esche con le mani, così facendo i piccoli bastardi di roditori – che siano topi o ghiri – sentono l’odore dell’umano e non si lappano l’inquietante bustina dal colore azzurrognolo.
Dunque dovrò riprovare usando i guanti di lattice, come un infermiere, e magari una fionda artigianale per arrivare più in lato sul tetto.
Che poi, a pensarci bene, a un ghiro così astuto e coraggioso ci sarebbe da pagargli un bianchino, quell’ortrugo ormai sgasato per via del tappo di plastica che una volta si usava per le bottiglie della minerale, altro che esche velenose.
sabato 24 settembre 2011

La leggenda dei Jethro Tull e di Ian Anderson ha inizio, nel nostro paese, nel febbraio del 1971.
L’Italia è in quel periodo terra di conquista per gli alfieri del cosiddetto progressive rock britannico, nelle sue varie declinazioni: dal filone sinfonico/classico (Yes, EL& P, Gentle Giant, Procul Harum) a quello più politicamente impegnato e con venature jazzy (King Crimson, Family); anche se, in generale, Woodstock è lontana - le manifestazioni studentesche anche - e il si vive un periodo di riflusso che culminerà negli anni di piombo.
Numerosi rappresentanti del genere – tra i migliori i primi Genesis di Peter Gabriel, i Van der Graaf Generator di Peter Hammill e i King Crimson di Robert Fripp – fecero molta fatica ad affermarsi in casa propria, e tuttavia il loro teatro barocco e artistoide, fatto di tastiere e complessi arrangiamenti orchestrali, in poco tempo sbancò le charts in Svizzera, Belgio, Olanda e Italia, dando vita tra l’altro a una fioritura di ottimi gruppi nostrani (da noi Il Banco del Mutuo Soccorso, Il Rovescio della Medaglia, Le Orme e – con sfumature diverse – band storiche come la Premiata Forneria Marconi e gli Area di Demetrio Stratos).
Il primo febbraio 1971 i Tull suonano, per la prima volta in Italia, al Teatro Smeraldo di Milano, davanti a 4.000 fans rapiti ed estasiati.
Sino ad allora, erano usciti tre album - This Was (1968), Stand Up (1969) e Benefit (1970) – che avevano suscitato l’interesse di un pubblico ancora ristretto e che restavano, tutto sommato, nel campo blues-rock.
Nonostante il fumo dei lacrimogeni e gli scontri, all’esterno del teatro, tra gruppi di autonomi e forze dell’ordine, la serata milanese si rivela un autentico trionfo per la band di Blackpool.
Al centro dell’attenzione di tutti, ovviamente, il leader Ian Anderson e il suo piffero magico – è un flauto traverso - e il suo look eccentrico: pastrano a scacchi, fuseau neri e stivali scamosciati e stringati.
Il concerto si apre con una versione acustica di My God, uno dei vertici della loro carriera e uno dei pezzi trainanti del nuovo album Aqualung - che ancora non è uscito nei negozi per l’etichetta Chrysalis - ovvero la storia drammatica ed aspra di un clochard (il barbone raffigurato sulla celebre copertina assomiglia molto allo stesso Anderson) in un contesto urbano squallido e assai degradato, popolato da ladri e puttane ("Sitting on a park bench, eyeing little girls with bad intent"): la mini-suite non è altro che l’ultimo rantolo rabbioso di Aqualung in punto di morte, e contiene guidizi sarcastici e sprezzanti nei confronti della "sanguinosa Chiesa d'Inghilterra”: The bloody Church of England in chains of history requests your earthly presence at the vicarage for tea.
I nuovi brani vengono eseguiti da una band in autentico stato di grazia: lunghe cavalcate con improvvisi cambiamenti di scena e di ritmo, sfrenate jam intervallate da intervalli acustici: la straordinaria Locomotive Breath e Cross-Eyed Mary, oltre naturalmente alla title-track, il ritratto proletario di Up To Me e la sarcastica Hymn 43, e poi il repertorio tratto dalle opere precedenti: Nothing is Easy, Bouree e Jeffrey Goes To Leicester Squeare. Il live-asct si conclude con una strepitosa versione di Wind Up, altro atto di accusa nei confronti di Dio ("He’s not the kind you have to wind up on Sundays/Non è il caso disturbarlo di Domenica")
Quello dei Jethro Tull è un prog assolutamente atipico, capace com’è di amalgamare l’hard-rock degli Zeppelin – il riff di chitarra di Acqualung è uno dei riff definitivi della storia del rock – con la classica e con il jazz, ma in primo luogo con il folk e la grande tradizione blues: l’attaccamento alla radici è testimoniato anche dall’incoinsueta scelta del nome, ispirata dal pioniere della moderna agricoltura, l'agronomo Jethro Tull (1674-1741).
Dopo Aqualung verranno altri ottimi lavori – il concept album Thick As A Brick (1972) e altri episodi minori; insomma, quello fu il momento magico, e dopo quel momento nulla fu come prima.
martedì 20 settembre 2011

C’era la Swinging London degli anni Sessanta.
Le minigonne.
I Beatles e gli Stones.
C’erano le epiche battaglie tra Rockers e Mods.
E pensare che noi trenta-quarantenni ci siamo dovuti accontentare dei litigi tra i fratelli Gallagher (sic!) o di qualche loro scazzo con Albarn, ovvero ciò che la Cool Britannia dell’epoca Blair ci ha saputo offire.
Ma il bel volume di Eleonora Bagarotti sugli Who – ovvero: Pete Townshend (chitarra), Roger Daltrey (voce), John Entwistle (basso) e Keith Moon (batteria) - edito recentemente da Arcana, oltre e a restituire l’atmosfera vibrante della Swinging London, passa meticolosamente in rassegna tutti i testi della storica band britannica, aggiungendo alle traduzioni anche una serie di commenti e di aneddoti che ci fanno entrare nel loro mondo e che si rivelano assai utili al fine di svelare la genesi delle canzoni.
In alcuni casi, contribuisce persino a smitizzare gli inni (o anti-inni) generazionali degli esordi, da I Can’t Explain alla celeberrima My Generation, senza tuttavia sminuirne la portata storica (“già solamente con questo brano”, scrive la Bagarotti riferendosi alla seconda, “gli Who hanno impresso un’indelebile orma sulla vetta del mondo musicale”).
Troppi significati sono stati dati a My Generation, lamenta infatti Townsend, che precisa: “è una canzone contro l’ipocrisia e il perbenismo. Due atteggiamenti che ho sempre detestato”.
Resta il fatto che, chiosa Eleonora, in un’era che ancora risentiva dei coretti beat e in cui Beatles e Stones erano alle prese con storie d’amore, il balbettio di Daltrey, la furia della band e versi come: “La gente cerca di metterci sotto/solo perché ce ne andiamo in giro/Le cose che fanno sono terribilmente fredde/spero di morire prima di diventare vecchio”, non potevano non scatenare un immediato effetto di immedesimazione in tantissimi ragazzi, che vi videro il riflesso del proprio malessere.
Il lavoro ripercorre le varie tappe della carriera degli Who dedicando spazio, ovviamente, al primo concept-album, The Who Sell Out (1967), che imita le trasmissioni di una radio pirata, con stacchi pubblicitari compresi: celebre quello degli Heinz Baked Beans, già omaggiati da Warhol dalla Pop Art.
E ovviamente alle due rock-opera Tommy (1969) – chi scrive è particolarmente affezionato alla storia del bambino cieco, sordo e muto che diventa un campione di flipper, avendo visto il film per la prima volta al cinema Jolly quando aveva solo dieci anni, accompagnato dal fratello maggiore (chissà cosa gli stava passando in testa?) - e Quadrophenia (1973), sull’epopea Mods.
Tra i nostri must, Baba O’Riley, ovvero uno dei brani forti di Who’s Next (1971), forse l’album più celebrato.
Com’è noto, si voleva omaggiare lo spiritualismo di Meher Baba e al contempo celebrare uno dei musicisti che piu’ avevano influenzato la band: Terry Riley, padre del minimalismo. Meno noto è il processo creativo – piuttosto casuale – alla base del leggendario intro di synth, che apprendiamo dalle pagine di questo prezioso volume tramite la ricostruzione di Townsend: “Ho scritto il brano mentre stavo giocando a fare sperimentazioni con i nastri e il sintetizzatore. C’era l’idea di scegliere una persona tra il pubblico e chiederle informazioni personali – altezza, peso, segno zodiacale – e metterli nel sintetizzatore. Il mio progetto era tradurre un essere umano in musica. Nella canzone ho programmato i dettagli della vita di Meher Baba, e il risultato è diventato il tema iniziale e di sottofondo di Baba O’Riley”.
Discorso analogo per il ritornello – It’s only teenage wasteland/E’ solo un deserto di adolescenti – che è nato riprendendo una frase di un fotografo a un roadie della band, intento a raccogliere un mare di rifiuti dopo un concerto all’Isola di Wight.
Più arduo invece fare chiarezza sul vero significato di Won’t Get Fooled Again (più o meno: non ci prenderete più per il culo), ovvero il testo più discusso e chiacchierato della loro lunga carriera. Spesso etichettato come un brano reazionario - per il rifiuto di Townsend di fare la rivoluzione, per l’atmosfera disillusa lontana anni luce dall’idealismo hippie, e anche per il suo epilogo di marca orwelliana: ”ti presento il nuovo padrone/è uguale al vecchio” - è stato tuttavia adottato dagli operai inglesi durante le loro rivendicazioni sindacali. “Tutti a dirmi che dovevamo avere un ruolo politico, di combattere il capitalismo e finanziare certe comunità (Townsend aveva dovuto subire pesanti critiche per aver allontanato in malo modo Abbie Hofmann, attivista politico di sinistra, che era salito sul palco a Woodstock interrompendo l’esibizione dei Who). Con quella canzone volevo solo dire alle persone che mi dicevano cosa fare: andatevene a fare in culo!”, ammette oggi Townsend. Che, in tempi recenti, ha negato a Michael Moore l’utilizzo del brano per la soundtrack di Farenheit 9/11 e, ai laburisti che gli hanno chiesto di poterlo utilizzare in campagna elettorale, ha risposto: “Sì, ma solo se mi permettete di cambiare tutti i versi”.
Un’ultima cosa, un consiglio per i neofiti degli Who: andate a cercarvi una copia di Live At Leeds, 1970, uno dei piu’ grandi dischi migliori di sempre, nell’edizione deluxe.
Per alcuni critici il migliore di sempre: una scaletta da brividi e un’esecuzione secca e potente, ineguagliabile.
John/Jack Frusciante è di nuovo uscito dal gruppo – stavolta a Enrico Brizzi importa poco, impegnato com’è nei suoi pellegrinaggi laici sulla Via Francigena – ma il gruppo ha deciso di continuare. Sostituito l’ormai ex-figliol prodigo con il trentenne Josh Klinghoffer, già nella line-up della band californiana durante l’ultima tournee e un viso da sbarbatello che poco si addice a quei vecchi figli di puttana dei suoi nuovi compagni di viaggio, dopo cinque anni di silenzio manda alle stampe un nuovo album, presentato in anteprima il 30 agosto a Colonia con un live-act ripreso in alta definizione e trasmesso in oltre 900 sale cinematografiche di tutto il mondo. Bizzarrie del marketing.
Un’ora abbondante di funky e pop, non particolarmente ispirato, assai lontano dalla furia sfrontata degli esordi e forse nemmeno dettato da un’urgenza incontenibile; preciso e patinato, maybe per colpa di un Rubin da sempre in cabina di regia (è pur sempre garanzia di una continuità con il passato illustre); anche se, tutto sommato, I’m With You suona meno anonimo e piatto del precedente Stadium Arcadium.
Tra i quattordici pezzi della raccolta, un posto di primo piano spetta ai ritornelli facili e ruffiani e però irresistibili – “il mitico ritornello, che poi è sempre lo stesso e che non lascia neanche più disorientati o peggio schifati, tanto poi ti ritrovi a cantarlo mentre ti fai la barba”, scrive Ondarock.it – come in Factory Of Faith, Ethiopia o nel singolo The adventures of Rain Dance Maggie, già in heavy rotation su MTV e Virgin Radio.
Ma le cose migliori – in mezzo a parecchi episodi senza storia - sono a nostro giudizio le ballate Police Station e Brendan’s death song, dedicata ad un amico del gruppo recentemente scomparso, proprietario del LA Nightclub che fece praticamente esordire la band, e la beatlesiana, pianistica, Happiness Love Company.
martedì 6 settembre 2011
La lunga pausa estiva consente al recensore di tirare un po’ il fiato e anche di recuperare alcuni dischi usciti nella prima metà dell’anno e inevitabilmente – datane l’immensa mole - sino a ora trascurati. E’ innegabile, infatti, che le nuove tecnologie e il trionfo del web abbiano provocato (o accelerato) l’attuale crisi del mercato discografico; il rovescio della medaglia è che la possibilità di far ascoltare facilmente il proprio lavoro a un gran numero di persone sparse per il mondo incentiva e stimola un’enorme e costante diffusione di bands e artisti di interesse.
Tra essi, gli Wild Beasts arrivano da Kendal, profondo Galles, e suonano un pop sensuale ed elegante, a volte persino un po’ stucchevole, di chiara ispirazione romantic rock. Degna di nota la performance del cantante Hayden Thorpe: la sua voce da tenore è sempre in primo piano. Albatross come primo singolo è una scelta poco felice, noi preferiamo Loop the Loop e la conclusiva End Come Too Soon.
In ambito indie-folk, segnaliamo le nuove uscite per Leisure Society e Dodos.
I primi sono da tempo attivi nel Wilkommen Collective, la "comune musicale" di stampo progressista e new-hippy della scena di Brighton, e con il loro secondo lavoro (“Nell’acqua scura”) aprono il campo a sonorità piu’ ariose e ad arrangiamenti piu’ complessi; ottima la title-track, accompagnata dall’ukulele.
I secondi, californiani di San Francisco, con No Color (c’è una strana affinità tra i titoli di questi album…) ripropongono la loro consolidata ricetta, un folk corale dolce e umorale che si rivelerà – ne siamo certi - un’ottima colonna sonora per l’autunno che incombe.
Per ultimi i Luup, ovvero un collettivo sorto attorno al flautista greco Stelios Romaliadis che ha stregato gran parte della critica e che può vantare una serie infinita di illustri collaboratori. E’ un disco difficile, un ambient di stampo cameristico che lascia poco spazio alla melodia; i “rituali del pascolo”, assai flebili, suonano allo stesso tempo sinistri e magici.
Ci vorrà del tempo per digerirli.
Tra essi, gli Wild Beasts arrivano da Kendal, profondo Galles, e suonano un pop sensuale ed elegante, a volte persino un po’ stucchevole, di chiara ispirazione romantic rock. Degna di nota la performance del cantante Hayden Thorpe: la sua voce da tenore è sempre in primo piano. Albatross come primo singolo è una scelta poco felice, noi preferiamo Loop the Loop e la conclusiva End Come Too Soon.
In ambito indie-folk, segnaliamo le nuove uscite per Leisure Society e Dodos.
I primi sono da tempo attivi nel Wilkommen Collective, la "comune musicale" di stampo progressista e new-hippy della scena di Brighton, e con il loro secondo lavoro (“Nell’acqua scura”) aprono il campo a sonorità piu’ ariose e ad arrangiamenti piu’ complessi; ottima la title-track, accompagnata dall’ukulele.
I secondi, californiani di San Francisco, con No Color (c’è una strana affinità tra i titoli di questi album…) ripropongono la loro consolidata ricetta, un folk corale dolce e umorale che si rivelerà – ne siamo certi - un’ottima colonna sonora per l’autunno che incombe.
Per ultimi i Luup, ovvero un collettivo sorto attorno al flautista greco Stelios Romaliadis che ha stregato gran parte della critica e che può vantare una serie infinita di illustri collaboratori. E’ un disco difficile, un ambient di stampo cameristico che lascia poco spazio alla melodia; i “rituali del pascolo”, assai flebili, suonano allo stesso tempo sinistri e magici.
Ci vorrà del tempo per digerirli.
Iscriviti a:
Post (Atom)