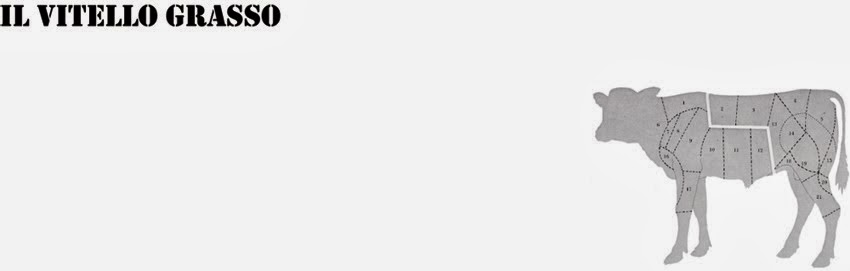lunedì 31 gennaio 2011
100.000 lire
Non avevamo trovato biglietti in prevendita, e allora eravamo partiti dal bar assai presto. Nell’abitacolo della vecchia utilitaria regnava un alone di pessimismo. Era la prima volta dei Pearl Jam in Italia: tutto esaurito da mesi. Ma noi si era deciso di andare su a Milano lo stesso. Vediamo come butta, ci eravamo detti. Una volta arrivati, neanche il tempo di parcheggiare e Big ti acquista da un bagarino quattro biglietti al modico prezzo di centomila lire l’uno, che a quei tempi – era appena uscito Vitalogy, nel 1994, se non ricordo male - con un centino ci facevi il signore un mese, se non avevi vizi particolari: una briscola in cinque ogni tanto e i gintonic della Pieve il sabato sera. Cazzo, Big, potevamo almeno parlarne prima, mi ero lamentato senza troppa convinzione, mentre lui silenziosamente soddisfatto, coi nostri biglietti in tasca, si dirigeva verso l’ingresso al palazzetto.
D’altro canto era il nostro periodo grunge: capelli lunghi sino alle spalle e camicie di flanella a quadri scozzesi comprate sul mercato, che ancora adesso sono buone per andare a funghi. A quei tempi, un Ep in vinile colorato di Touch I’m Sick dei Mudhoney, noi si era capaci di spendere una fortuna.
Inutile dire che non ci pentimmo affatto.
E’ con questi ricordi appena sfocati in testa che mi accingo ad ascoltare questo nuovo (ennesimo) live della band di Seattle, dato alle stampe per festeggiare il ventesimo compleanno a quasi tredici anni di distanza dal suo celebre predecessore, Live On Two Legs, ovvero il loro primo disco dal vivo ufficiale (con il quale, particolare curioso che ai fan piu’ accaniti non sfuggirà, non condivide alcun brano in scaletta). Tredici anni durante i quali Vedder e soci hanno pubblicato una serie impressionante di concerti, bootleg, performance acustiche.
C’era poco da aggiungere, quindi, e per questo la scelta dei pezzi è poco ortodossa: tutt’altro che un “Best Of”, Live On Ten Legs privilegia i rock’n’roll tirati e adrenalinici, per la gioia dei patiti del pogo: su tutti i classici Animal e Rearviewmirror (da Vs, 1993), Spin The Black Circle (da Vitalogy, 1994) e State Of Love And Trust (dalla soundtrack di Singles, 1991). Pesca poi ad ampie mani nel repertorio piu’ recente, con ben quattro brani dall’ultimo album Backspacer (bene Unthought Known e la ballata acustica Just Breathe), una sporca World Wide Suicide dal penultimo omonimo del 2006 e le riflessive I Am Mine e Nothing As It Seems, per recuperare solo nel finale i fasti degli esordi con il fantastico tris Alive, Jeremy e Porch. C’è spazio infine per le cover, a dire il vero non indimenticabili: Arms Aloft di Joe Strummer (Clash) in apertura e Public Image dei P.I.L., la creatura di John Lydon post Sex Pistols: come a dire, veniamo proprio da lì, dal punk.
Qualcuno, sul web, storce il naso.
Io davvero non lo capisco, quel qualcuno: i Pearl Jam sanno fare bene i Pearl Jam, cos’altro dovrebbero fare?
Qualcuno insiste cioè a dire che da decenni non fanno altro che canonizzare se stessi, riproponendo la solita minestra della nonna. Mah, forse perché il mio povero nonno non era davvero un drago in cucina – per dirne una: mescolava lo sciroppo di tamarindo con quello di orzata per ottenere un orrendo beverone -, noi da quella nonna ci andremmo tutti i giorni, a mettere le gambe sotto il tavolo.
sabato 22 gennaio 2011
Pronti:via!, ed ecco il primo grande album del 2011.
Abbandonate le velleità progressive e la ricerca di nuove e piu’ complesse sonorità che avevano caratterizzato il pur ottimo The Hazards Of Love (2009), i Decemberists – una curiosità: la loro sigla non deriva, come era presumibile, dal mese di dicembre, bensì dal nome dei rivoluzionari russi che nel 1925 si ribellarono allo zar – riscoprono le radici e l’amore per la tradizione.
Una sorta di Bringing It All Back Home, insomma.
A questo scopo si ritirano nella tranquillità agreste di un granaio ai piedi del monte Hood, nei pressi della loro Portland – la stessa Portland che recentemente ha portato alla ribalta bands come Menomena, Tu Fawning e Phoenix – e danno alla luce The King Is Dead (omaggio agli Smiths), un album di classico folk-rock, apparentemente semplice, ma di grande immediatezza e impatto emotivo.
Si parte alla grande con Don’t Carry It All, poi Calamity Song è la prima, esplicita ammissione dell’adorazione per il jingle-jangle dei Byrds e dei primi R.E.M. (pare uscire da Murmur o da Reckoning; e infatti Peter Buck collabora in tre pezzi) e Rise To Me è una languida ballata in stile Nashville (Gram Parsons).
Con un disinvolto copia e incolla, Rox In The Box ripropone nel mezzo un’aria in stile Irish Heartbeat, e le successive January Hymn e June Hymn si reggono su delicati arpeggi di chitarra Gibson.
E’ una profusione di mandolini, fise e armoniche a bocca, tra Young, Dylan e Springsteen: prendete l’intro del potente (e bellissimo) singolo Down By The Water, par di sentire The Promised Land.
All Arise! è invece quasi una cover dei Creedence, e prima della conclusiva, malinconica Dear Avery (Red House Painters) c’è ancora tempo per un perfetto brano pop come This Is Why We Fight.
Girerà a lungo sui nostri Ipod.
Il progetto Captain Spock nasce dall’inattesa (tardiva?) fusione tra Sagrada Familia e Perla Madre, bands attivissime sulla scena piacentina nella seconda metà degli anni ’90.
La line-up ufficiale comprende infatti il songwriter Romolo Stanco alla voce, dobro e chitarre varie, Paolo Stabellini alle chitarre elettriche, Enrico Scotti alla batteria, Alberto Callegari al basso, Andrea Cravedi e Giorgio Tartaro, volto televisivo di Leonardo su SKY, alla chitarra classica.
La geografia del sestetto resta in territori già battuti - soprattutto dai Sagrada Familia -ovvero il rock americano della grande tradizione roots (ascolare The Seagulls Show The Way e Birthday Show, quasi country), seppur rivisitato in chiave contemporanea alla maniera di mostri sacri quali Eels, Calexico e Cake.
Il loro album di debutto – registrato allo Studio Elfo di Tavernago e rimasterizzato addirittura in California - parte quasi sottovoce, con la blueseggiante Miracles, per prendere immediatamente quota con l’ottimo e solido rock chitarroso – tra Tom Petty e Screaming Trees - di Jack&Devil e Derogatory. Ma c’è spazio anche per malinconiche ballate acustiche (The Peaceful Place I Miss e Climbing Up A Star, che sembrano essere influenzate dal Vedder di Into The Wild), mentre un arrangiamento elegante e raffinato tiene in corsa anche i pezzi piu’ radiofonici come Two ed Everyday. Un cenno a parte per la conclusiva ed eclettica I Came From Mars, e per Dr Beginner, che inizia con un parlato alla Lou Reed e termina in un fantastico pezzone grunge, a nostro giudizio il brano migliore dell’intera raccolta.
Ignorance, tuttavia, non vuole essere solo un disco.
Durante le esibizioni live, al pubblico viene offerto quello che è apparentemente un packaging “da disco in vinile”, realizzato in cartone riciclato e customizzato da noti artisti e writers (il primo è stato Emiliano Cataldo), all’interno del quale si trova una t-shirt disegnata dal designer Romolo Stanco con un QR code stampato sulla nuca che permette, con un semplice scatto fotografico, il download gratuito dell’intero album. Un’idea geniale.
La line-up ufficiale comprende infatti il songwriter Romolo Stanco alla voce, dobro e chitarre varie, Paolo Stabellini alle chitarre elettriche, Enrico Scotti alla batteria, Alberto Callegari al basso, Andrea Cravedi e Giorgio Tartaro, volto televisivo di Leonardo su SKY, alla chitarra classica.
La geografia del sestetto resta in territori già battuti - soprattutto dai Sagrada Familia -ovvero il rock americano della grande tradizione roots (ascolare The Seagulls Show The Way e Birthday Show, quasi country), seppur rivisitato in chiave contemporanea alla maniera di mostri sacri quali Eels, Calexico e Cake.
Il loro album di debutto – registrato allo Studio Elfo di Tavernago e rimasterizzato addirittura in California - parte quasi sottovoce, con la blueseggiante Miracles, per prendere immediatamente quota con l’ottimo e solido rock chitarroso – tra Tom Petty e Screaming Trees - di Jack&Devil e Derogatory. Ma c’è spazio anche per malinconiche ballate acustiche (The Peaceful Place I Miss e Climbing Up A Star, che sembrano essere influenzate dal Vedder di Into The Wild), mentre un arrangiamento elegante e raffinato tiene in corsa anche i pezzi piu’ radiofonici come Two ed Everyday. Un cenno a parte per la conclusiva ed eclettica I Came From Mars, e per Dr Beginner, che inizia con un parlato alla Lou Reed e termina in un fantastico pezzone grunge, a nostro giudizio il brano migliore dell’intera raccolta.
Ignorance, tuttavia, non vuole essere solo un disco.
Durante le esibizioni live, al pubblico viene offerto quello che è apparentemente un packaging “da disco in vinile”, realizzato in cartone riciclato e customizzato da noti artisti e writers (il primo è stato Emiliano Cataldo), all’interno del quale si trova una t-shirt disegnata dal designer Romolo Stanco con un QR code stampato sulla nuca che permette, con un semplice scatto fotografico, il download gratuito dell’intero album. Un’idea geniale.
venerdì 14 gennaio 2011
Filastrocche bislacche
di Marina, con un cut'n'paste dal mio classificone di fine anno:
Il personaggio è alquanto strambo, e con irriverenza mi apostrofa - There Is Love In You – il mio è stupore allo stato liquido, anzi sonoro.
Siamo in un locale, affollato, sottofondo di chitarre abrasive e fisarmoniche gitane, litanie trip-hop e cori terribilmente tetri.
La mia amica, la nuova regina della black music, è in bagno a rifarsi il trucco e mi ha lasciata sola in questo spazio fluido in continuo divenire, dove la gente cambia a ogni secondo, e sembran tutti creature solitarie impossibili da catalogare.
Questo però è diverso, pavento sia alienato e disturbato, a tratti persino paranoico, perché i suoi occhi ti guardano ma non sembra mica ti vedano veramente, chissà in quale vortice impressionante di suoni psichedelici è aggrovigliata la sua mente. Il suo abbigliamento lo si potrebbe definire bucolico e naif, piuttosto dimesso ma non cupo, invero originale. Non puzza, e questo è già una notizia in questo posto. Perché siamo in un posto fuori mano, il centro città è lontano e se guardo fuori dalle vetrate un po’ sporchine vedo un paesaggio contemporaneo alienato e alienante, di fronte un centro commerciale col suo bel parcheggio e a fianco un autolavaggio, più in là un groviglio di svincoli autostradali, dietro si lasciano immaginare le schiere interminabili di villette a schiera. Siamo finite qua alla ricerca dell’ultimo amore perduto della regina, lei d’altronde si innamora spesso, a modo suo con freschezza e immediatezza, poi la prende sempre nel culo, ma senza tema di smentite si può affermare che nelle sue storie non manca mai di intensità e originalità, mai una caduta di tensione o di stile.
Io la prego sempre di trovare un soggetto un cicinino meno claustrofobico e teso di quelli che con cui si accoppia di solito, magari più sofisticato e malinconico. Ma lei niente, le sue storie nascono e muoiono sempre in un caleidoscopio di emozioni allo stato puro, e quasi mai belle emozioni.
E adesso che cazzo starà facendo in bagno che non torna più, mentre il mio nuovo amico non ci pensa neanche a spostarsi dalla mia aura vitale, poi però ci ripensa e sale sul palchetto di pallets, imbraccia una chitarra elettrica e improvvisa un riff, c’è dentro di tutto, ma sopra quel tutto ci stanno una rabbia mai sopita e un sound graffiante, e passaggi fottutamente geniali. E non ero io l’oggetto del suo amore, non mi guarda neanche più perso nel suo mondo. Peccato.
Il personaggio è alquanto strambo, e con irriverenza mi apostrofa - There Is Love In You – il mio è stupore allo stato liquido, anzi sonoro.
Siamo in un locale, affollato, sottofondo di chitarre abrasive e fisarmoniche gitane, litanie trip-hop e cori terribilmente tetri.
La mia amica, la nuova regina della black music, è in bagno a rifarsi il trucco e mi ha lasciata sola in questo spazio fluido in continuo divenire, dove la gente cambia a ogni secondo, e sembran tutti creature solitarie impossibili da catalogare.
Questo però è diverso, pavento sia alienato e disturbato, a tratti persino paranoico, perché i suoi occhi ti guardano ma non sembra mica ti vedano veramente, chissà in quale vortice impressionante di suoni psichedelici è aggrovigliata la sua mente. Il suo abbigliamento lo si potrebbe definire bucolico e naif, piuttosto dimesso ma non cupo, invero originale. Non puzza, e questo è già una notizia in questo posto. Perché siamo in un posto fuori mano, il centro città è lontano e se guardo fuori dalle vetrate un po’ sporchine vedo un paesaggio contemporaneo alienato e alienante, di fronte un centro commerciale col suo bel parcheggio e a fianco un autolavaggio, più in là un groviglio di svincoli autostradali, dietro si lasciano immaginare le schiere interminabili di villette a schiera. Siamo finite qua alla ricerca dell’ultimo amore perduto della regina, lei d’altronde si innamora spesso, a modo suo con freschezza e immediatezza, poi la prende sempre nel culo, ma senza tema di smentite si può affermare che nelle sue storie non manca mai di intensità e originalità, mai una caduta di tensione o di stile.
Io la prego sempre di trovare un soggetto un cicinino meno claustrofobico e teso di quelli che con cui si accoppia di solito, magari più sofisticato e malinconico. Ma lei niente, le sue storie nascono e muoiono sempre in un caleidoscopio di emozioni allo stato puro, e quasi mai belle emozioni.
E adesso che cazzo starà facendo in bagno che non torna più, mentre il mio nuovo amico non ci pensa neanche a spostarsi dalla mia aura vitale, poi però ci ripensa e sale sul palchetto di pallets, imbraccia una chitarra elettrica e improvvisa un riff, c’è dentro di tutto, ma sopra quel tutto ci stanno una rabbia mai sopita e un sound graffiante, e passaggi fottutamente geniali. E non ero io l’oggetto del suo amore, non mi guarda neanche più perso nel suo mondo. Peccato.
lunedì 10 gennaio 2011
Colpevolizzato a dismisura dagli amici per non aver inserito l’ottava fatica dei Marlene Kuntz nel Best Off 2010, il recensore cerca di porre rimedio dedicando loro la prima recensione del nuovo anno.
La musica della band di Cuneo può forse risultare indigesta ad alcuni, a causa di una certa fredda autoindulgenza e di un’innegabile spocchia, in primo luogo del leader Cristiano Godano. Che non si smentisce nemmeno questa volta. Con la graphic art del disco, nella quale si mostra tutto nero intabarrato e con un improbabile e bizzarro cappello, sulla cover addirittura a solcare le acque come Caronte. E con l’invettiva iniziale di Ricovero Virtuale – gran pezzo rock, peraltro – con la quale attacca i maniaci del downloading (E sento puzza di sfigato/brutto e storto e avviluppato/sul suo trionfo sentenziare/auto-riflesso e marginale … Canta con me questo pezzo: "Son borioso e schifosetto") e ancor piu’, con inaudita violenza in Pornorima, i fan che li hanno criticati nei forum e nei blog per un presunto cedimento alle logiche del mercato: "Che pensino a scopare i farisei dell’indie-rock/le anti-sbrodoline snob/gli alternativi a pacchi e stock/Facciamogli capire, dai!/che siamo qui a godere/e poi a quelli più stronzetti/gli facciamo anche sentire/Come provi il tuo piacere/E poi potranno anche vedere/gli ebefrenici fighetti dell’Olimpo indie-rock/ le frigidine blah-blah-blog/gli avanguardisti a pacchi e stock/Sai che c’è?/Sei la mia porno-rima".
Tuttavia, Ricoveri Virtuali e Sexy Solitudini è un album teso e nervoso, bello e sincero, che segna un ritorno alle atmosfere del passato, e contiene diversi ottimi pezzi, tra i quali il singolo Paolo Anima Salva – ennesimo omaggio a Fabrizio De Andrè, che stia diventando una moda? –, l’ottima L’Artista, Vivo e la conclusiva, splendida ballata Scatti, mentre Orizzonti è puro Sonic Youth sound: sembra di sentire Ranaldo e Moore e le loro chitarre.
Certo, un po’ di ironia e maggiore umiltà non sarebbero guastate.
Iscriviti a:
Post (Atom)