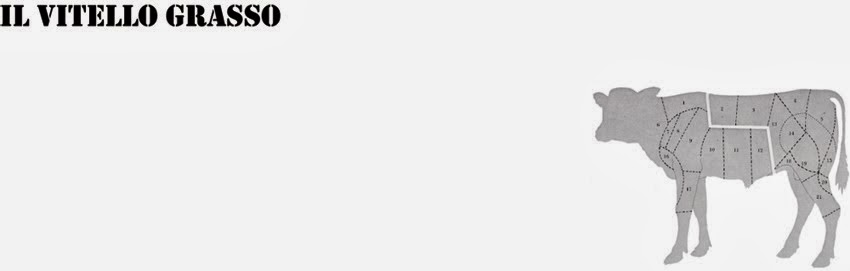L’attesa
al Palabanca era di quelle uniche e irripetibili.
Intanto:
Lou Reed a Piacenza. Dici poco. Per una volta non ti sembrava di essere alla
periferia dell’impero, ai margini di tutto quello che conta.
La
setlist aveva - come sempre accede in queste occasioni - suscitato perplessità
e delusioni, composta com’era da pezzi recenti, tratti da “Animal Serenade”
(2004), “The Raven” (2003) ed “Ecstasy” (2000), oltre che da pezzi minori riarrangiati
in versione noise, e da almeno due pezzi inediti. Era ovvio che non ci si
poteva aspettare ne’ un greatist hits ne’ tantomeno un amarcord dei Velvet
Underground, però le concessioni alla nostalgia furono davvero poche,
pochissime: tra esse il bis con “Sweet Jane”, in piedi davanti al palco senza
transenna, un grande classico che l’eroe
maledetto del rock (oggi tutti i media titolano così…) probabilmente eseguiva
solamente per riappropriarsene, dopo lo scippo (splendido) dei Cowboys Junkies.
Quindi: niente “Transformer”, niente “Berlin”. Ma nemmeno nessun brano da
grandi dischi come “Magic and loss” e “New York”. Altrettanto ovviamente, i fan
duri e puri sui forum si fecero beffa di quei poveretti che si aspettavano “Perfect
Day” o “Walk on the wild side”…
Ma
l’atmosfera era stata comunque vibrante, la platea da subito si era svuotata (in
teoria posti a sedere numerati) per andarsi a sedere per terra sotto il palco
(e intanto quelli della tribuna erano scesi in platea). C'era stata anche la
surreale entrata di un maestro di Tai Chi, il cui kata era stato accompagnato
dalla musica.
E
tornando a casa, avvolti nella nebbia che trasudava da una distesa di magazzini
per la logistica e di piazzali di asfalto per le manovre degli articolati, tra
trattorie a menu fisso e prostitute coi collant e la mini, ci era sembrato di
aver vissuto - in ogni caso - una indimenticabile serata di rock’n roll.