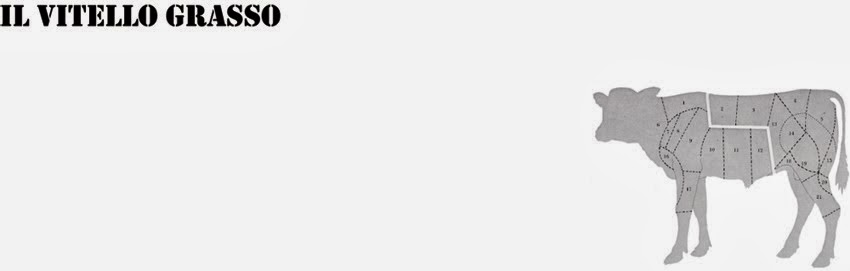giovedì 21 gennaio 2010
Un po’ perché pentito per aver ingiustamente trascurato il loro “Embryonic” nel recente pagellone di fine anno, e di aver addirittura escluso un pezzo come “Evil” dalla tradizionale compilation natalizia per gli amici piu’ intimi.
Un po’ perché l’originale - il The Dark dei Pink Floyd intendo – è stato uno dei miei primi ascolti in assoluto. Lo sparava a manetta mio fratello (maggiore) Achille - non che fosse un gran rockettaro, per la verità: in quei tempi, ascoltava canti gregoriani, fumava la pipa e portava una folta barba nera tipo Renato Curcio - sul suo stereo ad altissima fedeltà, a un volume tanto alto da far vibrare i vetri delle finestre e anche i lampadari in gocce di cristallo dell’inquilino di sotto. Io all’epoca andavo alle medie, e passavo il mio tempo a guardare i cartoni di Gundam e Mazinga, a collezionare adesivi che si mendicavano in giro per i negozi del centro o a tirare quattro calci al pallone sul campetto in asfalto dell’oratorio di San Savino. Immaginatevi il mio stupore di fronte alla perfezione assoluta e alla grandiosità di quei suoni.
E un po’ perché – massì, diciamola tutta, cazzo, con buona pace di tutta quella cricca fighetta e snobbona che gli preferisce i dischi degli esordi, quelli dell’epoca Barrett , ovvero i piu’ lisergici “The Piper At The Gates Of Dawn” o “Ummagumma” – “The Dark Side Of The Moon” è:
1. Il capolavoro dei Pink Floyd;
2. Uno dei piu’ grandi dischi della storia del rock.
In poche parole, una vera e propria opera d’arte.
Il suo maggior demerito, agli occhi di molti, è il fatto di aver venduto così tanto – per Wiki è il terzo disco rock piu’ venduto della storia (rimase per 741 settimane nella classifica Billboard 200 della omonima rivista musicale americana, dalla quale uscì soltanto negli anni ’80: uscì nel 1973!), qualcosa come 45 milioni di copie, preceduto solamente da Thriller di Michael Jackson e da Back In Black degli ACDC - e di aver trasformato Waters, Gilmour e soci in una banda di milionari pigri e imbolsiti.
Questo remake dei Flaming Lips, autoprodotto dalla band di Wayne Coyne e uscito alla fine dello scorso anno, oltre a rappresentare il classico omaggio dell’allievo al maestro, è una gradevolissima sorpresa, così lontano dall’essere una rivisitazione trita e scontata, dal compitino insomma.
L’opener “Speak To Me/Breathe” stupisce per la sua tensione nervosa, ma è la successiva versione dance di “On The Run” a spiazzare di brutto. Discreta la versione acustica di “Time”, con la ripresa di “Breathe”, che anticipa la strepitosa, apocalittica, cover di “The Great Gig In The Sky”, con i vocalizzi di Peaches e l’ausilio – come in quasi tutti pezzi – di Henry Rollins.
Si procede con la celeberrima “Money”, che qui sembra suonata dagli alieni e, ancora, con una lentissima versione di “Us And Them”, piuttosto dura da digerire. “Any Colour You Like” in salsa krautrock apre la strada al crescendo finale con la pacata “Brain Damage”, dall’arrangiamento lo-fi, e la straordinaria “Eclipse”, la cui perfezione ci lascia dei dubbi: e se in realtà fosse un pezzo dei Flaming Lips?
Da ascoltare e mandare a memoria, l’originale e il remake, tutte le volte che si puo’.
mercoledì 13 gennaio 2010
Non chiamateli Superband, potrebbero incazzarsi infatti; in ogni caso non sembrano tenerci piu’ di tanto.
Ma se non sono una Superband loro, chi altri può meritarsi un simile appellativo?
Ecco i (succinti) Curriculum Vitae dei tre membri dei Them Crooked Vultures (che suona piu’ o meno come: “quegli avvoltoi tutti torti”)
- Josh Homme: voce e chitarra, da Palm Desert, California, USA, leader già dei seminali Kyuss, inventori con il loro strepitoso “Blues for The Red Sun” (1992) del cosiddetto stoner-rock, e poi dei Queen Of The Stone Age (“Songs For The Deaf”, 2002).
- Dave Grohl: batteria, fa il suo ingresso nel 1990 nel terzetto base dei Nirvana, da Seattle, USA, giusto in tempo per dare il suo contributo all’epocale “Nevermind” (1991) e agli album successivi della band piu’ importante di fine secolo. Successivamente (1995) fonda i Foo Fighters, dei quali è anche il cantante.
- John Paul Jones (all’anagrafe John Baldwin, il nome d’arte è invece ispirato a un corsaro statunitense, considerato il padre della marina americana): basso e tastiere, da Londra, Gran Bretagna, 63 anni compiuti da poco piu’ di una settimana, membro fondatore dei mitici Led Zeppelin; è l’autore di alcuni memorabili giri di basso (“The Lemon Song”, “Ramble On” e “Black Dog”), quanto basta per entrare di diritto nell’Olimpo degli Immortali (del rock, si intende).
Ma i tre non hanno alcuna intenzione di guardare indietro.
Anzi.
Ripartono da zero, con l’entusiasmo e l’umiltà dei grandi: si pensi che il loro debutto live in terra inglese è avvenuto alla Brixton Academy londinese come band di supporto agli Arctic Monkeys, lo scorso 26 agosto (mah).
Per questo, sarebbe alquanto ingeneroso, nel dover giudicare questo loro album omonimo di debutto, fare paragoni con il loro scomodo passato (è talmente ovvio, infatti, che tra questi solchi non troverete nessuna “Stairway To Heaven” e nessuna “Whole Lotta Love” e nemmeno una “Tangerine”, o una “Lithium”).
A noi è piaciuto.
L’inizio è cazzuto e roboante, con la tiratissima sequenza “No One Loves Me & Neither Do I” (in puro stile zep), “Mind Eraser, No Chaser” e “New Fang”- questi ultimi sono i primi due singoli estratti dall’album, e piaceranno ai fan degli White Stripes - mentre “Dead End Friend” è un pezzone stoner ed “Elephants” ammicca a territori progressive sinora inesplorati. Dopo una serie di brani tutto sommato trascurabili, nei quali Homme prende decisamente il sopravvento ma non riesce a svincolarsi dal suo recente passato (QOTSA), il disco riprende corpo e vigore con l’hard-rock ‘70 di “Gunman” e la conclusiva, ottima, “Spinning In Daffodils”, che in poco piu’ di sette minuti riesce nel difficile intento di condensare stoner, progressive, psichedelia, grunge persino, in una sintesi quasi perfetta.
domenica 10 gennaio 2010
mercoledì 6 gennaio 2010
QUASI COME KEROUAC, 11

July 26th - TERZA PARTE
Solo un colpo di fortuna.
Per nessun motivo apparente, infatti, decidiamo di lasciare la Statale 91 per imboccare una scorciatoia assai tortuosa, verso ovest, in direzione Many Farms.
La strada è assolutamente deserta e dopo ogni curva si aprono magnifici e sempre imprevedibili scenari, guglie e rocce splendidamente erose dal vento e scavate dall'acqua, toni e colori accesi e vividi, sotto un cielo immenso ed elettrico.
Attraversiamo luoghi dai nomi evocativi: Rough Rocks, Red Rocks e Black Mesa. Territorio Navajo. Osservo minuziosamente la mappa. A poche miglia c'è il confine con il New Mexico, e ancora piu' a nord il Colorado. Cortez (The Killer?), Mesa Verde, Durango. La Durango di Bob Dylan.
Avanziamo con estrema lentezza.
Il sole, che sino a ora aveva picchiato duro, ci regala un attimo di tregua, andando a nascondersi dietro a un improvviso cumulo di nuvole nerastre.
Scendono persino due gocce di pioggia, ma è solo un'illusione.
Restiamo in silenzio dentro l'abitacolo della nostra auto che scivola leggera tra le curve che corrono parallele a un torrente in secca.
In pochi minuti raggiungiamo la Statale 190, nei pressi di Kayenta, e poi ancora a nord verso la mitica Monument Valley, che resta proprio sul confine tra gli stati dell'Arizona e dello Utah, ormai solo poco piu' di venti miglia ci separano da una delle mete principali del viaggio.
Arriviamo al tramonto, come da copione piu' classico.
E' a quell'ora, infatti, che le rocce si tingono di rosso come il fuoco, in un fantastico contrasto con l'azzurro intenso del cielo.
Optiamo per il loop in senso antiorario, e dunque circumnavighiamo la zona off-limits mediante una pista di sabbia rossa. La Toyota procede a strappi, affondando le ruote nelle buche e nei vari dislivelli della pista, e ripartendo ogni volta con maggior fatica. Alcuni fuoristrada guidati dai nativi, di quelli con le ruote enormi da mietitrebbia che da noi in Italia le usiamo per andare a prendere i bambini fuori da scuola, fingono di insabbiarsi per costringere i turisti a scendere e a spingere: è una squallida pantomima, e infatti ridono tutti.
Improvvisamente avvertiamo una gran botta, ma dopo una rapida ispezione escludiamo danni al paraurti in tinta carrozzeria.
Inoltre, con la mia consueta e inguaribile goffaggine nel pomeriggio ho rovesciato mezza lattina di Fanta nel cambio automatico, e questo certamente non aiuta.
Schizzi di fango sulle portiere, il cofano è completamente impolverato.
Chissà cosa direbbero, alla Hertz.
Lo spettacolo è grandioso, e ci lascia senza parole.
Tra noi, infatti, non ci nascondevamo un pò di timore che la Monument Valley - vista e rivista in centinaia di film western, e con le sue trite e stereotipate immagini da cartolina - fosse una mezza delusione, e invece così non è.
Cazzo, è davvero come se un fottuto cowboy yankee sbucasse fuori da un angolo e ci puntasse la sua pistola addosso.
Al John Ford Point, scattiamo le fotoricordo di rito.
Un cattivo presagio.
A Kaylenta non ci aspetta nessuno.
(Così almeno è scritto sul manoscritto originale: cazzo avrò voluto intendere, poi. Chi doveva esserci? John Wayne in carne e ossa?)
Traduco che non troviamo da dormire.
Verso Page, allora, e su quella strada poco prima di mezzanotte - dopo aver accarezzato ormai l'idea di accamparci per la notte sui sedili di pelle imbottita della nostra Camry - finalmente avvistiamo un piccolo motel ancora aperto, una specie di baita di legno piuttosto rabberciata ma dall'aspetto così familiare.
Iscriviti a:
Post (Atom)