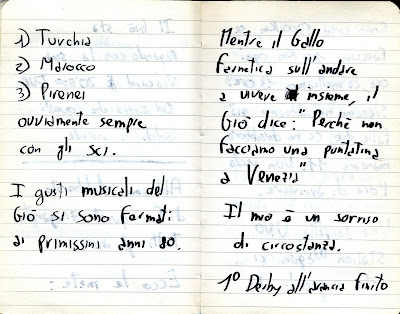martedì 29 giugno 2010
La perfida Albione se ne torna mestamente a casa dal Sudafrica – il (clamoroso) goal fantasma di Lampard non è un alibi che regge per i patetici leoni di Capello: Rooney sembrava la controfigura di Iaquinta – ma si consola con numerosi ritorni importanti in campo discografico.
Di Paul Weller e del suo Wake Up The Nation! – ovvero l’amarissimo controcanto al crepuscolo del New Labour - è stato già detto, e allora dobbiamo parlare dei nuovo album dei Divine Comedy di Neil Hannon (Bang Goes The Knighthood) - sempre di livello eccelso e con un’ottima When A Man Cries, barocchismo degno del miglior Peter Hammill o del Bowie di mezzo -, dei Teenage Fanclub (Shadows) – i beniamini di Nick Hornby non deludono le attese -, di Robyn Hitchcock con i suoi Venus (Propellor Time), vecchio maestro della psichedelica pop, e dei mitici e immarcescibili Fall di Mark E. Smith da Manchester (Your Future Our Clutter): questi ultimi due non li abbiamo ancora ascoltati – musica per le orecchie per gli amanti e i nostalgici degli Eighties - ma promettiamo di tornarci sopra al piu’ presto.
Ma il maggior clamore è per l’ottavo album dei Chemical Brothers (Further: “Piu’ avanti”).
Chi scrive non è mai stato un fan sfegatato del duo londinese (al secolo: Ed Simons e Tom Rowlands), e nemmeno della musica dance/techno – il cosiddetto Big Beat - tanto in voga nei club negli anni Novanta (Prodigy, Fat Boy Slim).
Eppure Further si differenzia dalla recente produzione dei fratelli chimici perché abbassa un po’ il tiro, pretende meno insomma e infatti è piu’ divertente; dunque possiamo goderci, senza dovercene vergognare, la semplice melodia elettronica stile Daft Punk o Air del singolo Swoon – strepitoso il videoclip, una vera e propria opera d’arte digitale – e di Another World, il kraut di Snow e K+D+B, la citazione di Baba O’Riley dei Who nella lunga ed estenuante Escape Velocity (lunga), mentre piu’ scontata (e rimasticata) suona Horse Power.
Pubblicato su Virgin, sarà uno dei tormentoni dell’estate 2010.
sabato 19 giugno 2010
Chi come noi si porta l’Irlanda nel cuore non può che rallegrarsi per questa opera prima del giovane dublinese Conor J. O’Brien, alias Villagers.
Abbiamo scoperto per caso il singolo Becoming A Jackal – stesso titolo dell’album – grazie a un insolito passaggio in F***ing Good Music, ottima trasmissione serale della rete satellitare brand:new di Mtv, e subito ci hanno sorpreso il suo delicato fraseggio folk e la sua immediatezza comunicativa: la critica per lui ha scomodato paragoni scomodi con Elliott Smith, Sufjan Stevens e i Bright Eyes.
Il disco si apre con le orchestrazioni immagnifiche di I Saw The Dead, che narra di un funerale sotto il mare, prosegue con il singolo stesso e con la ritmata Ship Of Promises, dalle parti degli Wilco.
Ma è nella parte centrale che raggiunge l’apice con un pop fiabesco dalla freschezza invidiabile: Home, That Day - con spettacolari cori in farsetto a là Bon Iver - e infine The Pact (I’lle Be Your Fever), una marcetta sixties con un ritornello irresistibile.
Becoming A Jackal (= “Diventando uno sciacallo”, qualcosa che si avvicina a un concept album sulla storia grottesca di un ragazzo che si trasforma appunto in sciacallo) sembrerebbe mostrare, nel finale, qualche segno di stanchezza ma l’indice di gradimento si impenna all’improvviso con la meravigliosa Pieces, il brano migliore di tutta la raccolta, sospesa tra un’atmosfera vagamente jazzy (Tindersticks, Divine Comedy), una magistrale interpretazione vocale tra Damien Rice e Tom Yorke (Radiohead) e un finale da licantropo in stile Eels.
Per PiacenzaSera una delle proposte piu’ interessanti dell’anno in corso.
Anzi.
E se ci trovassimo di fronte (per restare in Irlanda) all’erede di Van - The Man - Morrison?
lunedì 7 giugno 2010
Dopo aver preso un cazziatone dall’amico J. per non aver inserito San Patricio dei Chieftains con il mitico Ry Cooder (a suo dire, il disco dell’anno, a dire di J., intendo dire) nel pezzo di due settimane orsono dedicato a una serie di collaborazioni inusuali e feconde tra artisti di estrazione differente - mea culpa - non posso esimermi di recensire il sesto album di Micah P. Hinson: un suo, un nostro, vecchio pallino. Anche perché Tony Face ha già parlato dalle colonne di PiacenzaSera di alcune interessanti uscite di maggio, tra le quali l’ottimo Brothers dei Black Keys – davvero una sorpresa, grazie Tony - e i Dead Weather, per la verità un po’ legnosi quest’ultimi.
Il folksinger texano – avete notato quanti texani, ultimamente? Per fortuna, non solo i Bush da quella terra arida e ricca – ritorna con un disco da battaglia: "I pionieri sabotatori hanno il cuore pieno di rabbia. Guardiamo il mondo cambiare e non ci piace quello che vediamo". Basti citare la cover del disco, con una canna di pistola puntata contro l’osservatore, o il titolo dell’ouverture strumentale, fin troppo esplicito: A Call To Arms (Una Chiamata Alle Armi).
Troviamo in quest’opera tutto quello che ci è sempre piaciuto nei suoi lavori precedenti, ovvero il consueto immaginario della grande pianura americana: Walt Whitman, l’epica western, ritratti di frontiera, predicatori falliti e venditori di bibbie (My God), matrimoni in crisi (Seven Horses Seen), la voglia di fuga e di ribellione, gli archi e il pianoforte, la malinconia e la speranza. E poi il maestro Johnny Cash, l’eco di Calexixo e Black Heart Procession (The Striking Before The Storm e soprattutto The Cross That Stole This Heart Away), del revival wave di National e compagnia briscola (Watchman, Tell Us Of The Night), persino i fasti del Nick Cave mistico di The Ship Song (in 2nd and 3rd) e sperimentazioni noise forse troppo ambiziose (The Returning).
Ancora una volta, tuttavia, il meglio di sé Micah (pronounced: “maica”) lo da’ con una manciata di struggenti canzoni d’amore (The Letter At Twin Wrecks (Dear Ashley), dedicata alla moglie), tra le quali emerge la delicatezza e la disarmante semplicità, apparentemente persino banale, di Take Off That Dress For Me, tra Cohen e il primo Waits.
Alla fine, tutti d’accordo con J.: ottimo lavoro, Maica.
PS: presto lo vedremo in Italia: il 16 luglio a Verona, il 17 al Pistoia Blues Festival, il 18 luglio a Ferrara, il 19 luglio a Roma e il 20 luglio a Torino.
sabato 22 maggio 2010
3+3=6
E’ un periodo di collaborazioni inaspettate e contaminazioni feconde.
Ben vengano, in un periodo come questo, in ultima analisi caratterizzato dall’assenza di album indimenticabili, di quelli da portarsi dietro in una fantomatica isola deserta (che poi magari arrivi là per ascoltarti in santa pace, che so, “Rock Bottom” di Robert Wyatt o “Blonde On Blonde” di Bob Dylan, e improvvisamente piombano lì, a romperti i coglioni, Daniele Battaglia - chi cazzo sarà mai, poi, Daniele Battaglia? - e Aldo Busi, Massimo Ciavarro o Giucas Casella).
L’ex-leader dei Talking Heads non è certo nuovo a questo tipo di scommesse: basti qui ricordare il seminale My Life In The Bush Of Ghost, inciso con Brian Eno (ovvero: l’incontro di due geni musicali che dà vita a un autentico capolavoro) e i lavori con Mogway, Paul Simon e Ruicky Sakamoto.
Con il celebre Dj inglese (al secolo Norman Quentin Cook) ed ex-membro degli Housemartins, egli costruisce un vero e proprio concept album ("Here Lies Love"), ovvero un ciclo di canzoni dedicate alla controversa figura di Imelda Marcos, amante della bella vita e vedova dell'ex-dittatore delle Filippine, già portato a teatro sotto forma di musical a partire dal 2007. Album sovraccarico e tutto sommato un po’ faticoso: ci sono la dance, il funk elettronico degli esordi, gli ovvi aromi sudamericani, e anche inutili barocchismi; soprattutto, una serie impressionanti di vocalists femminili che, pazientemente in attesa del loro turno, danno voce a Imelda e alle altre donne importanti della sua vita: Natalie Merchant, Cindy Lauper, Tori Amos, Martha Wainwright, Kate Pierson dei B52’S, Florence & The Machine.
Dopo dodici anni alla guida degli Amparanoia, la cantante Andalusa Amparo Sánchez intraprende la carriera solista chiedendo aiuto ai Calexico, ai quali ella aveva prestato la sua splendida voce in Inspiración (sull’album "Carried to Dust"). Il risultato non poteva che essere eccellente: "Tucson Habana" è un disco elegante e raffinato, caldamente consigliato anche dall’amico Big, con una malinconica atmosfera latina appena venata da accenti jazz e blues, e – sullo sfondo – il riconoscibile contributo dei maestri Burns e Convertino, rispettivamente alla batteria e alla chitarra.
Ma la palma del connubio piu’ inedito e sorprendente se la guadagnano i bravi Okkervil River di Will Sheff, qui ad accompagnare il clamoroso rientro – dopo quindici anni di silenzio, caratterizzati da tragedie personali e da un profondo travaglio interiore - di Roky Erickson, ex-leader (è tutta una parata di ex…) della garage-band californiana dei 13th Floor Elevators (come non ricordare You’re Gonna Miss Me?, uno dei brani migliori dell’esaltante stagione dei Sixties).
Sheff, con un lavoro di ascolto certosino, ha scelto una manciata di brani tra gli oltre cento composti dal suo vecchio idolo, e si è offerto di accompagnarlo con la sua band per una rivisitazione di alto livello, tendenzialmente lo-fi, con echi di psichedelia, rithm’n blues e hard-rock.
Giovanni Battista Menzani
www.cjmoleskine.blogspot.com
giovedì 20 maggio 2010
domenica 16 maggio 2010
sabato 15 maggio 2010
Il colore viola del titolo raffigura alla perfezione il romanticismo tenebroso e crepuscolare della band newyorkese (originaria di Cincinnati, Ohio), con il passar del tempo assurta – al pari dei concittadini Interpol, il cui atteso nuovo disco è previsto a breve - da icona indie a “classico” del nuovo rock made in U.S.A.
Dare un seguito allo splendido e fortunatissimo Boxer (2007: con perle quali Mistaken For Strangers e Fake Empire, utilizzata da Obama per la campagna presidenziale del 2008) era un’impresa alquanto ardua.
I National – al debutto sulla storica label 4AD - optano per una linea di sostanziale continuità, con la consueta, raffinata miscela di post-punk, canzone d’autore e rock intellettuale (Joy Division, Leonard Cohen, Tindersticks), e per questo motivo non mancheranno di essere accusati di scarso coraggio: scelgono cioè di non voler tentare forzatamente la strada del nuovo, della sperimentazione, con il rischio di dar vita a creature incompiute o pasticciate (l’ultimo Editors, ad esempio).
Tuttavia, rispetto al recente passato, il loro sound appare talvolta meno claustrofobico e teso, e vira verso suoni e arrangiamenti piu’ ariosi e sofisticati, addirittura epici (Little Faith, England).
L’album si apre laddove i fratelli Dessner e Deavevano lasciato, con l’atmosfera cupamente dark di Terrible Love, le chitarre abrasive e la voce lamentosa del barbuto Matt Berninger (oltre a lui, la band è formata da una doppia coppia di fratelli: Aaron e Bryce Dessner; Scott e Bryan Devendorf) a tenere banco; l’opener track è, insieme al primo singolo Bloodbuzz Ohio, tra i brani maggiormente in linea con i fasti di Boxer.
Sorrow è invece la prima – in ordine temporale - di una serie di ballate malinconiche e struggenti (la bellissima Runaway – originariamente intitolata Karamazov e dedicata a Dostoyevsky - Lemonworld con quell’irresistibile coda: D-D-D-D-D-D-D-D, oltre alla conclusiva Vanderlyle Crybaby Geeks) che confermano il loro mestiere.
Chi ne avesse voglia, può cercare sul tubo la loro recente esibizione al Letterman Show (puntata del 13.05.10): hanno eseguito la languida Afraid Of Everyone con la partecipazione straordinaria di Sufjan Stevens per il backing vocals.
venerdì 14 maggio 2010
Cancrena, 05
In piedi vicino alla finestra della mia stanza da letto, raschiarata dalla luce di una vecchia lampada al kerosene, intravvedo il leggero pendio del prato e, poco oltre, un timido raggio di sole finalmente squarciare il tetro sipario di nuvole nere - finalmente una tregua.
Ho quasi finito di preparare i miei bagagli.
Non è una cosa facile: riporre le mie cose nelle valigie mi provoca emozioni intense, la mente si riempe di ricordi indelebili.
I nipoti del vecchio si presentarono - in formazione completa - per il giorno delle esequie. Impettiti e spocchiosi, nei loro abiti scuri da funerale.
Ricordo il silenzio che precedette la sepoltura. Il vento tirava violento sino a spazzare le cime dei cipressi del viale del piccolo camposanto.
La cerimonia fu dignitosa, considerate come si erano messe le cose all'inizio.
Il giorno successivo al decesso, quei maledetti avevano battuto il territorio per chiese e cimiteri, alla ricerca del conto piu' basso. Con questa crisi, persino i preti si fanno la guerra e noi dobbiamo aprofittarne, si dicevano tra loro mentre misuravano a passi la stanza del vecchio ormai senza vita. Un parroco di pianura offrì loro persino un comodo pagamento rateale, e una tessera a punti, valida anche per battesimi, comunioni, cresime e matrimoni: alla decima cerimonia avevi diritto a un'undicesima gratis.
Uomini che non conoscono la vergogna.
Fu allora che mi impuntai, e pretesi di seppellire il vecchio qui, nella sua terra, tra la sua gente.
Alla fine era venuto il momento di fare i conti.
L'appuntamento dal notaio fu fissato venti giorni esatti dopo il funerale.
Un nipote ragioniere era stato eletto il portavoce degli eredi. Era un tipo agguerrito, con un completo nuovo acquistato all'ipermercato e un foulard di seta nel taschino del gilet. Nervosamente, si rigirava tra le dita un piccolo codice di leggi, sul quale aveva appuntato una serie di segnalibri colorati. Al suo fianco erano schierati gli altri nipoti, con le loro consorti dal trucco un pò pesante.
Dall'altra parte del grande tavolo di legno massiccio, io sola. Cominciarono a tremarmi le gambe.
Il notaio, un omuncolo basso e secco con evidenti problemi di forfora, aprì la cassaforte, estrasse i documenti e, senza troppi preamboli, lesse con un filo di voce le estreme volontà del decujus, scandendo il ritmo con una serie infinita di omissis.
Il testamento del vecchio mi escludeva in modo definitivo.
Le sue proprietà spettavano ai suoi nipoti, suoi legittimi eredi, che adesso sembravano decisamente piu' sollevati e annuivano con la testa alla lettura del documento.
Eppure il vecchio...
Ti lascio questa vecchia casa, mi aveva detto in tono solenne nemmeno un mese prima, tu sei l'unica che puo' ancora evitarle una fine rovinosa e senza gloria.
Io mi ero buttata in lacrime ai suoi piedi: sentivo di non meritarlo.
Lui mi aveva accarezzato i capelli, sottili e castani come quelli di mia madre, che li raccoglieva sempre all'indietro in una lunga coda sin'oltre le scapole e la schiena, e mi aveva comandato di rialzarmi in piedi.
Non piagnucolare così, Cristo, aveva detto, mi fai venire voglia di cambiare idea.
E io lo so, che il vecchio non ha cambiato idea.
(Il parroco mi aveva avvertito. Mi aveva detto di non coltivare grandi aspettative. Sospettava che il notaio si sarebbe accordato con i parenti e che avrebbe fatto sparire l'originale del testamento, sostituendolo con un altro contraffatto ad arte. Sono cose che succedono, da queste parti, mi aveva detto sconsolato).
Sì, le cose dovevano essere andate così.
E così rimasi senza nulla (ma nulla meritavo).
Un'uggiosa mattina di ottobre ricevetti dalle mani del postino una raccomandata. Mentre firmavo l'avviso di ricevimento, lessi l'indirizzo del mittente in calce alla busta bianca e immacolata: erano loro.
Senza tanti preamboli, mi ringraziavano del lavoro svolto al servizio del loro amato nonno e mi lasciavano una settimana di tempo per far su le mie cose e lasciare la casa.
Temevano che io decidessi di rimanere quì ancora del tempo, che occupassi questa casa in modo abusivo, e quindi fecero sparire tutti i documenti e tutte le bollette e chiamarono dei tecnici per disdire i contratti del gas e della corrente elettrica.
Fecero murare l'ingresso del locale caldaia.
Fecero mettere dei piombini sui contatori della corrente elettrica.
Fecero tagliare i tubi del gas.
Prima di andare a dormire, mi sciacquo le ascelle con l’acqua gelida del fontanazzo giù in cortile, quello con la vasca in graniglia e il rubinetto di bronzo a forma di testa d'aquila.
Al buio, asciugo i capelli appoggiandoli con cautela alla vecchia stufa di ghisa, e intanto osservo la credenza con gli sportelli di vetro colorato, la credenza sulla quale il vecchio aveva attaccato con il nastro adesivo le fotografie della sua famiglia: riunioni di famiglia, ritratti di uomini e donne con l'abito della festa, scatti sfocati di bambini appena nati, gruppi chiassosi di ragazzi vestiti da piccoli ometti.
Mi avvicino e le osservo con attenzione, ancora una volta, assaporando ogni immagine e ogni ricordo come se quelli fossero ricordi miei, i ricordi della mia vita.
Strano, penso allora, di fotografie mie e della mia famiglia non ne conservo neppure una.
Fuori, cade ancora la pioggia.
mercoledì 12 maggio 2010
Frettolosamente catalogato nella categoria “Folk Inglese”, o Psych-Folk, questo debutto omonimo degli Erland & The Carnival è un’autentica rivelazione.
La stravagante band è composta da Erland Cooper, cantautore originario delle Isole Orcadi (Scozia), da Simon Tong (ex The Verve, The Good, The Bad & The Queen) e David Nock (The Orb, Fireman) e si è ispirata – nella scelta del nome - al compositore jazz Jackson C. Frank e alla sua My name is Carnival, la cui notevole cover è stata inserita nella tracklist dell’album.
Abilissimi nel mischiare i generi e le influenze piu’ disparate – tutto in un frullatore: organetti a là Doors; la psichedelia ’70: Love, Kaleidoskope; echi Pink Floyd prima maniera; il folk inglese ‘60/’70: Pentangle, Fairport Convention; il country sinfonico di Ennio Morricone, sempre piu’ di moda negli ultimi tempi – gli E&TC ripropongono un repertorio di brani tratti dalla tradizione folkloristica d'oltremanica (su tutte: l’ottima Was You Ever See, Love Is A Killing Thing; One morning fair, classico gallese qui in chiave rock; Tramps And Hawkers, che riporta alla mente addirittura il primo Tim Buckley - quello di Hallucinations, per intenderci), rivisitati con sbalorditiva intensità, originalità e freschezza.
A questo aggiungono alcune perle d’autore: la ballata fricchettona Disturbed This Morning, la lisergica The Echoing Green e The Sweeter The Girl The Harde, un garage che recupera una meravigliosa e scanzonata atmosfera sixties, tanto che non avrebbe certamente sfigurato nella mitica raccolta Nuggets.
Infine, Trouble In Mind, ovvero uno straordinario pezzo di indie-pop che – in un paese normale – sarebbe puntualmente in testa alle classifiche e alle heavy rotation di radio e tv.
Per noi di PiacenzaSera, Erland & The Carnival si inserisce di prepotenza nella lista dei migliori album di questo inizio di 2010.
E potrebbe restarci a lungo.
venerdì 7 maggio 2010

Ancora il Canada sugli scudi.
Dallo sterminato paese al nord degli USA – popolato, a giudizio degli yankees, da boscaioli dalla barba lunga dediti all’abuso di alcol e di sciroppo d’acero (l’ho assaggiato in una stanza d’albergo a Toronto, è terribile) – arrivano due nuovi album degni della nostra attenzione.
I Woodpigeon (ancora il nome di un uccello, come nel caso degli ottimi Shearwater, recensiti qualche tempo fa su PcSera) sono un collettivo che arriva da Calgary, cittadina altrimenti nota per le recenti Olimpiadi invernali.
La loro terza fatica, intitolata Die Stadt Muzikanten, è una buona raccolta di canzoni folk prevalentemente acustico a là C.S.N.&Y. (la title-track, Empty-Hall Sing-Along, Morningside), anche se non mancano improvvise accelerazioni elettriche (Such A Lucky Girl, Duck Duck Goose).
Purtroppo per noi, solamente per il mercato giapponese e per i primi acquirenti on-line dell’album, è stato offerto un album di dodici bonus track registrate con l’onnipresente Steve Albini, contenente una sequenza (sembra…) di brani grintosi e robusti, come da tradizione del vecchio Steve, e assai differenti dallo stile dell’album.
I Thee Silver Mt. Zion, da Montreal, sono invece una costola – o side-project – dei piu’ celebri Godspeed You Black Emperor!, alfieri post-rock, a giudizio di scrive uno dei progetti piu’ significativi, in assoluto, del decennio scorso.
L’opener There Is A Light e la conclusiva Piphany Rambler sono due lunghe suite che ripropongono il prog dilatato e magniloquiente tipico della casa madre.
I Built Myself A Metal Bird, invece, è un episodio decisamente piu’ ruvido, con il canto sincopato di Efrim in puro stile Pere Ubu.
Infine c’è spazio per una sequenza di brani piu’ rilassati e ipnotici, arrangiati con un proluvio di archi e chitarre, pensati come ipotesi diverse da svilupparsi a partire dallo stesso concetto: Kollapz Tradixional (Thee Olde Dirty Flag), Collapse Traditional (For Darling) e Kollaps Tradicional (Bury 3 Dynamos).
martedì 4 maggio 2010
domenica 25 aprile 2010
Cancrena, 04
Negli ultimi tempi, il vecchio si reggeva a malapena in piedi.
Tuttavia, non voleva che lo aiutassi.
Con le stampelle se la cavava benissimo, sosteneva lui.
E invece metteva il culo giu' in terra in continuazione, e poi restava lì delle ore, senza chiedere aiuto, in attesa degli eventi. Si faceva venire dei lividi bluastri grandi come delle padelle.
Lo so bene io - quante volte ho dovuto pulirglelo, quel suo culo flaccido.
Lui restava lì, in posizione supina dentro la vecchia vasca dai bordi increspati e dal fondo ingiallito, a tremare come un neonato.
Era morto nel sonno, all'alba di un bellissimo giorno di fine estate, mentre nei campi di erba medica già cantavano i grilli e le cicale.
Non c'era stato bisogno di autopsia o di esami particolari. Arresto cardiaco: questa la diagnosi del medico di famiglia, un uomo grassoccio e stempiato con un unico vestito di flanella grigia, che puzzava di sigari di bassa marca. Viveva da solo in un appartamento di dodici locali, completamente vuote, che aveva ereditato dalla facoltosa madre. Sotto la sua abitazione c’era l’ambulatorio, una piccola stanza buia e poco areata: l’unica finestra, di dimensioni minuscole, dava su un tetro cavedio per gli impianti condominiali.
C'era da aspettarselo, aveva commentato - scrollando la testa in segno di disapprovazione - il dottore, appena prima di salutare frettolosamente i primi parenti convenuti sul posto.
Tutti, in famiglia, avevano sofferto di problemi di circolazione.
Il padre era morto d'infarto, quando lui ancora portava i calzoncini corti e un paio di sandali scalcinati, e passava i suoi pomeriggi a inseguire le anatre starnazzanti nell'aia polverosa.
Per tutta la vita aveva provato a ricordarselo, suo padre, ma tutto quello a cui riusciva a pensare era un sorriso stanco, un patetico riporto di capelli unti sulla fronte stempiata e due occhi gelidi e distanti.
Oppure a quella volta che, da bambino, aveva sfondato il solaio del fienile ed era caduto di sotto, in mezzo ai liquami della stalla, e il padre l'aveva picchiato con la cinghia dei pantaloni.
Questo lo ricordava bene.
E anche le barrette di cioccolato bianco che suo padre nascondeva nel cassetto della scrivania del suo studio, e che ogni tanto gli dava dopo cena, senza farsi vedere da sua moglie che non approvava per niente.
E lui che zappava nell'orto poco dopo il tramonto.
E le due sterline d’oro che gli aveva regalato per la prima comunione.
Era andata ancor peggio allo zio di suo padre, stimato penalista in pensione e insignito - con cerimonia ufficiale - di una medaglia al valore e del titolo di cavaliere.
Una rara malattia lo aveva costretto su una carrozzella. Il sangue aveva progressivamente smesso di circolare nelle sue vene e i muscoli si erano pertanto atrofizzati, sino ad incancrenirsi: uno dopo l’altro, i medici erano stati costretti ad amputargli tutti e quattro gli arti, prima le gambe e poi le braccia.
Così facendo, avevano creato un mostro - un’assurda e miserabile larva umana.
Lo zio trascorreva il suo tempo su una carrozzella, parcheggiata sotto la pianta del fico, borbottando sommesse e oscene litanie.
Una volta addormentato, il mollusco – questo era il gentile nomignolo affibbiatogli dai figli dei mezzadri - costituiva un facile bersaglio e, così, nascosti dietro la siepe, i teppistelli lo colpivano ripetutamente con pirioli di carta sparati da cerbottane di plastica dura. Talvolta il piriolo veniva incendiato con un cerino appena prima del lancio, oppure veniva dotato di uno spillo, sadicamente infilato proprio nella punta del cono costruito con vecchi giornali. Nelle torride giornate d’estate, lo zio era il facile obiettivo di fitti lanci di gavettoni d’acqua dal balconcino del bagno del primo piano. Non solo, accerchiato al centro dell’aia, sopportava con eroica pazienza l'assedio di una tribu' di mocciosi travestiti da pellerossa, con le piume delle galline appena spennate sulla testa.
Il vecchio mi aveva piu' volte raccontato della faccia atterrita di suo zio quando, appena svegliatosi da una pennica pomeridiana, si ritrovò alcune pelli di fico spalmate sul cranio lucido.
Da quell’improvvisato copricapo, viscido e vellutato, il succo dei frutti colava sulle guance del vecchio, mescolandosi con lacrime amare di umiliazione.
sabato 24 aprile 2010
I texani Midlake sono tra le bands piu’ attive del momento.
Pochi mesi orsono è uscito per la label Bella Union il loro terzo album (“The Courage Of Others”), con il quale sembrano aver abbandonato le atmosfere lisergiche degli esordi per approdare a un folk assai piu’ tradizionale e classico, seppur terribilmente monocorde.
A poca distanza, eccoli di nuovo in veste di co-produttori (e musicisti) dell’opera prima di John Grant - ex-leader degli Czars, da Denver, Colorado, al rientro dopo una fase a dir poco turbolenta della sua vita, caratterizzata da eccessi vari – accolta oltreoceano e nel Regno Unito dall’ovazione quasi unanime da parte della critica (5 stelle su 5 per Mojo).
Anche Grant trae ispirazione dai grandi classici del passato, prima di tutto il grande rock americano degli anni anni Settanta.
Ed è - è doveroso ammetterlo - capace di scrivere ottime canzoni.
Come la doppietta iniziale con le malinconiche TC And Honeybar e I Wanna Go To Marz, per esempio, che qualcuno sul Web ha paragonato addirittura a un mpstro sacro come I Talk To The Wind dei King Crimson.
Il problema sono gli arrangiamenti levigati, puliti, tipici di un certo AOR (Adult Oriented Rock) da classifica, un mucchio di citazioni e alcune melodie facili facili, assai semplici da mandare a memoria: alcuni pezzi ricordano, per citare il Grande Lebowski, i fottuti Eagles.
Where Dreams Go To Die e It’s Easier promettono bene, grazie alla voce calda e suadente di Grant, ma i rispettivi ritornelli sono davvero troppo melensi per le nostre povere orecchie indie.
Meglio Chicken Bones, un pezzo decisamente on the road – sembra di sentire i Little Feat di Willin’ e Trouble - e la marcetta pianistica Silver Platter Club, che pare invece Randy Newman o il primo Billy Joel.
Ancora un paio di episodi poco convincenti, ma poi nel finale l’album si riscatta alla grande: in Caramel Grant sembra fare il verso ad Antony & The Johnson, e c’è anche una bella coda sintetica in mellotron, mentre Leopard And Lamb e la title-track – grande atmosfera glam - hanno davvero un bel tiro.
Chissà se al Drugo sarebbe piaciuto.
Mah.
Mica sono i Creedence.
Pochi mesi orsono è uscito per la label Bella Union il loro terzo album (“The Courage Of Others”), con il quale sembrano aver abbandonato le atmosfere lisergiche degli esordi per approdare a un folk assai piu’ tradizionale e classico, seppur terribilmente monocorde.
A poca distanza, eccoli di nuovo in veste di co-produttori (e musicisti) dell’opera prima di John Grant - ex-leader degli Czars, da Denver, Colorado, al rientro dopo una fase a dir poco turbolenta della sua vita, caratterizzata da eccessi vari – accolta oltreoceano e nel Regno Unito dall’ovazione quasi unanime da parte della critica (5 stelle su 5 per Mojo).
Anche Grant trae ispirazione dai grandi classici del passato, prima di tutto il grande rock americano degli anni anni Settanta.
Ed è - è doveroso ammetterlo - capace di scrivere ottime canzoni.
Come la doppietta iniziale con le malinconiche TC And Honeybar e I Wanna Go To Marz, per esempio, che qualcuno sul Web ha paragonato addirittura a un mpstro sacro come I Talk To The Wind dei King Crimson.
Il problema sono gli arrangiamenti levigati, puliti, tipici di un certo AOR (Adult Oriented Rock) da classifica, un mucchio di citazioni e alcune melodie facili facili, assai semplici da mandare a memoria: alcuni pezzi ricordano, per citare il Grande Lebowski, i fottuti Eagles.
Where Dreams Go To Die e It’s Easier promettono bene, grazie alla voce calda e suadente di Grant, ma i rispettivi ritornelli sono davvero troppo melensi per le nostre povere orecchie indie.
Meglio Chicken Bones, un pezzo decisamente on the road – sembra di sentire i Little Feat di Willin’ e Trouble - e la marcetta pianistica Silver Platter Club, che pare invece Randy Newman o il primo Billy Joel.
Ancora un paio di episodi poco convincenti, ma poi nel finale l’album si riscatta alla grande: in Caramel Grant sembra fare il verso ad Antony & The Johnson, e c’è anche una bella coda sintetica in mellotron, mentre Leopard And Lamb e la title-track – grande atmosfera glam - hanno davvero un bel tiro.
Chissà se al Drugo sarebbe piaciuto.
Mah.
Mica sono i Creedence.
domenica 18 aprile 2010
Difficile immaginare due debutti così diversi, così lontani.
Soffice, leggero e innocente il primo.
Ruvido, sporco e sfrontato il secondo.
Eppure, sono i dischi che vanno in loop sul mio Ipod durante le lunghe passeggiate serali con il vecchio cane Oscar, adesso che è finalmente primavera e il cielo appare sterminato e senza nubi.
Jonsi – vero nome: Jón Þor Birgisson - è il leader degli islandesi Sigur Ros, band in assoluto tra le piu’ importanti dello scorso decennio. Qui è al suo debutto solista, intitolato semplicemente Go (Andiamo), anche se a dire il vero preceduto dallo sperimentale Riceboy Sleeps recentemente inciso in coppia con Alex Somers.
Per non ricadere nell’ovvio, lo straordinario vocalist dalla terra dei vulcani cerca di smarcarsi da un passato/presente così illustre - che tuttavia riaffiora in brani letteralmente senza tempo come le eteree Tornado e Kolniður, oltre che nella nenia incomprensibile Hengilás) - puntando su filastrocche bislacche e su un’immediatezza e una freschezza pop (il singolo Go Do, Animal Arithmetic e l’ottima Boy Lilikoi) che funzionano assai bene. Oltre che su una base ritmica piu’ solida (alle percussioni troviamo Samuli Kosminen dei Múm) e su una lunghezza dei brani piu’ contenuta del consueto; celebre il rifiuto dei Sigur Rós al Letterman Show: offrirono al gruppo solamente quattro minuti per suonare, un tempo troppo esiguo per lo stile della band.
Gonjasufi – vero nome: Sumach Valentine – è un personaggio alquanto strano, per usare un eufemismo.
Nero, rasta, insegnante di yoga, intellettuale mistico e inquieto, Dj ed ex-rapper, oggi artista di punta della scuderia WARP.
La sua opera prima è una delle produzioni piu’ sorprendenti di questa prima parte dell’anno, con il quale mescola con classe e irriverenza i piu’ disparati generi musicali: il trip hop (Portishead e Tricky) di Ancestors e di Change, il blues-rock gutturale di Suzie Q (Captain Beefheart) e She Gone, il folk bucolico di Sheep, l’elettronica vintage di I've Given e Holidays, il groove di Dust, la disco di Candylane, le citazioni terzomondiste dell’ottima Kowboyz And Indians, l’acid-rock psichedelico di Klowds (nella quale fa il verso addirittura a Jim Morrison) e della conclusiva Made.
E lo fa con un’inclinazione rigorosamente Lo-fi (fruscìi di fondo compresi) che fa pensare – oltre che a Frank Zappa - al primo, grandissimo, Beck.
Da seguire con attenzione.
Iscriviti a:
Post (Atom)