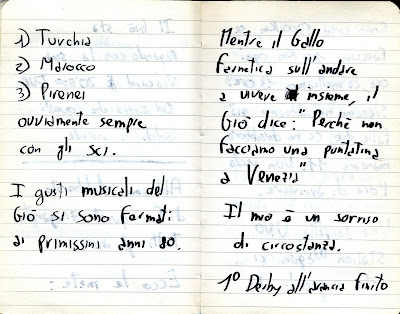giovedì 20 maggio 2010
domenica 16 maggio 2010
sabato 15 maggio 2010
Il colore viola del titolo raffigura alla perfezione il romanticismo tenebroso e crepuscolare della band newyorkese (originaria di Cincinnati, Ohio), con il passar del tempo assurta – al pari dei concittadini Interpol, il cui atteso nuovo disco è previsto a breve - da icona indie a “classico” del nuovo rock made in U.S.A.
Dare un seguito allo splendido e fortunatissimo Boxer (2007: con perle quali Mistaken For Strangers e Fake Empire, utilizzata da Obama per la campagna presidenziale del 2008) era un’impresa alquanto ardua.
I National – al debutto sulla storica label 4AD - optano per una linea di sostanziale continuità, con la consueta, raffinata miscela di post-punk, canzone d’autore e rock intellettuale (Joy Division, Leonard Cohen, Tindersticks), e per questo motivo non mancheranno di essere accusati di scarso coraggio: scelgono cioè di non voler tentare forzatamente la strada del nuovo, della sperimentazione, con il rischio di dar vita a creature incompiute o pasticciate (l’ultimo Editors, ad esempio).
Tuttavia, rispetto al recente passato, il loro sound appare talvolta meno claustrofobico e teso, e vira verso suoni e arrangiamenti piu’ ariosi e sofisticati, addirittura epici (Little Faith, England).
L’album si apre laddove i fratelli Dessner e Deavevano lasciato, con l’atmosfera cupamente dark di Terrible Love, le chitarre abrasive e la voce lamentosa del barbuto Matt Berninger (oltre a lui, la band è formata da una doppia coppia di fratelli: Aaron e Bryce Dessner; Scott e Bryan Devendorf) a tenere banco; l’opener track è, insieme al primo singolo Bloodbuzz Ohio, tra i brani maggiormente in linea con i fasti di Boxer.
Sorrow è invece la prima – in ordine temporale - di una serie di ballate malinconiche e struggenti (la bellissima Runaway – originariamente intitolata Karamazov e dedicata a Dostoyevsky - Lemonworld con quell’irresistibile coda: D-D-D-D-D-D-D-D, oltre alla conclusiva Vanderlyle Crybaby Geeks) che confermano il loro mestiere.
Chi ne avesse voglia, può cercare sul tubo la loro recente esibizione al Letterman Show (puntata del 13.05.10): hanno eseguito la languida Afraid Of Everyone con la partecipazione straordinaria di Sufjan Stevens per il backing vocals.
venerdì 14 maggio 2010
Cancrena, 05
In piedi vicino alla finestra della mia stanza da letto, raschiarata dalla luce di una vecchia lampada al kerosene, intravvedo il leggero pendio del prato e, poco oltre, un timido raggio di sole finalmente squarciare il tetro sipario di nuvole nere - finalmente una tregua.
Ho quasi finito di preparare i miei bagagli.
Non è una cosa facile: riporre le mie cose nelle valigie mi provoca emozioni intense, la mente si riempe di ricordi indelebili.
I nipoti del vecchio si presentarono - in formazione completa - per il giorno delle esequie. Impettiti e spocchiosi, nei loro abiti scuri da funerale.
Ricordo il silenzio che precedette la sepoltura. Il vento tirava violento sino a spazzare le cime dei cipressi del viale del piccolo camposanto.
La cerimonia fu dignitosa, considerate come si erano messe le cose all'inizio.
Il giorno successivo al decesso, quei maledetti avevano battuto il territorio per chiese e cimiteri, alla ricerca del conto piu' basso. Con questa crisi, persino i preti si fanno la guerra e noi dobbiamo aprofittarne, si dicevano tra loro mentre misuravano a passi la stanza del vecchio ormai senza vita. Un parroco di pianura offrì loro persino un comodo pagamento rateale, e una tessera a punti, valida anche per battesimi, comunioni, cresime e matrimoni: alla decima cerimonia avevi diritto a un'undicesima gratis.
Uomini che non conoscono la vergogna.
Fu allora che mi impuntai, e pretesi di seppellire il vecchio qui, nella sua terra, tra la sua gente.
Alla fine era venuto il momento di fare i conti.
L'appuntamento dal notaio fu fissato venti giorni esatti dopo il funerale.
Un nipote ragioniere era stato eletto il portavoce degli eredi. Era un tipo agguerrito, con un completo nuovo acquistato all'ipermercato e un foulard di seta nel taschino del gilet. Nervosamente, si rigirava tra le dita un piccolo codice di leggi, sul quale aveva appuntato una serie di segnalibri colorati. Al suo fianco erano schierati gli altri nipoti, con le loro consorti dal trucco un pò pesante.
Dall'altra parte del grande tavolo di legno massiccio, io sola. Cominciarono a tremarmi le gambe.
Il notaio, un omuncolo basso e secco con evidenti problemi di forfora, aprì la cassaforte, estrasse i documenti e, senza troppi preamboli, lesse con un filo di voce le estreme volontà del decujus, scandendo il ritmo con una serie infinita di omissis.
Il testamento del vecchio mi escludeva in modo definitivo.
Le sue proprietà spettavano ai suoi nipoti, suoi legittimi eredi, che adesso sembravano decisamente piu' sollevati e annuivano con la testa alla lettura del documento.
Eppure il vecchio...
Ti lascio questa vecchia casa, mi aveva detto in tono solenne nemmeno un mese prima, tu sei l'unica che puo' ancora evitarle una fine rovinosa e senza gloria.
Io mi ero buttata in lacrime ai suoi piedi: sentivo di non meritarlo.
Lui mi aveva accarezzato i capelli, sottili e castani come quelli di mia madre, che li raccoglieva sempre all'indietro in una lunga coda sin'oltre le scapole e la schiena, e mi aveva comandato di rialzarmi in piedi.
Non piagnucolare così, Cristo, aveva detto, mi fai venire voglia di cambiare idea.
E io lo so, che il vecchio non ha cambiato idea.
(Il parroco mi aveva avvertito. Mi aveva detto di non coltivare grandi aspettative. Sospettava che il notaio si sarebbe accordato con i parenti e che avrebbe fatto sparire l'originale del testamento, sostituendolo con un altro contraffatto ad arte. Sono cose che succedono, da queste parti, mi aveva detto sconsolato).
Sì, le cose dovevano essere andate così.
E così rimasi senza nulla (ma nulla meritavo).
Un'uggiosa mattina di ottobre ricevetti dalle mani del postino una raccomandata. Mentre firmavo l'avviso di ricevimento, lessi l'indirizzo del mittente in calce alla busta bianca e immacolata: erano loro.
Senza tanti preamboli, mi ringraziavano del lavoro svolto al servizio del loro amato nonno e mi lasciavano una settimana di tempo per far su le mie cose e lasciare la casa.
Temevano che io decidessi di rimanere quì ancora del tempo, che occupassi questa casa in modo abusivo, e quindi fecero sparire tutti i documenti e tutte le bollette e chiamarono dei tecnici per disdire i contratti del gas e della corrente elettrica.
Fecero murare l'ingresso del locale caldaia.
Fecero mettere dei piombini sui contatori della corrente elettrica.
Fecero tagliare i tubi del gas.
Prima di andare a dormire, mi sciacquo le ascelle con l’acqua gelida del fontanazzo giù in cortile, quello con la vasca in graniglia e il rubinetto di bronzo a forma di testa d'aquila.
Al buio, asciugo i capelli appoggiandoli con cautela alla vecchia stufa di ghisa, e intanto osservo la credenza con gli sportelli di vetro colorato, la credenza sulla quale il vecchio aveva attaccato con il nastro adesivo le fotografie della sua famiglia: riunioni di famiglia, ritratti di uomini e donne con l'abito della festa, scatti sfocati di bambini appena nati, gruppi chiassosi di ragazzi vestiti da piccoli ometti.
Mi avvicino e le osservo con attenzione, ancora una volta, assaporando ogni immagine e ogni ricordo come se quelli fossero ricordi miei, i ricordi della mia vita.
Strano, penso allora, di fotografie mie e della mia famiglia non ne conservo neppure una.
Fuori, cade ancora la pioggia.
mercoledì 12 maggio 2010
Frettolosamente catalogato nella categoria “Folk Inglese”, o Psych-Folk, questo debutto omonimo degli Erland & The Carnival è un’autentica rivelazione.
La stravagante band è composta da Erland Cooper, cantautore originario delle Isole Orcadi (Scozia), da Simon Tong (ex The Verve, The Good, The Bad & The Queen) e David Nock (The Orb, Fireman) e si è ispirata – nella scelta del nome - al compositore jazz Jackson C. Frank e alla sua My name is Carnival, la cui notevole cover è stata inserita nella tracklist dell’album.
Abilissimi nel mischiare i generi e le influenze piu’ disparate – tutto in un frullatore: organetti a là Doors; la psichedelia ’70: Love, Kaleidoskope; echi Pink Floyd prima maniera; il folk inglese ‘60/’70: Pentangle, Fairport Convention; il country sinfonico di Ennio Morricone, sempre piu’ di moda negli ultimi tempi – gli E&TC ripropongono un repertorio di brani tratti dalla tradizione folkloristica d'oltremanica (su tutte: l’ottima Was You Ever See, Love Is A Killing Thing; One morning fair, classico gallese qui in chiave rock; Tramps And Hawkers, che riporta alla mente addirittura il primo Tim Buckley - quello di Hallucinations, per intenderci), rivisitati con sbalorditiva intensità, originalità e freschezza.
A questo aggiungono alcune perle d’autore: la ballata fricchettona Disturbed This Morning, la lisergica The Echoing Green e The Sweeter The Girl The Harde, un garage che recupera una meravigliosa e scanzonata atmosfera sixties, tanto che non avrebbe certamente sfigurato nella mitica raccolta Nuggets.
Infine, Trouble In Mind, ovvero uno straordinario pezzo di indie-pop che – in un paese normale – sarebbe puntualmente in testa alle classifiche e alle heavy rotation di radio e tv.
Per noi di PiacenzaSera, Erland & The Carnival si inserisce di prepotenza nella lista dei migliori album di questo inizio di 2010.
E potrebbe restarci a lungo.
venerdì 7 maggio 2010

Ancora il Canada sugli scudi.
Dallo sterminato paese al nord degli USA – popolato, a giudizio degli yankees, da boscaioli dalla barba lunga dediti all’abuso di alcol e di sciroppo d’acero (l’ho assaggiato in una stanza d’albergo a Toronto, è terribile) – arrivano due nuovi album degni della nostra attenzione.
I Woodpigeon (ancora il nome di un uccello, come nel caso degli ottimi Shearwater, recensiti qualche tempo fa su PcSera) sono un collettivo che arriva da Calgary, cittadina altrimenti nota per le recenti Olimpiadi invernali.
La loro terza fatica, intitolata Die Stadt Muzikanten, è una buona raccolta di canzoni folk prevalentemente acustico a là C.S.N.&Y. (la title-track, Empty-Hall Sing-Along, Morningside), anche se non mancano improvvise accelerazioni elettriche (Such A Lucky Girl, Duck Duck Goose).
Purtroppo per noi, solamente per il mercato giapponese e per i primi acquirenti on-line dell’album, è stato offerto un album di dodici bonus track registrate con l’onnipresente Steve Albini, contenente una sequenza (sembra…) di brani grintosi e robusti, come da tradizione del vecchio Steve, e assai differenti dallo stile dell’album.
I Thee Silver Mt. Zion, da Montreal, sono invece una costola – o side-project – dei piu’ celebri Godspeed You Black Emperor!, alfieri post-rock, a giudizio di scrive uno dei progetti piu’ significativi, in assoluto, del decennio scorso.
L’opener There Is A Light e la conclusiva Piphany Rambler sono due lunghe suite che ripropongono il prog dilatato e magniloquiente tipico della casa madre.
I Built Myself A Metal Bird, invece, è un episodio decisamente piu’ ruvido, con il canto sincopato di Efrim in puro stile Pere Ubu.
Infine c’è spazio per una sequenza di brani piu’ rilassati e ipnotici, arrangiati con un proluvio di archi e chitarre, pensati come ipotesi diverse da svilupparsi a partire dallo stesso concetto: Kollapz Tradixional (Thee Olde Dirty Flag), Collapse Traditional (For Darling) e Kollaps Tradicional (Bury 3 Dynamos).
martedì 4 maggio 2010
domenica 25 aprile 2010
Cancrena, 04
Negli ultimi tempi, il vecchio si reggeva a malapena in piedi.
Tuttavia, non voleva che lo aiutassi.
Con le stampelle se la cavava benissimo, sosteneva lui.
E invece metteva il culo giu' in terra in continuazione, e poi restava lì delle ore, senza chiedere aiuto, in attesa degli eventi. Si faceva venire dei lividi bluastri grandi come delle padelle.
Lo so bene io - quante volte ho dovuto pulirglelo, quel suo culo flaccido.
Lui restava lì, in posizione supina dentro la vecchia vasca dai bordi increspati e dal fondo ingiallito, a tremare come un neonato.
Era morto nel sonno, all'alba di un bellissimo giorno di fine estate, mentre nei campi di erba medica già cantavano i grilli e le cicale.
Non c'era stato bisogno di autopsia o di esami particolari. Arresto cardiaco: questa la diagnosi del medico di famiglia, un uomo grassoccio e stempiato con un unico vestito di flanella grigia, che puzzava di sigari di bassa marca. Viveva da solo in un appartamento di dodici locali, completamente vuote, che aveva ereditato dalla facoltosa madre. Sotto la sua abitazione c’era l’ambulatorio, una piccola stanza buia e poco areata: l’unica finestra, di dimensioni minuscole, dava su un tetro cavedio per gli impianti condominiali.
C'era da aspettarselo, aveva commentato - scrollando la testa in segno di disapprovazione - il dottore, appena prima di salutare frettolosamente i primi parenti convenuti sul posto.
Tutti, in famiglia, avevano sofferto di problemi di circolazione.
Il padre era morto d'infarto, quando lui ancora portava i calzoncini corti e un paio di sandali scalcinati, e passava i suoi pomeriggi a inseguire le anatre starnazzanti nell'aia polverosa.
Per tutta la vita aveva provato a ricordarselo, suo padre, ma tutto quello a cui riusciva a pensare era un sorriso stanco, un patetico riporto di capelli unti sulla fronte stempiata e due occhi gelidi e distanti.
Oppure a quella volta che, da bambino, aveva sfondato il solaio del fienile ed era caduto di sotto, in mezzo ai liquami della stalla, e il padre l'aveva picchiato con la cinghia dei pantaloni.
Questo lo ricordava bene.
E anche le barrette di cioccolato bianco che suo padre nascondeva nel cassetto della scrivania del suo studio, e che ogni tanto gli dava dopo cena, senza farsi vedere da sua moglie che non approvava per niente.
E lui che zappava nell'orto poco dopo il tramonto.
E le due sterline d’oro che gli aveva regalato per la prima comunione.
Era andata ancor peggio allo zio di suo padre, stimato penalista in pensione e insignito - con cerimonia ufficiale - di una medaglia al valore e del titolo di cavaliere.
Una rara malattia lo aveva costretto su una carrozzella. Il sangue aveva progressivamente smesso di circolare nelle sue vene e i muscoli si erano pertanto atrofizzati, sino ad incancrenirsi: uno dopo l’altro, i medici erano stati costretti ad amputargli tutti e quattro gli arti, prima le gambe e poi le braccia.
Così facendo, avevano creato un mostro - un’assurda e miserabile larva umana.
Lo zio trascorreva il suo tempo su una carrozzella, parcheggiata sotto la pianta del fico, borbottando sommesse e oscene litanie.
Una volta addormentato, il mollusco – questo era il gentile nomignolo affibbiatogli dai figli dei mezzadri - costituiva un facile bersaglio e, così, nascosti dietro la siepe, i teppistelli lo colpivano ripetutamente con pirioli di carta sparati da cerbottane di plastica dura. Talvolta il piriolo veniva incendiato con un cerino appena prima del lancio, oppure veniva dotato di uno spillo, sadicamente infilato proprio nella punta del cono costruito con vecchi giornali. Nelle torride giornate d’estate, lo zio era il facile obiettivo di fitti lanci di gavettoni d’acqua dal balconcino del bagno del primo piano. Non solo, accerchiato al centro dell’aia, sopportava con eroica pazienza l'assedio di una tribu' di mocciosi travestiti da pellerossa, con le piume delle galline appena spennate sulla testa.
Il vecchio mi aveva piu' volte raccontato della faccia atterrita di suo zio quando, appena svegliatosi da una pennica pomeridiana, si ritrovò alcune pelli di fico spalmate sul cranio lucido.
Da quell’improvvisato copricapo, viscido e vellutato, il succo dei frutti colava sulle guance del vecchio, mescolandosi con lacrime amare di umiliazione.
sabato 24 aprile 2010
I texani Midlake sono tra le bands piu’ attive del momento.
Pochi mesi orsono è uscito per la label Bella Union il loro terzo album (“The Courage Of Others”), con il quale sembrano aver abbandonato le atmosfere lisergiche degli esordi per approdare a un folk assai piu’ tradizionale e classico, seppur terribilmente monocorde.
A poca distanza, eccoli di nuovo in veste di co-produttori (e musicisti) dell’opera prima di John Grant - ex-leader degli Czars, da Denver, Colorado, al rientro dopo una fase a dir poco turbolenta della sua vita, caratterizzata da eccessi vari – accolta oltreoceano e nel Regno Unito dall’ovazione quasi unanime da parte della critica (5 stelle su 5 per Mojo).
Anche Grant trae ispirazione dai grandi classici del passato, prima di tutto il grande rock americano degli anni anni Settanta.
Ed è - è doveroso ammetterlo - capace di scrivere ottime canzoni.
Come la doppietta iniziale con le malinconiche TC And Honeybar e I Wanna Go To Marz, per esempio, che qualcuno sul Web ha paragonato addirittura a un mpstro sacro come I Talk To The Wind dei King Crimson.
Il problema sono gli arrangiamenti levigati, puliti, tipici di un certo AOR (Adult Oriented Rock) da classifica, un mucchio di citazioni e alcune melodie facili facili, assai semplici da mandare a memoria: alcuni pezzi ricordano, per citare il Grande Lebowski, i fottuti Eagles.
Where Dreams Go To Die e It’s Easier promettono bene, grazie alla voce calda e suadente di Grant, ma i rispettivi ritornelli sono davvero troppo melensi per le nostre povere orecchie indie.
Meglio Chicken Bones, un pezzo decisamente on the road – sembra di sentire i Little Feat di Willin’ e Trouble - e la marcetta pianistica Silver Platter Club, che pare invece Randy Newman o il primo Billy Joel.
Ancora un paio di episodi poco convincenti, ma poi nel finale l’album si riscatta alla grande: in Caramel Grant sembra fare il verso ad Antony & The Johnson, e c’è anche una bella coda sintetica in mellotron, mentre Leopard And Lamb e la title-track – grande atmosfera glam - hanno davvero un bel tiro.
Chissà se al Drugo sarebbe piaciuto.
Mah.
Mica sono i Creedence.
Pochi mesi orsono è uscito per la label Bella Union il loro terzo album (“The Courage Of Others”), con il quale sembrano aver abbandonato le atmosfere lisergiche degli esordi per approdare a un folk assai piu’ tradizionale e classico, seppur terribilmente monocorde.
A poca distanza, eccoli di nuovo in veste di co-produttori (e musicisti) dell’opera prima di John Grant - ex-leader degli Czars, da Denver, Colorado, al rientro dopo una fase a dir poco turbolenta della sua vita, caratterizzata da eccessi vari – accolta oltreoceano e nel Regno Unito dall’ovazione quasi unanime da parte della critica (5 stelle su 5 per Mojo).
Anche Grant trae ispirazione dai grandi classici del passato, prima di tutto il grande rock americano degli anni anni Settanta.
Ed è - è doveroso ammetterlo - capace di scrivere ottime canzoni.
Come la doppietta iniziale con le malinconiche TC And Honeybar e I Wanna Go To Marz, per esempio, che qualcuno sul Web ha paragonato addirittura a un mpstro sacro come I Talk To The Wind dei King Crimson.
Il problema sono gli arrangiamenti levigati, puliti, tipici di un certo AOR (Adult Oriented Rock) da classifica, un mucchio di citazioni e alcune melodie facili facili, assai semplici da mandare a memoria: alcuni pezzi ricordano, per citare il Grande Lebowski, i fottuti Eagles.
Where Dreams Go To Die e It’s Easier promettono bene, grazie alla voce calda e suadente di Grant, ma i rispettivi ritornelli sono davvero troppo melensi per le nostre povere orecchie indie.
Meglio Chicken Bones, un pezzo decisamente on the road – sembra di sentire i Little Feat di Willin’ e Trouble - e la marcetta pianistica Silver Platter Club, che pare invece Randy Newman o il primo Billy Joel.
Ancora un paio di episodi poco convincenti, ma poi nel finale l’album si riscatta alla grande: in Caramel Grant sembra fare il verso ad Antony & The Johnson, e c’è anche una bella coda sintetica in mellotron, mentre Leopard And Lamb e la title-track – grande atmosfera glam - hanno davvero un bel tiro.
Chissà se al Drugo sarebbe piaciuto.
Mah.
Mica sono i Creedence.
domenica 18 aprile 2010
Difficile immaginare due debutti così diversi, così lontani.
Soffice, leggero e innocente il primo.
Ruvido, sporco e sfrontato il secondo.
Eppure, sono i dischi che vanno in loop sul mio Ipod durante le lunghe passeggiate serali con il vecchio cane Oscar, adesso che è finalmente primavera e il cielo appare sterminato e senza nubi.
Jonsi – vero nome: Jón Þor Birgisson - è il leader degli islandesi Sigur Ros, band in assoluto tra le piu’ importanti dello scorso decennio. Qui è al suo debutto solista, intitolato semplicemente Go (Andiamo), anche se a dire il vero preceduto dallo sperimentale Riceboy Sleeps recentemente inciso in coppia con Alex Somers.
Per non ricadere nell’ovvio, lo straordinario vocalist dalla terra dei vulcani cerca di smarcarsi da un passato/presente così illustre - che tuttavia riaffiora in brani letteralmente senza tempo come le eteree Tornado e Kolniður, oltre che nella nenia incomprensibile Hengilás) - puntando su filastrocche bislacche e su un’immediatezza e una freschezza pop (il singolo Go Do, Animal Arithmetic e l’ottima Boy Lilikoi) che funzionano assai bene. Oltre che su una base ritmica piu’ solida (alle percussioni troviamo Samuli Kosminen dei Múm) e su una lunghezza dei brani piu’ contenuta del consueto; celebre il rifiuto dei Sigur Rós al Letterman Show: offrirono al gruppo solamente quattro minuti per suonare, un tempo troppo esiguo per lo stile della band.
Gonjasufi – vero nome: Sumach Valentine – è un personaggio alquanto strano, per usare un eufemismo.
Nero, rasta, insegnante di yoga, intellettuale mistico e inquieto, Dj ed ex-rapper, oggi artista di punta della scuderia WARP.
La sua opera prima è una delle produzioni piu’ sorprendenti di questa prima parte dell’anno, con il quale mescola con classe e irriverenza i piu’ disparati generi musicali: il trip hop (Portishead e Tricky) di Ancestors e di Change, il blues-rock gutturale di Suzie Q (Captain Beefheart) e She Gone, il folk bucolico di Sheep, l’elettronica vintage di I've Given e Holidays, il groove di Dust, la disco di Candylane, le citazioni terzomondiste dell’ottima Kowboyz And Indians, l’acid-rock psichedelico di Klowds (nella quale fa il verso addirittura a Jim Morrison) e della conclusiva Made.
E lo fa con un’inclinazione rigorosamente Lo-fi (fruscìi di fondo compresi) che fa pensare – oltre che a Frank Zappa - al primo, grandissimo, Beck.
Da seguire con attenzione.
venerdì 16 aprile 2010
Cancrena, 03
I primi tempi, avevo paura del vecchio.
Ero arrivata dal mio paese con una piccola valigia tutta sgualcita, non ancora maggiorenne: una ragazza timida e insicura, con un vocabolario stentato e ridotto all'osso, venti parole o poco piu', apprese da un corso acquistato al mio paese per corrispondenza.
Io restavo sempre sull’attenti, come un vecchio maggiordomo.
Lui mi trattava male.
Ci aveva preso gusto, quel maiale.
Ed era anche irascibile.
Per un nonnulla, era capace di strillare come un pazzo. Andava letteralmente fuori di testa. Sbatteva i pugni contro il muro. Ci fu una volta persino che si ferì alle nocche delle dita, e io fui costretta a portarlo all'ospedale per farlo cucire con un paio di punti di sutura. All'infermiera aveva raccontato che si era chiuso la mano nel grande cancello di ferro, quel vecchio cancello che demilimitava la proprietà privata - oltre gli orti, appena piu' in là del ciglio della strada.
Quando era di cattivo umore - ed era spesso di cattivo umore - spostava tutte le cose dal loro posto.
Così, senza motivo.
Solo per farmi un dispetto.
Eppure.
Eppure, nonostante tutto, io avevo finito per affezionarmi a lui.
Non foss'altro che per l'abitudine.
Passavamo insieme lunghi pomeriggi, con la pioggia o con il sole, io e lui soli nel silenzio spettrale di quella vecchia casa che - ora - restava ai margini della storia.
Davanti al fuoco, il vecchio mi raccontava la sua storia, con l'aria complice di chi ti sta facendo chissà quali confidenze. Si ricordava tutto, del suo passato.
Come tutti gli anziani, non avrebbe saputo dire dove aveva messo la scatola dei fiammiferi che lui stesso aveva usato soltanto qualche istante prima, ma era in grado di ricostruire episodi avvenuti da tempo immemorabile, con una precisione assoluta. Con un’attenzione maniacale per i dettagli. Forse qualcosa se lo inventava sul momento - è possibile, anzi probabile, adesso che ci penso - ma per me non cambiava nulla.
Restavo pazientemente ad ascoltarlo.
Era quello di cui aveva bisogno, in fondo: qualcuno che lo ascoltasse, non chiedeva altro.
Qualche volta avrei voluto persino prendergli una mano, quella sua mano rugosa con le vene rigonfie - così gonfie che sembrava potessero esplodere da un momento all'altro.
Non l'ho mai fatto per paura di essere male interpretata.
Le conoscete anche voi, le storie che si mettono in giro sulle badanti.
Non lo credereste, ma il vecchio era capace di piccole dolcezze.
Ogni tanto mi lasciava bere un po’ di vino, quel lambrusco frizzante da pochi soldi che mi mandava a comprare tutti i sabati al banco del mercato. Me lo davano in un contenitore di plastica, tipo le taniche che normalmente si usano per la nafta del trattore. Il tappo veniva avvitato con forza ma anche così non teneva piu' di tanto e così mi ritrovavo con i sedili della vecchia utilitaria tutti inzuppati.
Vino buono come questo non ce n'è, ripeteva lui. Lo fanno ancora come si faceva una volta. Mica tutti quegli additivi che ci mettono adesso. Altrochè.
Io annuivo, cosa volete che sappia io, di vino. Da noi si beve solo vodka. Ormai i nostri uomini sono tutti scemi, a furia di bere vodka.
In cambio delle sue piccole gentilezze, io lo facevo vincere a scopa.
Non ci stava, a perdere, quel bastardo.
Con una donna, poi - non sia mai: il massimo dell'umiliazione.
Non se poteva proprio parlare.
Così io scartavo le carte sbagliate e lui mi riprendeva bonariamente per i miei errori marchiani.
E ripeteva che le donne non erano fatte per giocare con le carte, anche se forse si era accorto che io sbagliavo apposta, così, solo per farlo contento.
sabato 10 aprile 2010
La ricetta dei Baustelle, in fondo, è sempre la medesima: melodie accattivanti - semplici e immediate-, arrangiamenti orchestrali, testi impegnati e molto elaborati, malinconia e nichilismo.
Anche stavolta è così, malgrado la superproduzione di Pat McCarthy (U2, R.E.M.) apra la strada a un sound piu’ americano e diretto rispetto al passato. L’influenza della band georgiana, infatti, è evidente e la rivisitazione della chitarra jingle-jangle alla Byrds è qui riproposta con deliberata sfacciataggine: addirittura, è incredibile non trovare Peter Buck tra i credits della scialba La Canzone Della Rivoluzione…
Le altre novità, in breve: un’atmosfera evocativa da spaghetti-western, stile Ennio Morricone, l’abbandono del consueto citazionismo colto – diciamolo pure: Bianconi, tipico intellettuale snobbone, in questo disco se la tira un po’ meno, anche se nella title-track compare Jacopone da Todi – e dei duetti tra lo stesso Bianconi e la Bastreghi: per quest’ultima, molto meno spazio rispetto ai precedenti, celebratissimi, album.
Quasi ovunque, poi, aleggia lo spirito del grande De Andrè.
Nell’intro suggestivo L’indaco, che ci riporta alla mente Le Nuvole di Fabrizio.
Nella conclusiva L’ultima Notte Felice Del Mondo, la cui sezione fiati ricorda La Canzone Dell’Amore Perduto.
E ancora nella title-track, la quale peraltro sfodera un indovinato ritornello tipicamente Baustelle: non so voi, ma per me canticchiare “No/ci salveremo disprezzando la realtà/e questo mucchio di coglioni sparirà/e ne denaro e ne passione servirà/gentili ascoltatori siamo nullità/equipaggi persi in alto mare/forse il presidente non lo sa” è un’esperienza davvero catartica, soprattutto dopo aver ascoltato i titoli di testa del TG1 di Augusto Minzolini e un’intervista radio ad Angelino Alfano.
Il disco parte forte.
Oltre ai pezzi già citati, c’è la psichedelica San Francesco, il singolo Gli Spietati – con in coda un omaggio a Rino Gaetano di Mio Fratello E’ Figlio Unico – e soprattutto la suggestiva Follonica, ingeneroso e deprimente ritratto della terra toscana natìa (“Facciamo un pò di sesso/facciamolo lo stesso/per ricordarci di esser vivi/sulla spiaggia di Follonica”), e Le Rane. Quest’ultima, che si candida a nostro giudizio a diventare il secondo – irresistibile - singolo, è una riflessione nemmeno troppo sofisticata sul tempo che inesorabilmente sfugge ("Che fine hai fatto?/ ti sei sistemato?/che prezzo hai pagato?/che effetto ti fa?/vivi ancora in provincia?/ci pensi ogni tanto alle rane?/L'ultima volta ti ho visto cambiato/bevevi un amaro al bancone del bar/perché il tempo ci sfugge/ma il segno del tempo rimane"), mentre la base ritmica somiglia troppo a quella un pezzo dei Blur, quale sia non mi viene in mente ora.
Nella seconda parte del disco la tensione inevitabilmente cala, e con la tensione le emozioni.
Con la stanchezza riaffiorano poi vecchi vizi della band: l’eccessiva orecchiabilità, che confina qua e là con la banalità, alcuni arrangiamenti troppo ricercati; persino alcuni testi (La bambolina, Il sottoscritto) appaiono un po’ scontati.
Nel complesso, tuttavia, non un capolavoro memorabile ma un’opera intelligente e godibile, anche se non così facile come potrebbe sembrare al primo impatto.
Eppure, ne siamo sicuri, non mancheranno le stroncature.
Ma certi siti di critica rock, si sa, quando trattano la musica nostrana ricordano le nostre madri, che quando eravamo bambini ci dicevano sempre: proprio non sei mai contento!
Forse non perdoneranno alla band di Montepulciano la collaborazione con Irene Grandi al Festival di Sanremo - brutta compagnia, in effetti: tra lo sfigato che fa l’amore in mezzo ai laghi e il principe Savoia che stona con Pupo e Marcello Lippi, ce ne sarebbe abbastanza per chiedere l’espatrio – oppure la loro presunta svolta commerciale, la firma con una mayor e il cedimento alle logiche del Mercato e bla bla bla.
Noi ci accontentiamo di questi Mistici Dell’Occidente.
Anzi, come dicevano i nostri vecchi:
Cara di grazia.
mercoledì 31 marzo 2010
Cancrena, 02
Mi è spiaciuto, per il vecchio.
Intendo dire, mi spiace di dovermene andare via da qui, da questa casa che ormai un pò mi apparteneva. Mi spiace di essere rimasta senza un posto dove stare e tutto quanto. Ovvio che mi spiace per questo - non sono un'ipocrita.
Ma non è solo questo.
La morte di quel vecchio bastardo mi ha addolorato, sul serio.
Non lo dico per piaggeria.
D'altro canto, che motivo avrei per fingere, ora che lui non c'è più?
Il vecchio era uno stronzo di merda.
E' così, è inutile negarlo, adesso.
Aveva un pessimo carattere (lui stesso lo riconosceva, nei rari ed effimeri momenti di serenità).
Era prepotente.
A comandare si era dovuto abituare assai presto, da quando era diventato - subito dopo una laurea a pieni voti in legge - il capo di un'illustre stirpe che aveva fatto la storia del paese. Aveva gestito gli affari da autentico patriarca.
La sua era sempre stata una famiglia assai ricca.
Amava raccontare che, ai tempi belli, quando faceva il brodo sua madre era solita buttare via la carne. Quando poi le cose svoltarono per il peggio, seppero comunque resistere alla grande crisi, subito dopo l'ultima guerra, stringendo la cinghia e dannadosi l'anima per riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena. E così risalirono la china, lentamente, fino a tornare a essere la piu' grande azienda agricola di tutto il paese, anzi dell'intera provincia.
Dopo, i suoi nipoti si erano mangiati tutto, o quasi, avevano dilapidato una fortuna. Avevano aperto una nuova ditta, facendola presto fallire, e poi un'altra, e un'altra ancora, una serie desolante di tentativi morti sul nascere, sino all'inesorabile crac finanziario.
Per ripianare i debiti, avevano dovuto vendere i gioielli di famiglia.
Di questo passo, commentava amaro il vecchio, avrebbero fatto la fine dei loro acerrimi rivali di un tempo - quei farabutti si erano ridotti a dormire con i polli e i conigli in soggiorno, e facevano pure i turni di guardia perché avevano paura che qualche balordo glieli portasse via durante la notte.
Di quell'immenso patrimonio l'unica cosa che resta, ora, è questa vecchia casa diroccata.
Una volta, era una villa padronale immersa in un parco lussureggiante di ippocastani e querce secolari, con il tronco contorto e la chioma maestosa. Sul retro, l’aia inghiaiata era coperta dalla vite rampicante che in estate, fittamente appesa a un traliccio di fili di ferro ormai arrugginiti, costituiva uno scudo impenetrabile ai raggi del sole. Sotto la pianta dei fichi, poco distante da lì, una fila di seggiole in metallo arrugginito era allineata a un muretto di sassi coperto di muschio. Alla sua ombra il vecchio era solito accogliere il tepore della primavera, discorrendo con i mezzadri dell’inesorabile passare del tempo.
Della vita e della morte.
E del lavoro, quello duro, che aveva conosciuto sin da bambino nei campi di granoturco e di orzo, disposti lì attorno sino alla strada provinciale che porta in città.
lunedì 29 marzo 2010







Estratti dal Golden Dossier
http://shearwatermusic.com/
E chi li conosceva, questi Shearwater.
Nati come side-project dei piu’ celebri Okkervil River, ovvero come iniziativa collaterale di due loro membri (Will Sheff e Jonathan Meiburg; gli altri sono Howard Draper, Kim Burke e Thor Harris), giungono nel disinteresse generale alla conclusione di un’interessante trilogia - iniziata nel 2006 con “Palo Alto” e proseguita con “Rook” – dedicata, senza mezzi termini, alla distruzione del pianeta da parte dell’uomo.
"The Golden Arcipelago"e’ un un inno ecologista solenne e magniloquente , un vero e proprio concept ispirato alla vita degli abitanti delle isole Bikini, un luogo ideale e idealizzato posto ai confini del mondo e assai lontano alla cosiddetta civiltà occidentale.
Insieme all’album è possibile acquistare il volume “The Golden Dossier”, che mette insieme le immagini e le testimonianze accumulate dal leader durante i suoi viaggi nei luoghi più sperduti della terra: fotografie di aborigeni e progetti navali si accompagnano ad antiche mappe ed appunti di viaggio (qui da noi è impossibile trovarlo, ma è possibile scaricare gratuitamente la versione digitale dal sito ufficiale della band: http://shearwatermusic.com/).
La musica.
Le origini folk della band di Austin appaiono in questo nuovo capitolo piu’ sfocate, e le atmosfere bucoliche e sfumate degli esordi (“Hidden Lakes” e “Meridian”, aperta da un canto tribale) lasciano spazio a un rock concettuale e barocco, la cui accuratezza nei dettagli e la cui eleganza formale sfiorano il manierismo.
“Black Eyes” e “Corridors” sfoderano un’epica ampollosa stile prog ’70 (Van Der Graaf Generator) - la voce di Meiburg a tratti ricorda proprio il Peter Hammill piu’ declamatorio – mentre poetiche ed evocative sono il singolo “Castaways” e “God Made Me”, con un testo misticheggiante e un buon crescendo elettrico.
Il disco si chiude con due ballate appena sussurrate, “Uniforms” e “Missing Islands”, in bilico tra Radiohead e Sigur Ros.
mercoledì 24 marzo 2010
Tuttavia, noi di PiacenzaSera siamo un po’ come la Questura di Roma, e quindi ci tocca ridimensionare il tutto. Dice: siamo piu’ di un milione. E loro: in piazza c’erano centomila persone.
Per “Plastic Beach” vale lo discorso recentemente esposto per l’ultimo dei Massive Attack: anche qui c’è un po’ di tutto, è il trionfo dell’eclettismo postmoderno piu’ modaiolo, e alla fine non si capisce dove si vuole andare a parare.
Prima di tutto, ci sono i soliti pezzi hip-hop.
Superfast Jellyfish vede la partecipazione dei De La Soul e i Super Furry Animals, la scialba Sweepstakes di Mos Def, e infine Welcome To The Plastic Beach mette in mostra uno Snoop Dogg sopra le righe che cita Gil Scott-Heron (a proposito, è di questi giorni il suo ritorno con “I’m Here Now”, ottimo, che contiene tra l’altro una imperdibile cover di I’ll Take Care Of You di Mark Lanegan) e la sua The Revolution Will Be (Not) Televised.
C’è qualche ammiccamento alla world-music (White Flag, con un inutile introduzione in stile magrebino) e all’elettronica facile degli eighties (la coda sintetica di Empire Ants).
E c’è la consueta parata di stelle.
Ma nemmeno l’immenso Lou Reed riesce a nascondere la normalità – che sfiora la mediocrità - di Some Kind Of Nature (però che bella sensazione sentire lo spocchioso Albarn che gli fa il coro), mentre Mark E. Smith dei mitici Fall non fa quasi nulla in Glitter Freeze, a parte sbraitare qualche frase sconnessa attraverso un megafono annegato in un tappeto di sintetizzatori.
Il singolo Stylo – eseguito con Bobby Womack - è piuttosto insipido e di memorabile ha solo il videoclip on the road in stile Kowalski in Punto Zero. Inoltre è causa di una denuncia per plagio addirittura da parte di Eddy Grant…
Molto meglio Rhinestone Eyes, con un ritornello killer (Under sunshine pylons we'll meet while rain is falling like rhinestones from the sky) in puro stile Gorillaz.
Piu’ in generale, i pezzi migliori del lotto - salvo rarissime eccezioni - sono quelli per i quali Albarn conserva per sé il ruolo principale (To Binge, Broken, la conclusiva, breve, Pirate Jet).
Oltre naturalmente alla title-track (It's a Casio on a plastic beach/It's a styrofoam deepsea landfill/It's sort of made a computer speech/It's a Casio on a plastic beach/It's a Casio), con i grandissimi Mick Jones e Paul Simonon che ci fanno rivivere per un attimo l’epopea Clash.
Qualcuno ha già candidato “Plastic Beach” tra i dischi dell’anno 2010.
Per noi, che siamo come la Questura, è uno dei migliori del mese, anzi, di questa settimana.
domenica 21 marzo 2010
Cancrena, 01
Non smette piu' di piovere.
Ormai sono due settimane che viene giu', senza soste.
E il tetto continua a perdere.
L'anno scorso un uomo era salito sul tetto, era un muratore con due mani grosse come badili, lo aveva mandato il parroco, non avevo nessun altro a cui chiedere e così ho chiesto a lui. Quell'uomo aveva sostituito una dozzina di tegole rotte, ne aveva spostate altre quà e là, ma nulla era cambiato.
Andrebbe rifatto, quel tetto, mi aveva detto mentre scendeva sconsolato da una lunga scala a pioli appoggiata al muro maestro.
L'unica cosa che mi rimane da fare è sistemare una fila di secchi di plastica contro la parete ammuffita. A guardarli vuoti, quei secchi sembrano capienti, e invece si riempono alla svelta. Ogni mattina devo andare a svuotarli in cortile, altrimenti va a finire che si allaga pure il solaio, e allora sono guai seri.
E andrà pure peggio, almeno così dice la radio. Perturbazioni in arrivo dal nord. La temperatura scenderà sotto lo zero e ogni cosa, assai presto, sarà avvolta da un soffice velo di coltre bianca e lucente.
Sotto il peso della neve, il tetto potrebbe davvero crollare.
In fondo, a me non dovrebbe importare nulla.
Quel giorno, sarò già lontana da qui.
Quel giorno avrò trovato rifugio in un paese piu' caldo e piu' ospitale di questo, oppure, chissà, sarò di nuovo nella mia terra natìa, dove l'inverno è ancora piu' lungo e rigido che qui.
Qui dove non posso restare oltre.
Da quando è morto il vecchio, infatti, non mi resta nulla da fare.
Cerco di riempire il vuoto che incombe occupandomi delle faccende che ero solita sbrigare quando il vecchio era ancora vivo, un rimedio come un altro per scacciare via la nostalgia.
Sposto a fatica i grandi vasi degli oleandri. Li trascino sul vialetto facendo leva con il peso del mio corpo, sino a metterli al riparo sotto una misera tettoia di carta catramata. Altrimenti durante la notte gelerebbero.
Raccolgo le foglie secche ancora rimaste in terra. Odio vederle lì in giro, sparpagliate dappertutto. Per fortuna, il rastrello scivola leggero sull'erba viscida, rendendo tutto piu' semplice.
Accatasto le fascine di legna in mucchietti sempre uguali, laggiù in fondo, oltre la distesa di erba medica, e pazientemente le lego insieme con uno spago sottile e robusto.
Scelgo con cura i pezzi di carpino per la stufa, prelevandoli da una catasta sotto il pergolato quasi nascosto dai rampicanti.
Spazzo l'aia inghiaiata con una vecchia scopa di saggina.
Poi rientro in casa e accendo la televisione, un vecchio monitor ancora in bianco e nero, che chissà da quanti anni rimane al suo posto sopra la piccola credenza. Il segnale è disturbato. Non c'è verso di metterla a posto. Giù in paese, mi hanno detto che non si trovano piu' i pezzi di ricambio.
Accendo il fuoco sotto la cucina economica e preparo la minestra di grano saraceno, quella che voleva sempre il vecchio.
Spolvero la vecchia biblioteca di legno massiccio. Ogni tanto mi capita di prendere in mano uno di quegli antichi manoscritti, uno a caso, e di sfogliarlo distrattamente, così, per passare il tempo. Sul margine di pagine ingiallite e stropicciate, il vecchio aveva appuntato i suoi commenti con quella sua strana calligrafia, così fitta, per decifrarli devo usare la lente di ingrandimento. Lui ne teneva una sempre nel taschino del gilet.
Alla fine della giornata, esausta, mi lascio cadere sul vecchio sofà di finta pelle color crema, osservo il soffitto inzuppato d'acqua - minuscole gocce cadono ticchettando sul pavimento in graniglia - e aspetto che arrivi il momento di andare via.
Il mio biglietto aereo arriverà per posta.
L'ho prenotato su internet, anzi, lo ha prenotato il parroco per me. Si è fatto aiutare da un chierichetto, un ragazzo magro magro che abita nella casa appena oltre il fosso. Non ci capisco nulla, io. E poi non ho mica un computer. A voler essere precisi, non ho piu' nemmeno la corrente elettrica. Me l'hanno tagliata che è ormai una settimana. All'oratorio, invece, un computer ce l'hanno, e hanno anche una televisione con lo schermo tanto grande che tiene quasi tutta una parete. Fino all'anno scorso ci andavo anch'io, con il vecchio, a vedere i film della rassegna culturale, andava sempre a finire che lui si addormentava prima dell'intervallo, e riportarlo a casa era un'impresa davvero ardua. Dovevano aiutarmi in tre o quattro, scelti tra i piu' robusti in platea, per spostare quel vecchio flaccido a peso morto. Il dottore lo diceva sempre, che doveva dimagrire. Ma lui niente. Mangiava come un porco. E poi c'era il fatto che si metteva a russare disturbando, è inevitabile, gli altri spettatori. Una volta, era una commedia americana con quell'attrice che mi piace tanto, come si chiama, non mi ricordo il nome, beh, insomma, dovettero persino riavvolgere il nastro per proiettare di nuovo una scena del film, tanto che non si era capito nulla.
martedì 16 marzo 2010
C'è stato un tempo, irripetibile, delle etichette indipendenti.
A Chicago c'era la Touch&Go (Big Black, Jesus Lizard), a Washington D.C. la Dischord, gravitante attorno alla figura carismatica di Ian MacKaye dei Fugazi, e a New York la Matador (Pavement, Sonic Youth). In California la SST (Husker Du, Minutemen, Meat Puppets, Dinosaur Jr), la Restless (Replacements, Flaming Lips) e la Alternative Tentacles (Dead Kennedys). Oltreoceano, la 4AD (Dead Can Dance, The The, Pixies), la Rough Trade e la Creation (Jesus & Mary Chain, Ride, Felt), oltre alla Strange Fruit fondata da John Peel della BBC.
La Sub Pop di Seattle fu una delle piu' importanti. Attorno a essa si radunò infatti la scena grunge, ancora agli albori, e fu la casa discografica di Bruce Pavitt a scoprire i Nirvana, che tuttavia scelsero una major (Geffen) per spaccare tutto e incidere l'epocale Nevermind (1991). Un vero e proprio punto di svolta: dopo, nulla restò uguale, e il cosiddetto indie-rock diventò l'ennesima mucca da mungere da parte del mercato ufficiale.
Dopo un periodo di crisi, la Sub Pop è tornata da alcuni anni a essere un punto di riferimento per la scena alternativa a stelle e strisce.
In questo scorcio di inizio anno, il suo catalogo si è impreziosito di due ulteriori gemme.
The Album Leaf è un progetto ormai piu' che decennale di Jimmy Lavalle, da San Diego, pioniere del post-rock (Tristeza). "A Chorus Of Storytellers" è il loro sesto album, dove, accanto a una serie di ottime composizioni strumentali dall'accento nordico (Summer Fog, Blank Pages) trovano spazio anche una manciata di canzoni (la sognante Falling From The Sun, There Is A Wind, Almost There) nel senso piu' tradizionale del termine.
Ancor piu' bello "Teen Dream", ultima fatica dei Beach House da Baltimora.
La prima parte dell'album - quella che una volta avremmo chiamato la Side A - sfiora addirittura la perfezione: ascoltare Zebra, con il suo straordinario intro acustico, la fantastica ballata Silver Soul (Cocteau Twins al rallentatore), il singolo Norway, che potrebbe uscire da uno dei due capolavori dei My Bloody Valentine, Walk In The Park , con la voce di Victoria Legrand che ricorda davvero quella di Nico, e la delicata, pianistica, Used To Be.
Nella parte residua del disco si resta ad alti livelli, senza cadute di tensione o di stile, sino alla conclusiva Take Care, velvettiana sino al midollo.
mercoledì 3 marzo 2010
Davvero non riesco a capacitarmi – dopo un primo sommario ascolto - dell’enfasi con la quale la critica specializzata ha accolto questo nuovo secondo disco dei Vampire Weekend, sopravvalutata band di newyorkesi fighetti autori di un etno-folk elettrico un po’ naive e un po’ furbastro, e allora decido di andare a cercare qualche notizia sui nostri sul web.
Leggo su Wikipedia: “I Vampire Weekend sono una band indie/afro-pop americana, formatasi a New York nel 2006”.
Spulcio da un’intervista rilasciata dal leader della band, Ezra Koenig, a Onda Rock: “Penso che siamo attratti dalla musica africana perché è un tipo di musica che usa strumenti rock occidentali ma in un modo molto differente ed eccitante. E poi c’era una compilation di musica pop anni Ottanta del Madagascar molto minimalista che ascoltavamo sempre, con suoni di chitarra molto puliti: è stata un’ispirazione decisiva quando abbiamo iniziato a suonare insieme”.
Dappertutto si citano i Talking Heads di Fear Of Music, il Peter Gabriel piu’ terzomondista, Paul Simon, i Feelies.
Mah.
Ritento (sarò piu’ fortunato?)
Per dirla tutta, sin’ora sono riuscito ad ascoltare “Contra” solo attraverso i piccoli autoparlanti dell’Ipod, seduto su una seggiovia monoposto – di quelle di una volta, che devi tenerti tieni gli sci in mano – e quindi è decisione saggia del recensore quella di non abbandonarsi alla prima impressione, sostanzialmente negativa, e di dare loro almeno una seconda possibilità.
Anche se quella orrenda cover – con tanto di marchio di Ralph Lauren in bella vista - sembrerebbe già parlare da sola…
E infatti non va molto meglio.
Ascoltate l’attacco del singolo Horchata (tra parentesi, la beveva sempre anche mio nonno, che però la mescolava con lo sciroppo al tamarindo per creare un terrificante beverone): “In December, drinking horchata/I'd look psychotic in a balaclava/Winter's cold is too much to handle/Pincher crabs that pinch at your sandals”.
E pensare che c’è anche che li considera troppo intellettuali.
Sarà anche così. A me ricordano il Socrates della Fiorentina, quello che era talmente intelligente che nessuno dei compagni capiva quello che voleva fare.
Cousins e Holiday sembrano due cover degli Strokes eseguite da un’orchestrina a una festa dell’oratorio, spiazzano California English e Diplomate’s Son con la loro elettronica da cameretta e White Sky con il suo imbarazzante coretto tardo-adolescenziale, mentre Giving Up The Gun prova a mostrare inutilmente i muscoli.
Niente paura: i piu’ sembrano apprezzare quest’aura infantilista, questa presunta “ventata di freschezza”.
Tra i brani che si salvano, Run e soprattutto la conclusiva, rilassata, I Think UR A Contra, che – insieme all’altro pezzo lento del lotto, Taxi Cab - lascia intravvedere le reali potenzialità di questi ragazzi, se solo decidessero di crescere un po’.
Iscriviti a:
Post (Atom)